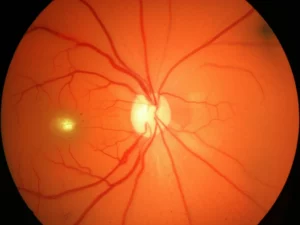Violenza nelle Coppie Giovani: Quando le Identità si Incrociano e Svelano Rischi Nascosti
Ciao a tutti! Oggi voglio parlarvi di un argomento tosto, ma super importante: la violenza nelle relazioni sentimentali (quella che gli esperti chiamano “Dating Violence” o DV) tra i giovani adulti, specialmente quelli che hanno avuto qualche guaio con la giustizia da ragazzi. È un tema che mi affascina e mi preoccupa allo stesso tempo, perché tocca corde profonde della nostra società e del modo in cui cresciamo e ci relazioniamo.
Immaginatevi quel periodo della vita, tra i 18 e i 25 anni, un’età pazzesca, piena di cambiamenti: si impara a vivere da soli, magari ci si sposta, si cerca la propria strada nel lavoro o nello studio, e si iniziano a costruire relazioni sentimentali più “adulte”. È un momento esaltante, ma anche stressante. E proprio in questo calderone di novità e pressioni, purtroppo, il rischio di incappare in relazioni violente, sia come vittime che come autori, può aumentare.
Ma la cosa che mi ha colpito leggendo uno studio recente è che questo rischio non è uguale per tutti. Sembra banale dirlo, ma le nostre identità – chi siamo, da dove veniamo, le esperienze che abbiamo vissuto – giocano un ruolo enorme. E spesso, la ricerca si è concentrata su gruppi specifici, tipo gli studenti universitari, lasciando un po’ in ombra chi l’università non la frequenta, magari perché lavora, ha già figli, o viene da contesti economici difficili. E che dire di chi ha avuto a che fare con il sistema giudiziario minorile (il JJS)? Questi ragazzi e ragazze partono spesso con un bagaglio più pesante di esperienze avverse, traumi, che possono renderli più vulnerabili.
Cos’è la Violenza nelle Relazioni Sentimentali (DV) e Perché Riguarda i Giovani Adulti?
Prima di addentrarci, capiamoci bene: quando parlo di DV, non intendo solo la violenza fisica (botte, spinte, minacce con oggetti), ma anche quella psicologica. Quest’ultima è subdola: manipolazione, umiliazioni, isolamento sociale, controllo costante. Entrambe le forme lasciano cicatrici profonde, aumentando il rischio di depressione, ansia, pensieri suicidi, abuso di sostanze.
Come dicevo, l’età dei giovani adulti (18-25 anni) è un periodo “sensibile”. Si stanno formando le relazioni adulte, si gestiscono nuove responsabilità e stress, e il cervello, in particolare il sistema di risposta allo stress, è ancora in fase di “rodaggio”. Questo mix può creare un terreno fertile per i conflitti e, nei casi peggiori, per la violenza. Lo studio che ho analizzato si è concentrato proprio su un gruppo di giovani adulti (circa 1100) che avevano avuto contatti con la giustizia minorile, un gruppo considerato ad alto rischio ma spesso trascurato dalla ricerca e dai programmi di prevenzione specifici per la DV.
Chi Rischia di Più? Uno Sguardo alle Identità Singole
La ricerca ha provato a capire quali “dimensioni dell’identità” fossero più legate al rischio di DV. E qui le cose si fanno interessanti, ma anche un po’ complesse. Vediamo cosa è emerso guardando i fattori uno per uno:
- Università sì/Università no: Chi non frequentava l’università sembrava avere tassi più alti di perpetrazione di violenza fisica e psicologica. Frequentare l’università, invece, potrebbe offrire fattori protettivi come maggior supporto sociale o programmi di prevenzione obbligatori. Ma attenzione: per la vittimizzazione, le differenze non erano così nette.
- Genere: Qui i dati sono spesso contrastanti in letteratura, ma in questo studio specifico, le donne riportavano livelli più alti sia di perpetrazione che di vittimizzazione per entrambe le forme di violenza (fisica e psicologica) rispetto agli uomini. Questo dato fa riflettere molto sulle dinamiche di potere, frustrazione e sulle possibili risposte alla violenza subita.
- Etnia/Razza: I giovani che si identificavano come Neri riportavano tassi più elevati per tutte e quattro le categorie (perpetrazione/vittimizzazione fisica/psicologica) rispetto ai Bianchi. Quelli che si identificavano come Ispanici, invece, mostravano meno vittimizzazione psicologica ma più perpetrazione fisica rispetto ai Bianchi. Queste differenze non sembrano dipendere solo dalla povertà, suggerendo il ruolo di discriminazioni sistemiche o fattori culturali specifici (anche se su questo bisogna essere cauti e servono più ricerche).
- Status Socioeconomico (SES): Sorprendentemente, in questo studio, un SES più alto (basato sull’istruzione dei genitori) era associato a tassi più alti di DV (tranne che per la vittimizzazione psicologica). Un risultato inatteso che va contro molte ricerche precedenti e merita approfondimento.

Questi risultati “singoli” ci danno già qualche indizio, ma la realtà è molto più intricata. Noi non siamo solo “donne” o “Neri” o “non universitari”. Siamo un mix complesso di tutte queste cose. E qui entra in gioco un concetto potentissimo: l’intersezionalità.
L’Intreccio che Fa la Differenza: L’Approccio Intersezionale (MAIHDA)
Pensateci: l’esperienza di una donna Nera di basso ceto sociale che non frequenta l’università sarà probabilmente molto diversa da quella di un uomo Bianco universitario di ceto medio. L’approccio intersezionale, nato dal pensiero femminista, ci dice proprio questo: le diverse forme di oppressione e privilegio (legate a genere, razza, classe, ecc.) non si sommano semplicemente, ma si intersecano, creando esperienze uniche.
Per studiare questo intreccio, i ricercatori hanno usato un metodo statistico avanzato chiamato MAIHDA (Multilevel Analysis of Individual Heterogeneity and Discriminatory Analyses). Non spaventatevi per il nome! In pratica, è come usare una lente d’ingrandimento speciale che permette di vedere come il rischio di DV cambia non solo in base a una singola identità, ma in base alle combinazioni uniche di diverse identità (es. donna + Nera + non universitaria + basso SES). L’obiettivo era capire se questo approccio ci desse informazioni in più rispetto a guardare i fattori separatamente. E la risposta è stata: sì.
Risultati Sorprendenti: Quando le Identità si Incrociano
L’analisi MAIHDA ha confermato che considerare l’intersezione delle identità è fondamentale per capire le disparità nella DV, specialmente per la violenza psicologica (sia perpetrata che subita) e la vittimizzazione fisica. Cosa significa? Che il rischio non è solo la somma delle parti, ma qualcosa di più complesso.
Ecco alcuni esempi emersi che mi hanno fatto riflettere:
- Donne Ispaniche Universitarie: Sorprendentemente, questo gruppo è risultato tra quelli a più alto rischio di vittimizzazione fisica. Questo è notevole perché, presi singolarmente, né l’identità Ispanica né la frequenza universitaria erano associate a un rischio così elevato di vittimizzazione nei modelli “semplici”. L’intersezione ha svelato una vulnerabilità nascosta.
- Donne Nere: Questo gruppo è emerso come particolarmente a rischio per diverse forme di DV, in particolare per la perpetrazione di violenza psicologica. Questo dato si allinea con altre ricerche e potrebbe riflettere meccanismi di difesa o risposte a oppressioni multiple e a una sfiducia verso le istituzioni (es. paura di denunciare).
- Intersezioni Razza/Etnia e SES: È emerso un pattern curioso: individui Bianchi con basso SES e individui Neri o Ispanici con alto SES sembravano avere tassi di rischio relativamente più alti per la perpetrazione fisica. Questo va un po’ contro l’idea “classica” dell’intersezionalità (dove chi somma più identità marginalizzate ha il rischio maggiore) e suggerisce che le dinamiche tra classe e razza/etnia nella DV sono complesse e meritano più studio. Forse entrano in gioco fattori come il razzismo sistemico nel sistema giudiziario (che colpisce diversamente) o lo stress legato al vivere in contesti prevalentemente Bianchi per persone di colore con SES più alto.

Questi risultati, anche se preliminari e basati su un gruppo specifico (giovani adulti con passato nel JJS), ci dicono che per capire davvero chi ha bisogno di aiuto e supporto, dobbiamo guardare oltre le etichette singole e considerare la complessità delle esperienze vissute all’incrocio di diverse identità.
Cosa Possiamo Imparare? Implicazioni per la Prevenzione
Allora, cosa ci portiamo a casa da tutto questo? Per me, il messaggio chiave è che la prevenzione della violenza nelle relazioni giovanili deve diventare molto più mirata e consapevole delle identità.
- Non solo universitari: C’è un bisogno enorme di programmi di prevenzione pensati specificamente per i giovani adulti che non frequentano l’università, dato il loro rischio elevato di perpetrazione. Questi programmi dovrebbero essere accessibili fuori dai campus, magari online o attraverso i servizi sociali e comunitari.
- Focus su gruppi specifici: I risultati evidenziano la necessità di interventi specifici per le donne Nere, che sembrano affrontare rischi particolari. Questi interventi dovrebbero essere sviluppati con loro (approccio “human-centered”), tenendo conto delle loro esperienze uniche, dei loro valori e delle barriere che possono incontrare (come la sfiducia nelle istituzioni). Bisogna creare risorse comunitarie che le facciano sentire sicure nel chiedere aiuto.
- Usare l’intersezionalità: L’approccio MAIHDA si è rivelato utile per scovare gruppi a rischio che altrimenti potrebbero sfuggire (come le donne Ispaniche universitarie). Questo suggerisce che le iniziative di salute pubblica e giustizia penale potrebbero usare strumenti simili per identificare più precisamente chi ha bisogno di supporto e personalizzare gli interventi.
- Capire il “perché”: Questo studio ci dice *chi* è più a rischio, ma non spiega completamente *perché*. Servono più ricerche per capire i meccanismi sottostanti: come interagiscono fattori come traumi passati, stress attuale, uso di sostanze, credenze culturali, esperienze di razzismo e discriminazione nel plasmare queste dinamiche violente all’interno delle diverse intersezioni identitarie.

Insomma, la lotta alla violenza nelle relazioni è complessa. Non basta dire “stop alla violenza”. Dobbiamo capire chi sono le persone più vulnerabili, tenendo conto di tutte le sfaccettature della loro identità, e creare interventi che siano davvero efficaci per loro, che parlino la loro lingua e rispondano ai loro bisogni specifici. È una sfida enorme, ma credo che studi come questo ci indichino la strada giusta da percorrere, una strada che guarda alla persona nella sua interezza e complessità.
Fonte: Springer