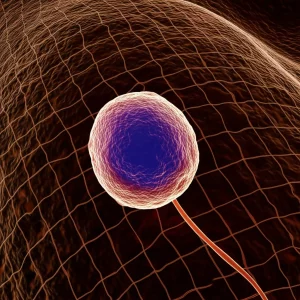Shock Settico e Vasopressina: Quando l’AVP Fa Davvero la Differenza?
Ragazzi, parliamoci chiaro: lo shock settico è un brutto cliente. È una delle principali cause di morte nelle nostre terapie intensive (ICU) e richiede un intervento rapido e deciso. Fluidi a manetta e farmaci vasopressori per cercare di riportare la pressione sanguigna a livelli decenti e garantire che gli organi ricevano abbastanza ossigeno. Nonostante i progressi, la mortalità rimane alta, tra il 30 e il 35%. Un numero che fa impressione.
Il Nostro Cavallo di Battaglia: La Norepinefrina (NE)
Il farmaco di prima scelta, il nostro “go-to”, è la norepinefrina (NE). Fa il suo lavoro nel ripristinare la pressione arteriosa media (MAP). Ma, come spesso accade in medicina, non è tutto oro quello che luccica. Molti pazienti sviluppano una sorta di resistenza, quello che chiamiamo shock refrattario alle catecolamine. E dosi elevate di NE non sono prive di rischi: possono causare aritmie o persino problemi al sistema immunitario. Insomma, a volte serve un “piano B”.
L’Alternativa: Arginina Vasopressina (AVP)
Qui entra in gioco l’arginina vasopressina (AVP). È un ormone che il nostro corpo produce naturalmente e che aiuta a stringere i vasi sanguigni e a trattenere acqua nei reni. Studi importanti come il VANISH e il VASST hanno suggerito che l’AVP può ridurre la dipendenza dalla NE, rendendola un’opzione preziosa nel nostro arsenale contro lo shock settico.
Le linee guida attuali (Surviving Sepsis Campaign 2021) ci dicono di pensare all’AVP quando le dosi di NE raggiungono un certo livello (tra 0.25 e 0.50 µg/kg/min). Ma, diciamocelo, basarsi solo su una soglia di NE potrebbe essere un po’ limitante. È plausibile che altri fattori specifici del paziente giochino un ruolo importante nel determinare se l’AVP funzionerà bene o meno. E fino ad ora, questi fattori non erano chiarissimi.
La Domanda Cruciale: Quando Aggiungere AVP?
Ecco perché è nato lo studio che voglio raccontarvi oggi. L’obiettivo primario era proprio questo: andare oltre la semplice dose di NE e identificare altre caratteristiche dei pazienti che potessero predire una buona risposta emodinamica all’AVP. Insomma, capire chi beneficia di più da questa “aggiunta” terapeutica.
Come Hanno Fatto? Uno Sguardo allo Studio
Si è trattato di uno studio osservazionale, prospettico e multicentrico. Hanno coinvolto pazienti adulti in terapia intensiva con diagnosi di shock settico secondo i criteri Sepsis-3, che non raggiungevano la pressione target nonostante i fluidi e con una dose di NE superiore a 0.25 µg/kg/min (equivalente base), e che quindi ricevevano AVP come secondo vasopressore. Hanno escluso pazienti con problemi specifici (ischemie acute, insufficienza renale cronica, ecc.) o con dati incompleti sulla NE.
La cosa interessante è come hanno definito la “risposta emodinamica all’AVP”: semplicemente osservando se, due ore dopo l’inizio dell’AVP, la velocità di infusione della NE si fosse stabilizzata o fosse diminuita. Un criterio pratico, che tiene conto della rapida azione dell’AVP e dell’obiettivo di ridurre il carico di catecolamine. Hanno anche guardato altri aspetti, come la durata totale dello shock e l’eventuale “ipotensione rebound” (un calo di pressione) quando si sospendeva l’AVP.

Tra maggio 2020 e ottobre 2023, hanno incluso 200 pazienti provenienti da 11 diverse terapie intensive (in Olanda, Italia e India). Un bel campione variegato.
I Risultati: Chi Risponde Meglio all’AVP?
E qui viene il bello! La notizia positiva è che ben 153 pazienti (il 79%) hanno soddisfatto i criteri di risposta emodinamica all’AVP. Un tasso di risposta piuttosto alto!
Ma quali fattori erano associati a questa risposta? L’analisi multivariata ha tirato fuori alcuni punti chiave:
- Obesità (BMI > 30 kg/m²): Sembra essere associata negativamente alla risposta. I pazienti obesi avevano meno probabilità di rispondere all’AVP (aOR 0.30).
- Iperlattatemia (alti livelli di lattato nel sangue): Anche questa era associata negativamente. Più alto il lattato, minore la probabilità di risposta (aOR 0.86 per ogni mmol/L in più).
- Dose di NE ≥ 0.30 µg/kg/min: Avere una dose di NE già un po’ più alta al momento di iniziare l’AVP era associato positivamente alla risposta (aOR 2.33). Questo suggerisce che l’AVP potrebbe essere particolarmente utile quando la resistenza alla NE inizia a farsi sentire di più.
Un altro dato interessante: l’incidenza di fibrillazione atriale di nuova insorgenza era significativamente più bassa nei pazienti che rispondevano all’AVP (4% vs 14% nei non-responder). Questo potrebbe essere legato alla riduzione del carico di NE, che come sappiamo può favorire le aritmie.
E la Durata dello Shock?
Lo studio ha anche cercato di capire cosa influenzasse la durata dello shock (cioè per quanto tempo i pazienti avessero bisogno di vasopressori dopo l’inizio dell’AVP). Nei pazienti sopravvissuti allo shock, i fattori associati a una durata maggiore erano:
- Un BMI più elevato.
- Una dose di NE più alta e una durata maggiore della terapia con NE prima di iniziare l’AVP.
- Un pH arterioso più basso al momento dell’inizio dell’AVP (indicativo di una maggiore acidosi metabolica).
Questo rinforza l’idea che iniziare prima l’AVP, specialmente in pazienti meno compromessi metabolicamente (pH più alto), potrebbe aiutare a risolvere lo shock più rapidamente.

Il Problema dell’Ipotensione Rebound
Una preoccupazione quando si usano farmaci come l’AVP è cosa succede quando li si sospende. Si può verificare un calo improvviso della pressione, la cosiddetta “ipotensione rebound”. In questo studio, è successa solo nel 9% dei pazienti sopravvissuti allo shock in cui si è potuta valutare, una percentuale relativamente bassa rispetto ad altri report. Curiosamente, l’unico fattore associato a un minor rischio di rebound è stato aver ricevuto AVP per più di 24 ore. Forse perché dopo un giorno il corpo ha avuto più tempo per stabilizzarsi o recuperare la propria produzione di vasopressina? È un’ipotesi. Non hanno trovato associazioni significative con la dose di NE al momento dello stop o con il fatto di aver ridotto gradualmente (tapering) l’AVP.
Cosa Ci Portiamo a Casa?
Questo studio, pur essendo osservazionale e con i suoi limiti (non hanno potuto controllare tutti i fattori confondenti come la sedazione, i fluidi pre-ICU, ecc.), ci dà degli spunti preziosi.
Primo, la risposta all’AVP è comune (quasi l’80% in questo studio!), e definirla come stabilizzazione o riduzione della NE sembra un approccio sensato e clinicamente rilevante.
Secondo, e forse più importante, non dobbiamo guardare solo la dose di NE per decidere se e quando usare l’AVP. Fattori come:
- Il peso del paziente (l’obesità sembra ridurre la risposta).
- Lo stato metabolico (alti livelli di lattato e basso pH sono segnali meno favorevoli).
- La dose di NE stessa (dosi >0.30 µg/kg/min sembrano indicare un maggior beneficio potenziale).
Questi elementi potrebbero aiutarci a personalizzare la terapia e a selezionare meglio i pazienti che trarranno maggior vantaggio dall’aggiunta di AVP.
L’associazione tra durata più lunga della NE prima dell’AVP e durata prolungata dello shock suggerisce, ancora una volta, che un uso precoce dell’AVP potrebbe essere vantaggioso, come già ipotizzato da altri studi.
Infine, l’ipotensione rebound sembra meno frequente di quanto temuto, specialmente se la terapia con AVP dura più di un giorno.
In Conclusione
L’AVP si conferma un’arma utile nel difficile combattimento contro lo shock settico refrattario alla norepinefrina. Questo studio prospettico ci aiuta a capire un po’ meglio *quando* quest’arma può essere più efficace, suggerendo di considerare un quadro più ampio del paziente, che includa BMI, lattato e pH, oltre alla dose di NE. Certo, servono ulteriori studi, magari randomizzati, per confermare questi risultati e definire strategie ottimali di timing e dosaggio. Ma è un passo avanti importante per ottimizzare la cura dei nostri pazienti più critici.
Fonte: Springer