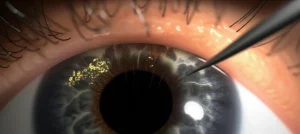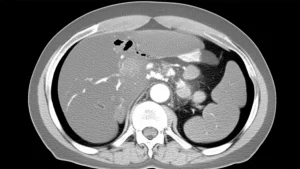DNA Sotto la Lente: Nuove Scoperte Genetiche nel Tumore della Lingua!
Ciao a tutti! Oggi voglio parlarvi di qualcosa che mi appassiona tantissimo: la genetica e come ci aiuta a svelare i misteri di malattie complesse come il cancro. Nello specifico, ci tufferemo nel mondo del carcinoma squamocellulare della lingua orale (OTSCC). Sembra un nome complicato, vero? Ma in parole povere, è un tipo di tumore che colpisce la parte mobile della lingua, quella che usiamo per parlare e gustare.
Perché è importante parlarne?
Beh, prima di tutto, il carcinoma squamocellulare orale (OSCC) rappresenta circa l’80% di tutti i tumori maligni della bocca, e la lingua è la sede più colpita, specialmente nei paesi sviluppati. Ma c’è un dato che ci fa drizzare le antenne: l’incidenza di questo tumore tra i giovani adulti (sotto i 45 anni) è in aumento in tutto il mondo, e non sappiamo ancora esattamente perché.
Certo, conosciamo i “soliti sospetti”: fumo e alcol sono i principali fattori di rischio. Ma ci sono anche altre abitudini, come masticare il betel quid (comune in alcune parti del mondo) o una dieta ricca di carni processate, che giocano un ruolo. A differenza di altri tumori della gola, quello della lingua è raramente legato all’infezione da HPV (Papilloma Virus Umano).
La cosa intrigante è che l’OTSCC può colpire anche persone senza nessuno di questi fattori di rischio noti. Questo ci suggerisce che la suscettibilità genetica e le interazioni tra geni e ambiente potrebbero avere un peso significativo, specialmente nei pazienti più giovani. Pensate, alcune varianti in geni legati al metabolismo dell’alcol, come ADH1B e ADH7, sono già state collegate a questa malattia.
La nostra caccia ai geni: lo studio GWAS
Finora, però, gli studi su larga scala che cercano associazioni tra varianti genetiche e questo specifico tipo di tumore sono stati pochi. Molti studi raggruppano diversi tumori della bocca e della faringe, ma noi crediamo sia fondamentale concentrarsi sull’OTSCC. Perché? Perché anche se vicini anatomicamente, i tumori in diverse parti della bocca possono avere cause, biologie e caratteristiche diverse. È come dire che tutti gli agrumi sono uguali, quando sappiamo bene che arance e limoni hanno le loro peculiarità!
Ecco perché abbiamo deciso di intraprendere uno studio specifico sull’OTSCC utilizzando un approccio potentissimo: il Genome-Wide Association Study (GWAS). Immaginate di avere una mappa dettagliatissima del DNA di migliaia di persone e di poterla confrontare per trovare piccole differenze (varianti genetiche) che compaiono più spesso in chi ha sviluppato una certa malattia rispetto a chi è sano. Questo è il GWAS: un’indagine su milioni di varianti genetiche per scovare quelle statisticamente associate a una condizione specifica.
Per il nostro studio, abbiamo avuto accesso ai dati straordinari del progetto FinnGen. Si tratta di un’iniziativa finlandese che combina i dati genomici di quasi mezzo milione di persone con le loro cartelle cliniche digitali. Un tesoro di informazioni! Abbiamo identificato 376 persone con diagnosi di OTSCC (escludendo tumori della base della lingua o delle tonsille linguali) e li abbiamo confrontati con oltre 400.000 persone senza storia di tumori, usate come gruppo di controllo. La maggior parte dei partecipanti era di origine europea (finlandese).

Le nostre scoperte: tre regioni del DNA sotto i riflettori!
Ebbene, cosa abbiamo trovato setacciando questo mare di dati genetici? Abbiamo identificato tre regioni specifiche del nostro genoma (chiamate loci) che mostrano un’associazione statisticamente significativa (con un valore p inferiore a 5 × 10⁻⁸, la soglia standard per questi studi) con un aumentato rischio di sviluppare l’OTSCC.
Vediamole più da vicino:
1. Locus su 5p15.33: Questa regione non è del tutto nuova nel mondo della ricerca sul cancro. La variante “principale” che abbiamo trovato qui (rs27067) si trova in una zona intergenica, cioè tra due geni: CLPTM1L e LINC01511. La cosa interessante è che nelle vicinanze (entro 1 milione di basi, che in termini genomici non è poi così tanto) ci sono geni già noti per essere coinvolti in vari tipi di cancro, come CLPTM1L stesso e il famosissimo TERT. CLPTM1L è legato alla resistenza a farmaci come il cisplatino e la sua sovraespressione è associata a una prognosi peggiore nel cancro orale. TERT è cruciale per il mantenimento dei telomeri (le “protezioni” finali dei nostri cromosomi) e la sua riattivazione è un evento comune in molti tumori, compresi quelli della testa e del collo. Studi recenti hanno mostrato che mutazioni nel promotore di TERT sono particolarmente frequenti proprio nell’OTSCC (quasi la metà dei casi!) e associate a una prognosi peggiore.
2. Locus su 10q24: Qui abbiamo trovato una variante (rs1007771191) vicino a un gene chiamato RPS3AP36 (uno pseudogene ribosomiale, la cui funzione è ancora poco chiara). Questa è una scoperta potenzialmente nuova per l’OTSCC! Nelle vicinanze ci sono altri geni interessanti legati al cancro, come SORBS1, ENTPD1 e PDLIM1. SORBS1 è coinvolto nell’adesione cellulare e nella migrazione, e il suo ruolo nel cancro sembra ambivalente (a volte soppressore, a volte promotore). ENTPD1 (noto anche come CD39) è una molecola chiave nel microambiente tumorale, che aiuta il tumore a “nascondersi” dal sistema immunitario producendo adenosina immunosoppressiva. Inibire CD39 è una strategia terapeutica promettente in fase di studio. PDLIM1 è coinvolto nell’organizzazione dello scheletro cellulare e nella regolazione di vie infiammatorie (come NF-κB) importanti per la progressione tumorale.
3. Locus su 20p12.3: Anche questa è una regione nuova associata all’OTSCC. La variante identificata (rs1438070080) si trova all’interno del gene PLCB1 (e vicino a PLCB4). Questi geni codificano per enzimi (Fosfolipasi C Beta) importanti nella segnalazione cellulare, in particolare nella regolazione del calcio intracellulare. PLCB1 è stato identificato come un gene che può guidare lo sviluppo di diversi tumori (colangiocarcinoma, mammella, fegato, stomaco) e la sua sovraespressione è spesso legata a stadi più avanzati e prognosi peggiore, facilitando la migrazione e l’invasione delle cellule tumorali. Anche PLCB4 è stato collegato a fenotipi aggressivi in alcuni tumori.
È interessante notare che le varianti trovate nei loci 10q24 e 20p12.3 sembrano essere più comuni nella popolazione finlandese rispetto ad altre popolazioni europee (un fenomeno chiamato “Finnish enrichment”). Questo sottolinea l’importanza di studiare popolazioni diverse per avere un quadro completo della genetica delle malattie.

Cosa significa tutto questo? E cosa ci riserva il futuro?
Identificare queste regioni genetiche è un passo avanti enorme! Ci dice che non stiamo cercando a caso. Questi loci contengono geni coinvolti in processi biologici fondamentali che sappiamo essere “dirottati” nel cancro: mantenimento dei telomeri, adesione e migrazione cellulare, evasione immunitaria, segnalazione intracellulare.
Abbiamo anche fatto un’analisi chiamata PheWAS (Phenome-wide association study) per vedere se la variante principale nel locus 5p15.33 (rs27067) fosse associata anche ad altre condizioni. Abbiamo trovato associazioni significative con il cancro alla prostata e la cheratosi seborroica (una condizione benigna della pelle), e un’associazione suggestiva (effetto co-direzionale) con il melanoma. Questo suggerisce che questa regione genomica potrebbe avere un ruolo più ampio nella suscettibilità a diverse condizioni.
Certo, come in ogni ricerca, ci sono delle limitazioni. Il nostro studio si è concentrato sulla popolazione finlandese, quindi i risultati potrebbero non essere direttamente generalizzabili a tutti. Inoltre, i GWAS identificano principalmente varianti comuni, potremmo aver perso varianti rare ma con un forte impatto. Non abbiamo potuto correlare i risultati con dati clinici specifici (come dimensioni del tumore o sopravvivenza) o tenere conto di tutti i possibili fattori ambientali.
Ma questo è solo l’inizio! I nostri risultati aprono nuove strade. Ora dobbiamo:
- Validare queste scoperte in altre popolazioni indipendenti.
- Capire quali specifici geni all’interno di questi loci sono i veri “colpevoli” e come esattamente contribuiscono allo sviluppo dell’OTSCC. Serviranno studi funzionali in laboratorio.
- Investigare se queste varianti sono specifiche per l’OTSCC o se sono condivise con altri tumori della testa e del collo.
- Confrontare il profilo genetico delle lesioni precancerose con quello dell’OTSCC per capire meglio la progressione della malattia.
Insomma, abbiamo aggiunto nuovi, importanti tasselli al complesso puzzle della genetica del tumore della lingua. Ogni scoperta come questa ci avvicina un po’ di più a comprendere meglio questa malattia, con la speranza, un giorno, di poterla prevenire o curare in modo più efficace. La ricerca continua!
Fonte: Springer