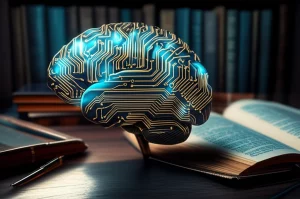Miniera di Rischi o Miniera di Opportunità? Decifriamo i Pericoli Nascosti nelle Aree Post-Minerarie
Ciao a tutti! Oggi voglio portarvi con me in un viaggio un po’ particolare, in quei luoghi che spesso dimentichiamo una volta che l’ultima pepita è stata estratta o l’ultimo pezzo di carbone ha visto la luce: le aree post-minerarie. Sapete, con la chiusura globale di tante miniere di carbone, c’è una spinta enorme a trasformare questi paesaggi, a volte feriti, in qualcosa di nuovo, di sostenibile. È quella che chiamiamo la “giusta transizione”, un modo per dire che dobbiamo bonificare queste zone pensando al futuro, alle comunità locali e all’ambiente. Ma c’è un “ma”, grosso come una montagna (a volte letteralmente!).
Queste aree, modellate da anni di attività estrattiva, sono un vero e proprio puzzle geologico e infrastrutturale, e questo le rende particolarmente vulnerabili a una serie di pericoli. E non parliamo di un pericolo alla volta, oh no! Spesso questi rischi si presentano in compagnia, uno dopo l’altro o tutti insieme, creando quello che noi addetti ai lavori chiamiamo un contesto multirischio (o multi-hazard, se preferite l’inglese). Immaginatevi un domino, dove una tessera che cade ne fa cadere altre: ecco, più o meno così.
Ecco perché nel mio campo di ricerca ci siamo chiesti: come possiamo analizzare in modo completo questa complessità? È fondamentale per garantire la sicurezza di chi vivrà o lavorerà in queste aree riconvertite. Così, ci siamo messi all’opera per confrontare alcune delle metodologie semi-quantitative più usate per l’analisi multirischio. Perché semi-quantitative? Perché spesso i dati super dettagliati scarseggiano, e questi metodi ci permettono di combinare il giudizio esperto con un po’ di sana analisi computazionale.
Quattro Metodi Sotto la Lente d’Ingrandimento
Abbiamo preso quattro “campioni” tra le metodologie semi-quantitative e li abbiamo messi alla prova su un’area post-mineraria reale, introducendo anche una valutazione innovativa di scenari multirischio. I protagonisti di questa comparazione sono stati:
- L’Analytic Hierarchy Process (AHP): un classico, molto diffuso e con una solida base teorica.
- L’Entropy Weight Method (EWM): più diretto da implementare, diciamo “pane al pane”.
- Il metodo del fattore di moltiplicazione parziale: questo qui entra più nel dettaglio dei principi del multirischio, cercando di cogliere le interazioni.
- Il metodo spaziotemporale: l’unico del gruppo che considera esplicitamente quanto spesso un pericolo può verificarsi nel tempo.
Vi anticipo subito una cosa: ognuno ha i suoi pro e i suoi contro. L’AHP è come quel professore un po’ rigido ma autorevole; l’EWM è più snello; il fattore di moltiplicazione parziale cerca di essere più preciso sulle interazioni; e il metodo spaziotemporale aggiunge la dimensione del tempo. Però, nessuno di questi, ahimè, riesce a tener conto della sequenza esatta con cui i pericoli si scatenano in uno scenario a catena. Un bel rompicapo, vero?
L’Eredità delle Miniere: Non Solo Carbone
L’impatto dell’estrazione del carbone su aria, acqua e suolo è una storia vecchia, ma sempre attuale. Pensate che oltre il 40% delle miniere di carbone europee ha chiuso i battenti negli ultimi anni in paesi come Germania, Polonia e Romania. E questo è un bene per la decarbonizzazione, certo, ma ci lascia con queste vaste aree da “guarire”. La bonifica efficace è la chiave per una transizione giusta verso la neutralità climatica, riutilizzando questi paesaggi per scopi che portino benefici a tutti.
Il problema è che queste ex-miniere hanno una morfologia complessa, infrastrutture abbandonate e attività residue che le rendono un bersaglio facile per molteplici pericoli. E non dimentichiamoci dei “regali” lasciati dall’attività estrattiva passata: pericoli che possono manifestarsi anche anni dopo la chiusura, come movimenti del terreno, incendi sotterranei, emissioni di gas. Questi pericoli “minerari” poi vanno a braccetto con quelli naturali (come terremoti o alluvioni) e quelli tecnologici (guasti a impianti residui), creando un cocktail esplosivo di condizioni multirischio che possono mandare all’aria i piani di bonifica.
Quando più pericoli coesistono e interagiscono, l’impatto complessivo è molto più alto rispetto alla somma dei singoli pericoli. Immaginate un terremoto (pericolo primario) che causa una frana (pericolo secondario), oppure un’alluvione che avviene contemporaneamente a un problema tecnologico. Capite bene che analizzare queste situazioni è un bel grattacapo, specialmente nelle aree post-minerarie dove la varietà di pericoli e di “beni” esposti (come nuove infrastrutture o ecosistemi ripristinati) è enorme.

La ricerca esistente si è concentrata molto sui pericoli naturali, ma noi abbiamo voluto allargare l’orizzonte, includendo le interazioni tra pericoli naturali, minerari e tecnologici. E sapete una cosa? C’è un vuoto notevole nella letteratura scientifica quando si parla di analisi multirischio specificamente per le aree post-minerarie. È un ambiente con sfide uniche!
Metodologie a Confronto: Qualitative, Semi-Quantitative e Quantitative
Per affrontare le interazioni tra pericoli e le condizioni multirischio, esistono tre grandi famiglie di metodologie:
- Qualitative: si basano sul giudizio esperto, usando strumenti come matrici di interazione, diagrammi, alberi decisionali. Usano scale di colori ed espressioni qualitative. Sono ottime per avere un quadro generale e visualizzare le interazioni.
- Semi-quantitative: qui entriamo nel nostro campo! Combinano il giudizio esperto con analisi computazionali per trasformare le interazioni in indicatori o pesi relativi, spesso usando software GIS per l’analisi spaziale. Sono flessibili e si adattano bene quando i dati scarseggiano.
- Quantitative: queste si affidano ad analisi numeriche e probabilistiche, come reti Bayesiane, funzioni Copula, probabilità condizionali e simulazioni Monte Carlo. Richiedono una marea di dati sulle interazioni, cosa spesso difficile da ottenere nelle aree post-minerarie.
La scelta del metodo dipende dagli obiettivi, dalle caratteristiche dell’analisi e dalla disponibilità di dati. Ecco perché le analisi comparative come la nostra sono così importanti: ci aiutano a capire quale metodo sia più accurato e appropriato per una data situazione. Il nostro lavoro è innovativo perché abbiamo adattato quattro metodi semi-quantitativi molto noti al contesto post-minerario, confrontandoli per capire come si comportano in queste condizioni complesse. Un aspetto cruciale che abbiamo sottolineato è quello degli scenari multirischio: catene di pericoli che si susseguono con sovrapposizioni spaziali e/o temporali. Costruire e valutare questi scenari è una vera sfida nelle aree post-minerarie.
Il Nostro “Laboratorio”: L’Area Post-Mineraria di Megalopolis
Per mettere alla prova i nostri quattro metodi, abbiamo scelto un caso di studio emblematico: l’area post-mineraria di Megalopolis, in Grecia. Storicamente, la Grecia è stata molto dipendente dalla lignite, e Megalopolis era uno dei cuori pulsanti di questa industria. Ora, con la chiusura progressiva delle centrali, la regione sta affrontando la transizione. L’area mineraria di Megalopolis è divisa in diversi bacini, e solo uno (Choremi) è ancora parzialmente operativo.
L’estrazione di lignite qui, specialmente nella miniera di Kyparissia, è stata complicata da condizioni idrogeologiche complesse, che hanno anche reso difficile la bonifica, portando a rischi come frane e inondazioni. Pensate che la deviazione del fiume Alfeios e il pompaggio continuo di acqua non sono bastati a evitare la formazione di due laghi di cava, poi unitisi in uno più grande. Questi laghi pongono problemi di gestione idrica a lungo termine. Nonostante ciò, sono stati fatti sforzi di riabilitazione, con rimboschimenti e sviluppo agricolo, e ci sono piani per creare altri laghi e installare impianti fotovoltaici.
In quest’area così dinamica, abbiamo identificato un gruppo di pericoli principali, basandoci sulla topografia e sulle attività post-minerarie:
- Pericoli Naturali: la regione ha un clima mediterraneo, con piogge intense in autunno e inverno che aumentano il rischio di inondazioni. Inoltre, la vicinanza all’Arco Ellenico la rende sismicamente attiva, quindi i terremoti sono una minaccia costante.
- Pericoli Minerari: i pendii ripidi e i gradoni di scavo rendono l’area soggetta a frane. Le inondazioni possono anche essere scatenate dall’innalzamento della falda acquifera dopo la chiusura della miniera o da frane che spostano grandi volumi di terra.
- Pericoli Tecnologici: guasti a infrastrutture di stoccaggio o condotte possono causare rilasci di gas o altri tipi di inquinamento.
Per la nostra analisi, ci siamo concentrati su: terremoti, piogge intense (che portano a inondazioni), frane, inondazioni (da altre cause) e rilasci di gas. Per ognuno, abbiamo assegnato un’intensità iniziale su una scala da 1 a 5, basandoci su dati storici e fonti nazionali. Ad esempio, i terremoti hanno un’intensità iniziale di 3, le piogge intense 3, le frane 4 (a causa della topografia vulnerabile), le inondazioni 3 e i rilasci di gas 2.

Gli Scenari Multirischio: Mettere alla Prova i Metodi
Con questi pericoli, abbiamo costruito sei scenari multirischio realistici, con un numero variabile di pericoli concatenati:
- Scenario 1: Pioggia (RF) → Frana (LA)
- Scenario 2: Terremoto (EQ) → Rilascio di Gas (RG)
- Scenario 3: Pioggia (RF) → Frana (LA) → Rilascio di Gas (RG)
- Scenario 4: Terremoto (EQ) → Frana (LA) → Inondazione (FL)
- Scenario 5: Pioggia (RF) → Inondazione (FL) → Frana (LA) → Rilascio di Gas (RG)
- Scenario 6: Terremoto (EQ) → Frana (LA) → Inondazione (FL) → Rilascio di Gas (RG)
L’obiettivo era calcolare e classificare questi scenari in base al loro Indice Multirischio (MHI), che ne quantifica l’intensità complessiva. Questo indice potrebbe poi servire come base per una valutazione del rischio multiplo, combinandolo con la vulnerabilità degli elementi esposti.
I Risultati: Luci e Ombre di Ogni Metodo
Analytic Hierarchy Process (AHP)
L’AHP ci chiede di confrontare a coppie i pericoli all’interno di ogni scenario, assegnando valori su una scala da 1/9 a 9 in base alla loro importanza relativa. Una limitazione è emersa subito: l’AHP non può valutare scenari con solo due pericoli (come i nostri scenari 1 e 2) a causa del calcolo del “Consistency Ratio” (CR), che richiede almeno tre elementi. Per gli altri scenari, abbiamo ottenuto valori di MHI compresi tra 1 e 4. Curiosamente, gli scenari 3 e 4 (con tre pericoli) hanno mostrato MHI più alti degli scenari 5 e 6 (con quattro pericoli). Lo scenario 4 (EQ → LA → FL) è risultato il più intenso. Un altro neo: l’ordine dei pericoli nello scenario non cambia il risultato finale dell’MHI, il che non è molto realistico, perché la sequenza conta eccome!
Entropy Weight Method (EWM)
L’EWM, a differenza dell’AHP, calcola i pesi dei criteri (i pericoli secondari) basandosi sull’entropia (una misura dell’incertezza). Anche qui, l’MHI variava tra 1 e 4. Gli scenari 1 e 4 sono risultati più “catastrofici” degli scenari 5 e 6, nonostante questi ultimi avessero più pericoli. Lo scenario 2 è stato il meno distruttivo, come ci si poteva aspettare. E, ahimè, anche con l’EWM, l’ordine dei pericoli nello scenario non ha influenzato l’MHI finale. Un punto a sfavore per la rappresentazione della realtà.
Metodo del Fattore di Moltiplicazione Parziale
Questo metodo si basa su una matrice di interazione che definisce probabilità di interazione (bassa o alta) tra pericoli primari e secondari. L’intensità iniziale dei pericoli secondari “innescati” viene amplificata. Qui, il confronto diretto degli MHI tra scenari con diverso numero di pericoli non è immediato, perché i valori non rientrano in un range fisso ma aumentano con il numero di pericoli. Abbiamo dovuto normalizzare i risultati (su una scala 0-1) per poterli confrontare. Lo scenario 4 è risultato il più intenso. Anche in questo caso, la sequenza dei pericoli non ha impattato l’MHI, essendo una semplice somma di valori. Il vantaggio è che assegna valori più alti a scenari con più pericoli, il che è più realistico, ma la necessità di normalizzazione è un limite.
Metodo Spaziotemporale
Questo metodo considera la frequenza temporale e la sovrapposizione spaziale dei pericoli. L’intensità iniziale di ogni pericolo (chiamata IHV) viene modificata da un fattore di moderazione (MF) legato alla sua frequenza. Una matrice di interazione assegna pesi che quantificano l’interazione spaziale. I risultati dell’MHI sono comparabili (range 1-5). Lo scenario 4 è risultato il più intenso, seguito a pari merito dallo scenario 6 (perché il rilascio di gas, avendo un IHV basso, non entrava nella matrice di interazione). Un aspetto interessante è che una modifica nell’ordine dei pericoli nello scenario 6 ha influenzato l’MHI, suggerendo che il metodo potrebbe, con qualche accorgimento, tener conto della sequenza, anche se nel nostro caso specifico la formula finale si basa su una somma di pesi.

Tiriamo le Somme: Un Confronto Metodologico
Confrontando i risultati, abbiamo notato una certa coerenza nella classificazione degli scenari, anche se con differenze. Lo scenario 4 (EQ → LA → FL) è quasi sempre tra i più critici, grazie ai suoi tre pericoli ad alta intensità con forti interazioni. L’EWM fa un po’ eccezione, non classificandolo come il più catastrofico a causa del modo in cui assegna pesi quasi uguali quando i valori nella matrice di confronto sono simili.
L’AHP ha il limite di non poter analizzare scenari con solo due pericoli e il suo indice di coerenza (CR) può essere restrittivo, specialmente con molti pericoli. Inoltre, tende a dare più peso ai pericoli iniziali della sequenza.
L’EWM è più flessibile ma, come detto, può assegnare pesi troppo simili, specialmente con molti pericoli, riducendo l’influenza di quelli dominanti. L’ampiezza della scala usata per i giudizi iniziali influenza criticamente i risultati.
Il metodo del fattore di moltiplicazione parziale è ben fondato sui principi del multirischio, ma la mancanza di normalizzazione dei risultati è un ostacolo. Inoltre, tende a sovrastimare l’MHI perché considera tutte le possibili interazioni della matrice, anche quelle non presenti in uno specifico scenario.
Il metodo spaziotemporale è l’unico a includere la frequenza, ma può essere limitato dalla scarsità di dati e potrebbe sottostimare la criticità di uno scenario se ci sono molti pericoli con intensità e frequenza simili ma non eccezionali.
Una cosa è chiara: nessuno dei metodi testati è perfetto per gestire la complessità di molti pericoli identificati contemporaneamente in aree post-minerarie. Tuttavia, possono essere utili in contesti più semplici, tenendo presenti i loro limiti. Il metodo del fattore di moltiplicazione parziale, ad esempio, ha un buon potenziale di miglioramento, magari introducendo un fattore che aggiusti l’intensità del pericolo in base alla sua frequenza e calcolando l’intensità aggiustata specificamente per ogni scenario. E, soprattutto, sarebbe fantastico poter incorporare un fattore che valuti la sequenza e l’influenza di ogni pericolo all’interno di uno scenario!
Cosa ci portiamo a casa?
Questo studio ci ha permesso di “dissezionare” quattro importanti metodi semi-quantitativi per l’analisi multirischio, applicandoli a un contesto sfidante come quello delle aree post-minerarie. Abbiamo visto che l’AHP e l’EWM forniscono classifiche coerenti, mentre il fattore di moltiplicazione parziale e il metodo spaziotemporale mostrano maggiore variabilità, evidenziando l’influenza delle interazioni e degli elementi temporali.
Il nostro obiettivo non era fare una valutazione completa del rischio per Megalopolis, ma piuttosto confrontare le prestazioni di questi metodi. E questo confronto è fondamentale non solo per capire le metodologie esistenti, ma anche per ispirare lo sviluppo di nuove tecniche che colmino le lacune identificate. Ogni metodo ha i suoi punti di forza e le sue debolezze, e la scelta dipende molto dal contesto specifico e dai dati disponibili.
In futuro, la ricerca dovrebbe mirare a integrare questi metodi in quadri di valutazione del multirischio più ampi, che includano anche analisi di vulnerabilità ed esposizione. Questo ci aiuterebbe a supportare meglio gli sforzi di bonifica e sostenibilità nelle aree post-minerarie, trasformandole da potenziali “miniere di rischi” a vere e proprie “miniere di opportunità” per le comunità e l’ambiente. E chissà, magari un giorno avremo metodi che tengano conto anche della sequenza dei pericoli in modo più efficace! La sfida è aperta.
Fonte: Springer