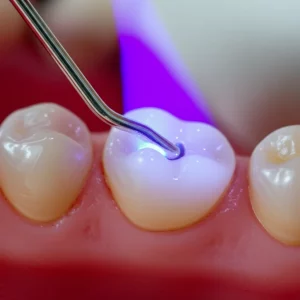Pietre che Sussurrano Segreti: Decifrare il Degrado delle Meraviglie di Helan Pass con la Scienza Fuzzy
Ciao a tutti, appassionati di storia, scienza e misteri scolpiti nella roccia! Oggi voglio portarvi con me in un viaggio affascinante, non in un luogo esotico qualsiasi, ma nel cuore di un problema che tocca il nostro patrimonio culturale: il degrado delle antiche reliquie in pietra. Nello specifico, voleremo (almeno con la fantasia) fino al Passo Helan, in Cina, un luogo magico custode di incredibili incisioni rupestri su arenaria, testimonianze silenziose di vite vissute migliaia di anni fa.
Il Nemico Silenzioso: Il Tempo e il Degrado
Avete mai pensato a come il tempo, con la sua azione lenta ma inesorabile, modella il mondo intorno a noi? Beh, sulle opere d’arte lasciate dai nostri antenati all’aperto, quest’azione si chiama degrado (o, per usare un termine più tecnico, weathering). Pioggia, vento, sbalzi di temperatura, cicli di gelo e disgelo, persino l’acqua che scorre… tutto contribuisce a erodere, crepare, sfaldare queste preziose testimonianze. Le reliquie in arenaria del Passo Helan, che raffigurano scene di caccia, rituali e vita quotidiana di 3000-10.000 anni fa, stanno soffrendo proprio questo destino. Sono lì, esposte agli elementi, e la loro superficie si sta lentamente deteriorando.
Il problema, amici miei, è che capire quanto siano effettivamente danneggiate queste rocce è un bel rompicapo. Certo, possiamo vedere crepe o pezzi che si staccano, ma come quantificare il danno in modo oggettivo? Fino ad oggi, mancavano standard chiari e le valutazioni erano spesso troppo soggettive. Immaginate due esperti che guardano la stessa roccia: uno potrebbe dire “è messa male”, l’altro “non è poi così grave”. Chi ha ragione? E soprattutto, come decidiamo dove intervenire prima e con quali metodi? C’è una linea sottile tra un livello di degrado e quello successivo, e l’occhio umano, da solo, fatica a tracciarla con precisione.
Una Lente d’Ingrandimento Scientifica: Entra in Scena il Fuzzy-AHP
Ma ecco che la scienza, come spesso accade, ci viene in aiuto con strumenti potenti e… un po’ “fuzzy”! No, non sto scherzando. Per affrontare questa sfida nel Passo Helan, un gruppo di ricercatori ha proposto un metodo innovativo chiamato fuzzy-AHP. Fermi tutti, non scappate! Sembra complicato, ma l’idea di base è geniale.
L’AHP (Analytic Hierarchy Process) è una tecnica che aiuta a prendere decisioni complesse scomponendo il problema in parti più piccole e gerarchiche (come un albero genealogico) e confrontandole a coppie per stabilirne l’importanza relativa. Immaginate di dover scegliere un’auto: confrontereste prezzo, consumi, sicurezza, ecc. L’AHP fa qualcosa di simile per il degrado, considerando fattori come le crepe, lo sfaldamento, i crolli e l’ambiente circostante.
E il “fuzzy”? Qui entra in gioco la logica fuzzy (o sfumata). La logica classica dice sì/no, vero/falso. La logica fuzzy, invece, accetta le sfumature, il “un po’ sì, un po’ no”, proprio come nella realtà. Il degrado non è quasi mai bianco o nero, ma una scala di grigi. La logica fuzzy permette di gestire questa incertezza e soggettività intrinseca, traducendo giudizi qualitativi (come “leggermente umido” o “sfaldamento a scaglie”) in numeri che possono essere elaborati matematicamente.
Combinando AHP e logica fuzzy, si ottiene un modello che considera tanti fattori diversi, pesa la loro importanza in modo strutturato (grazie all’AHP) e gestisce l’inevitabile “sfumatura” dei giudizi (grazie al fuzzy). Il risultato? Una valutazione quantitativa, molto meno soggettiva, del livello di degrado.

Indagine sul Campo: Cosa Succede Davvero a Helan Pass?
Per applicare questo metodo, i ricercatori hanno fatto un lavoro certosino. Hanno studiato l’ambiente del Passo Helan: un clima con forti escursioni termiche tra giorno e notte e tra estate e inverno, precipitazioni concentrate in pochi mesi ma capaci di mantenere umida la roccia a lungo, e una complessa idrochimica dell’acqua di sorgente che scorre nella zona, contribuendo alla dissoluzione chimica dei minerali.
Hanno analizzato la roccia stessa: un’arenaria quarzoso-feldspatica con calcite e minerali argillosi come cemento. Questa composizione la rende suscettibile a diversi tipi di attacco.
E poi, ovviamente, hanno osservato e misurato il degrado in situ su 20 diverse aree con reliquie, divise tra il versante sud e quello nord del passo (quest’ultimo risultato più degradato, probabilmente per le maggiori escursioni termiche e l’inclinazione degli strati rocciosi). Hanno identificato tre “colpevoli” principali:
- Crepe: Sia superficiali (da agenti atmosferici) che profonde (meccaniche, da stress strutturale o eventi esterni). Hanno misurato lunghezza, larghezza e densità. Alcune crepe meccaniche erano larghe quasi 4 centimetri!
- Esfoliazione (Sfaldamento): Il distacco di strati superficiali della roccia, paralleli alla parete. Può essere polverulento, granulare, a scaglie, scistoso o stratiforme. Hanno misurato spessore e area interessata. Lo sfaldamento a scaglie era il più comune.
- Crollo: La caduta di blocchi di roccia, un evento potenzialmente molto distruttivo. Qui hanno considerato l’inclinazione dei giunti rocciosi (che influenza la stabilità), la resistenza della roccia (misurata con uno strumento chiamato sclerometro) e, molto intelligentemente, hanno introdotto un nuovo parametro: la distanza dal crollo più vicino (DNC), per valutare la minaccia diretta alle incisioni.
Hanno raccolto una marea di dati: metri di crepe, millimetri di spessore dello sfaldamento, angoli di inclinazione, valori di rimbalzo dello sclerometro… un lavoro enorme!
Il Verdetto del Fuzzy-AHP: Una Classificazione Oggettiva
Con tutti questi dati e il modello fuzzy-AHP, è stato possibile calcolare un indice di degrado (chiamato WD, Weathering Degree) per ciascuna delle 20 reliquie studiate. Questo indice va da 0 (nessun degrado) a 1 (degrado massimo) ed è stato suddiviso in 5 livelli:
- 0 ≤ WD < 0.2 (Molto Basso)
- 0.2 ≤ WD < 0.4 (Basso)
- 0.4 ≤ WD < 0.6 (Medio)
- 0.6 ≤ WD < 0.8 (Alto)
- 0.8 ≤ WD ≤ 1 (Molto Alto)
E i risultati? Preparatevi, perché non sono proprio incoraggianti. Nessuna reliquia è risultata a degrado “molto basso” o “molto alto”, ma ben 12 su 20 (il 60%) sono state classificate a degrado medio, e 3 (il 15%) a degrado alto. In totale, il 75% delle reliquie studiate mostra un livello di degrado medio o alto! Questo conferma che la minaccia è seria e reale.

Il modello ha anche rivelato quali fattori pesano di più. Sapete qual è il fattore più influente sul degrado a Helan Pass? Il crollo (peso 0.433 su 1)! In particolare, l’inclinazione dei giunti rocciosi (peso 0.269) è risultata cruciale. Seguono, a pari merito, l’esfoliazione e l’ambiente (entrambi con peso 0.239), e infine le crepe (peso 0.089). All’interno dell’ambiente, le condizioni idrologiche (presenza di acqua) sono il secondo fattore singolo più importante (peso 0.180), mentre per l’esfoliazione, il tipo di sfaldamento (polverulento vs stratiforme, per esempio) è molto rilevante (peso 0.175). Anche la distanza dal crollo più vicino (DNC) ha un peso significativo (0.103).
Per essere sicuri della validità del metodo, i ricercatori lo hanno confrontato con un altro approccio (AHP-TOPSIS). I risultati erano simili, ma il fuzzy-AHP si è dimostrato più bravo a gestire i dati qualitativi (come il tipo di sfaldamento o le condizioni di umidità) e più coerente con le osservazioni sul campo in alcuni casi specifici.
Perché Tutto Questo è Importante?
Vi starete chiedendo: “Ok, interessante, ma a cosa serve tutto ciò?”. Serve, eccome! Questo studio non è solo un esercizio accademico. Fornisce, per la prima volta, una valutazione quantitativa e oggettiva dello stato di salute delle reliquie del Passo Helan. Questi numeri, queste classificazioni, sono fondamentali per chi si occupa della loro conservazione.
Ora sappiamo quali aree sono più a rischio (quelle con degrado alto e medio) e quali fattori sono più critici (il rischio crolli, l’acqua, certi tipi di sfaldamento). Questo permette di:
- Prioritizzare gli interventi: Concentrare le risorse limitate dove servono di più.
- Scegliere le strategie giuste: Se il problema principale è il crollo, le misure saranno diverse rispetto a dove domina lo sfaldamento superficiale.
- Monitorare nel tempo: Ripetendo queste analisi, si può vedere se il degrado sta accelerando e se le misure di protezione funzionano.

Inoltre, il metodo fuzzy-AHP sviluppato qui non è utile solo per Helan Pass. Ha il potenziale per essere applicato ad altri siti archeologici e monumenti in pietra in tutto il mondo, adattandolo ovviamente alle condizioni locali e ai tipi di roccia specifici. È uno strumento in più nella cassetta degli attrezzi per la salvaguardia del nostro immenso patrimonio culturale.
Insomma, la prossima volta che ammirerete un’antica incisione o una scultura esposta alle intemperie, pensate a tutto il lavoro scientifico che c’è dietro al tentativo di proteggerla. Pensate a come metodi come il fuzzy-AHP ci aiutano a “sentire” cosa ci stanno dicendo quelle pietre silenziose sul loro stato di salute, permettendoci di intervenire prima che sia troppo tardi. È una sfida continua, ma grazie alla scienza, abbiamo qualche arma in più per vincerla.
Fonte: Springer