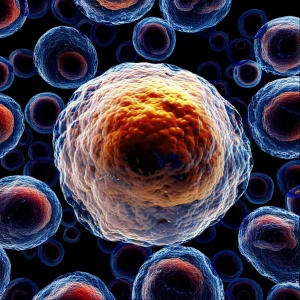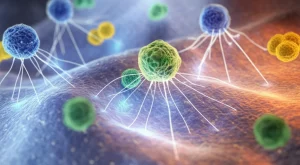Colloidi in Viaggio: Dal Lab al Campo, la Scala Conta Eccome! L’Importanza di un Esperimento Intermedio
Ciao a tutti! Oggi voglio parlarvi di un tema affascinante che tocca da vicino la salute pubblica e l’ambiente: come si muovono le particelle piccolissime, i cosiddetti colloidi, nelle nostre acque sotterranee? Pensate a batteri, microplastiche, o altri contaminanti emergenti. Capire il loro destino è fondamentale, ma c’è un grosso problema: quello che scopriamo in laboratorio, in piccole colonne di materiale poroso, spesso non corrisponde a quello che succede là fuori, nel mondo reale, su scale molto più grandi. È un bel rompicapo per chi si occupa di modellare il trasporto di queste sostanze nel sottosuolo.
Il Grande Dilemma della Scala: Laboratorio vs. Realtà
Immaginate di fare un esperimento in una colonnina di vetro riempita di sabbia o ghiaia nel vostro laboratorio. Misurate come un certo tipo di colloide viene trattenuto o si muove attraverso il materiale. Ottenete dei parametri, dei numeri che descrivono questo processo. Fantastico! Ma poi, dovete applicare questi numeri per prevedere cosa succederà in un acquifero reale, che magari si estende per chilometri. Funzionerà? Spesso, la risposta è no.
Questo perché il mondo reale è molto più complesso e, soprattutto, eterogeneo. Il sottosuolo non è un blocco uniforme di sabbia. Ci sono zone più permeabili dove l’acqua (e i colloidi) scorre più velocemente, creando dei veri e propri “percorsi preferenziali” (flusso preferenziale), e zone più “lente” o addirittura stagnanti. I modelli tradizionali, basati sul concetto di “volume elementare rappresentativo” (REV), faticano a catturare questa complessità. Si assume spesso un comportamento medio, ma la natura ama le eccezioni! E nel caso dei colloidi, questi percorsi preferenziali possono fare un’enorme differenza, permettendo loro di viaggiare molto più lontano e più velocemente di quanto ci aspetteremmo basandoci solo sugli esperimenti su piccola scala.
Un Ponte tra Laboratorio e Realtà: L’Esperimento sulla Grande Colonna
Ed è qui che entra in gioco la nostra ricerca. Ci siamo chiesti: come possiamo fare questo “salto di scala” (upscaling) in modo più affidabile? E se ci fosse un passo intermedio? Abbiamo pensato che un esperimento su una scala “meso”, più grande del classico esperimento da banco ma più controllata del campo aperto, potesse darci degli indizi preziosi.
Così, abbiamo realizzato qualcosa di piuttosto unico: una colonna di ghiaia indisturbata alta ben 4 metri! In pratica, abbiamo estratto due enormi “carote” di materiale direttamente da una cava, le abbiamo trasportate in laboratorio e le abbiamo unite, ricreando un pezzo di acquifero quasi “reale” ma in condizioni controllate. Un’impresa non da poco, vi assicuro! Dentro questa colonna gigante, abbiamo fatto scorrere acqua e abbiamo iniettato dei traccianti colloidali: spore del batterio Bacillus subtilis (un “sosia” innocuo di alcuni patogeni) e microsfere sintetiche di dimensioni simili (1 micrometro). Abbiamo monitorato come questi colloidi si muovevano e quanto venivano trattenuti lungo la colonna.

L’idea era confrontare i risultati ottenuti su questa scala intermedia con quelli già disponibili da esperimenti su piccole colonne (pochi decimetri) e da test reali in campo (decine di metri), usando materiali simili. Potevamo finalmente osservare il comportamento su tre ordini di grandezza di distanza diversi: 0.1 metri, 1 metro (la nostra colonna è 4m, ma abbiamo campionato a 3.6m, quindi circa 1 ordine di grandezza in più rispetto alle piccole colonne) e 10 metri (il test in campo era a 25m).
La Sorpresa: Non Esponenziale, ma una Legge di Potenza!
E qui arriva la parte più interessante. Tradizionalmente, si assume che la rimozione dei colloidi segua una legge esponenziale: più viaggiano, più ne vengono trattenuti, con un tasso di rimozione costante per unità di distanza (espresso spesso come log-removal per metro). Ma i nostri risultati, combinati con quelli precedenti, hanno mostrato un quadro diverso.
Abbiamo scoperto che la rimozione dei colloidi (sia in termini di log-removal che di tassi di attaccamento calcolati con i modelli) non diminuisce in modo esponenziale con la distanza, ma segue piuttosto una legge di potenza (power law). Cosa significa? In parole semplici, la rimozione è molto alta all’inizio, su brevi distanze (come nelle piccole colonne), ma poi diminuisce molto più lentamente man mano che la distanza aumenta. Se mettete i dati su un grafico con scale logaritmiche su entrambi gli assi (log-log plot), i punti si allineano lungo una retta: il marchio di fabbrica di una legge di potenza!
Pensateci: nelle piccole colonne da laboratorio, abbiamo misurato una rimozione media di circa 20 log/m per B. subtilis. Nella nostra colonna da 4 metri, la rimozione era scesa a circa 2 log/m. Nei test in campo, a 25 metri, era ulteriormente diminuita a circa 0.2 log/m. Vedete il pattern? Aumentando la scala di un fattore 10, la rimozione diminuisce di un fattore 10. È una relazione inversamente proporzionale che si manifesta come una legge di potenza. E questo valeva sia per le spore batteriche che per le microsfere!
Questo fenomeno era già stato osservato confrontando direttamente piccola scala e campo, ma il nostro esperimento sulla colonna “meso” ha fornito il tassello mancante, rafforzando l’ipotesi che questa legge di potenza sia una caratteristica intrinseca del trasporto in mezzi eterogenei.

Modellare la Complessità: Tentativi ed Errori
Abbiamo provato a modellare i nostri dati della colonna grande usando software standard come HYDRUS. Abbiamo usato un modello classico (flusso di equilibrio con un sito di attaccamento cinetico) e abbiamo visto che, per far tornare i conti, il tasso di attaccamento (Katt) doveva essere molto più basso rispetto a quello delle piccole colonne, confermando la dipendenza dalla scala.
Poi abbiamo fatto un tentativo interessante: abbiamo “barato” un po’ usando una funzione già esistente nel modello, pensata per descrivere lo “straining” (intrappolamento fisico in pori stretti) dipendente dalla profondità, ma l’abbiamo usata per mimare la nostra legge di potenza, anche se non pensavamo che lo straining fosse il meccanismo dominante nel nostro caso. L’idea era vedere se, introducendo una dipendenza dalla distanza nel tasso di attaccamento (facendolo diminuire con la profondità secondo una legge di potenza), potevamo far “assomigliare” di più il Katt della colonna grande a quello delle piccole colonne. E ha funzionato! Modificando un parametro (β) in questa funzione, siamo riusciti ad avvicinare i valori di Katt tra le due scale. Questo suggerisce che potremmo usare i dati da piccole colonne (più facili ed economiche da realizzare, magari con patogeni reali) e “scalarli” per modelli più grandi usando una funzione simile che tenga conto della diminuzione della rimozione con la distanza.
Abbiamo anche provato un modello a “doppia permeabilità”, che cerca esplicitamente di simulare zone a flusso veloce e lento. Sorprendentemente, questo approccio ha peggiorato le cose: ha aumentato la differenza tra i tassi di attaccamento della colonna grande e di quelle piccole. Forse perché i colloidi, a causa delle loro dimensioni, tendono a rimanere confinati nelle zone a flusso veloce, bypassando quelle lente, un comportamento che il modello a doppia permeabilità, pensato più per i soluti, non cattura perfettamente per i colloidi in questo contesto.

Perché Accade? Il Mistero dei Flussi Preferenziali
Ma qual è la causa fisica di questa legge di potenza? L’ipotesi più probabile è legata proprio all’eterogeneità e ai flussi preferenziali. In un materiale eterogeneo, i colloidi che riescono a evitare l’attaccamento iniziale o l’intrappolamento nei pori più piccoli, trovano rapidamente le “autostrade” del flusso. Una volta su queste corsie preferenziali, viaggiano veloci, con meno probabilità di interagire con le superfici dei grani e quindi di essere rimossi. Più viaggiano, più è probabile che siano proprio quelli che hanno trovato le vie più dirette e veloci.
Usando l’analogia del traffico citata nel testo originale: gran parte dei colloidi si perde nelle “stradine secondarie” (zone a bassa permeabilità, pori piccoli) vicino al punto di iniezione, magari rimanendo intrappolati in vicoli ciechi. Una piccola frazione, però, imbocca l'”autostrada” (percorsi ad alta permeabilità). Questi “fortunati” viaggiano veloci, magari restano nella corsia centrale e mancano le uscite (interazioni con le superfici). Ecco perché la rimozione diminuisce drasticamente con la distanza: quelli che arrivano lontano sono i “sopravvissuti” che hanno percorso le vie più efficienti. Questo effetto diventa dominante su scale più grandi, mentre è meno evidente nelle piccole colonne omogeneizzate o su brevi distanze.
Altre teorie parlano di fenomeni di auto-organizzazione del flusso o di principi termodinamici legati all’entropia, ma l’idea centrale resta quella di percorsi non uniformi che diventano sempre più importanti man mano che la scala aumenta.
Cosa Significa per il Futuro? Implicazioni Pratiche
Questa scoperta ha implicazioni importanti. Se i tassi di rimozione non sono costanti ma diminuiscono con la distanza secondo una legge di potenza, allora i metodi tradizionali per calcolare le fasce di rispetto attorno ai pozzi di acqua potabile, che spesso assumono rimozione costante, potrebbero essere non sufficientemente protettivi, specialmente in acquiferi eterogenei.
Pensiamo ai contaminanti emergenti come le microplastiche o le lunghe catene di PFAS (che possono comportarsi come colloidi). Se questi contaminanti trovano percorsi preferenziali, possono viaggiare molto più lontano di quanto previsto dai modelli classici. E con i cambiamenti climatici che portano eventi estremi come le alluvioni improvvise, il rischio che grandi quantità d’acqua spingano rapidamente questi contaminanti nelle falde acquifere attraverso vie preferenziali aumenta.
Il nostro lavoro, grazie all’esperimento sulla colonna “meso”, suggerisce che dobbiamo ripensare il modo in cui studiamo e modelliamo il trasporto nel sottosuolo. Dobbiamo:
- Riconoscere che la scala di misurazione influenza i parametri che otteniamo.
- Incorporare la natura non lineare (legge di potenza) della rimozione nei nostri modelli, specialmente per acquiferi eterogenei.
- Sviluppare forse nuovi approcci di modellazione che catturino meglio i flussi preferenziali, magari usando modelli di rete di pori su larga scala, approcci probabilistici o basati sui tempi di viaggio, forse aiutati dall’intelligenza artificiale.
L’esperimento sulla grande colonna si è rivelato un passo intermedio cruciale, un ponte che ci ha aiutato a capire meglio come collegare il piccolo mondo controllato del laboratorio con la vasta e complessa realtà del sottosuolo. La strada è ancora lunga, ma capire queste dinamiche di trasporto legate alla scala è fondamentale per proteggere le nostre preziose risorse idriche.
Fonte: Springer