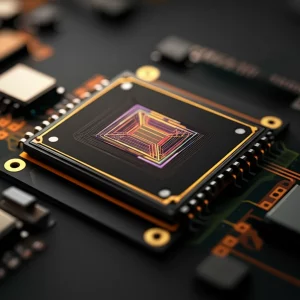Turbolenza: Conservare l’Energia è Davvero la Strada Giusta? Un Viaggio tra Dissipazione Anomala e Metodi FEM
Ciao a tutti! Oggi voglio parlarvi di un argomento che mi appassiona da tempo e che, secondo me, è al cuore di una delle sfide più grandi nella fluidodinamica computazionale (CFD): la simulazione dei flussi turbolenti. C’è un dibattito interessante nella comunità scientifica: quando simuliamo questi flussi complessi, dovremmo usare metodi numerici che conservano l’energia cinetica in modo perfetto, oppure metodi che introducono una certa dissipazione?
Il Dilemma: Conservazione vs. Dissipazione
Molti sanno che una discretizzazione numerica “sbagliata” dei termini di trasporto non lineari può far accumulare energia cinetica artificiale e mandare in tilt la simulazione. Questo è un bel problema, specialmente con la turbolenza. La comunità sembra divisa: c’è chi punta su schemi che conservano l’energia in modo discreto e chi preferisce schemi dissipativi.
La logica dietro gli schemi conservativi si basa spesso sull’aspettativa che, nel limite inviscoso (cioè senza viscosità molecolare, come descritto dalle equazioni di Eulero), l’energia cinetica debba conservarsi esattamente. Matematicamente, però, questo richiede che la soluzione sia “regolare”, cioè sufficientemente liscia, senza comportamenti strani.
Ma qui casca l’asino! C’è un’osservazione fenomenologica fondamentale nella turbolenza, quasi una legge non scritta (la “legge zero della turbolenza”): i flussi dissipano energia anche quando la viscosità molecolare diventa trascurabile. Questo fenomeno “anomalo” è chiamato dissipazione anomala. Già il grande Lars Onsager, nel lontano 1949, aveva ipotizzato che le equazioni di Eulero potessero dissipare energia cinetica attraverso la formazione di singolarità nel campo di velocità.
La Conferma di Onsager e le Implicazioni per la CFD
Negli ultimi anni, la congettura di Onsager è stata dimostrata matematicamente. Questo è un risultato pazzesco! Cosa significa per noi che sviluppiamo metodi numerici? Significa che l’ipotesi di regolarità, necessaria per la conservazione dell’energia nel limite inviscoso, è proprio critica per i flussi turbolenti. Anzi, dobbiamo aspettarci che il campo di velocità mostri comportamenti singolari man mano che ci avviciniamo al limite inviscoso, e questo supporta la dissipazione di energia cinetica.
Il mio argomento principale, quindi, è questo: progettare metodi numerici tenendo conto di questo comportamento fisico è una motivazione fortissima per costruire schemi numerici dissipativi (o consapevoli della dissipazione) per i termini convettivi. Vista così, la dissipazione numerica non appare più come un artefatto artificiale, ma come un ingrediente importante per superare i problemi introdotti dai metodi conservativi. Quali problemi? Ad esempio, l’incapacità di rappresentare la dissipazione anomala e l’accumulo di energia nelle piccole scale, un fenomeno noto come termalizzazione (un po’ come se l’energia si distribuisse uniformemente a caso, perdendo la struttura fisica).
In questo articolo, discuteremo i metodi agli elementi finiti (FEM) stabilizzati (H^1), (L^2), e (H(mathrm{div}))-conformi per flussi incomprimibili, concentrandoci sulla stabilità energetica del metodo numerico e sui suoi meccanismi di dissipazione per predire la dissipazione inerziale. Infine, daremo un’occhiata alla velocità di convergenza che possiamo realisticamente aspettarci per l’energia cinetica nelle simulazioni di flussi turbolenti sotto-risolte.

Singolarità Turbolente: Non Solo Shock
I progressi matematici recenti sulla dissipazione anomala e le singolarità di Eulero sono fondamentali. Sembra che questi risultati non siano ancora penetrati a fondo nella letteratura più orientata alla simulazione numerica e alla Large-Eddy Simulation (LES). I risultati matematici suggeriscono che le equazioni di Eulero non conservano l’energia di per sé, ma è la regolarità della soluzione la chiave per capire se c’è dissipazione nel limite inviscoso.
Un messaggio importante per chi sviluppa schemi numerici: le ipotesi sulla regolarità della soluzione non sono questioni accademiche quando si parla di turbolenza. Dobbiamo aspettarci che i flussi turbolenti abbiano una regolarità critica rispetto alla dissipazione anomala, implicando comportamenti singolari. Nella CFD, siamo familiari con le singolarità sotto forma di shock nei flussi ipersonici (regime comprimibile). Tuttavia, anche i flussi incomprimibili nel limite inviscoso (equazioni di Eulero) possono presentare singolarità. Chiamiamole singolarità turbolente per distinguerle dalle singolarità di shock. Mentre le seconde sono caratterizzate da discontinuità forti (salti), le prime sono più “deboli”: hanno un grado di regolarità maggiore, ma abbastanza forte da causare dissipazione. Secondo Onsager, le singolarità turbolente sono caratterizzate da un campo di velocità continuo ma con gradiente infinito.
Large-Eddy Simulation (LES): Filosofie a Confronto
La LES implicita è una tecnica consolidata per simulare flussi turbolenti in modo sotto-risolto. “Implicita” significa che è il metodo numerico stesso a fornire la dissipazione necessaria, invece di aggiungere modelli di turbolenza fisici (che agiscono come “pozzi” di energia). Metodi come l’approccio MILES nei volumi finiti o i metodi stabilizzati/multiscala variazionali negli elementi finiti sono ben noti.
Una motivazione chiave di questo lavoro è collegare le tecniche LES implicite con la dissipazione anomala, il comportamento singolare e le nuove intuizioni matematiche sulla congettura di Onsager. Contributi importanti e precoci in questo campo, altrimenti poco considerato, sono quelli di Hoffman e Johnson (2008, 2010), una prospettiva che discuteremo più avanti.
Certo, la comunità LES ha interiorizzato il fenomeno della dissipazione anomala, nel senso che c’è bisogno di rappresentare/modellare la dissipazione nelle simulazioni LES. Allo stesso tempo, sembra esserci divisione sulla questione se un metodo numerico debba essere in grado di rappresentare il backscatter (trasferimento di energia dalle piccole alle grandi scale) o se questo sia essenzialmente dannoso a causa del suo potenziale comportamento destabilizzante.
Riguardo al comportamento singolare, esistono ancora idee un po’ “misteriose” sulle singolarità a tempo finito. In particolare, il legame tra dissipazione e comportamento singolare appare sfocato. È ancora diffusa l’idea che le soluzioni delle equazioni di Eulero debbano conservare l’energia cinetica e rimanere lisce. L’immaginazione delle singolarità a tempo finito come un evento catastrofico (spesso chiamato blow-up) che implica inevitabilmente il fallimento del metodo numerico non è rara.

Sembra che il quadro attuale nella letteratura contenga ulteriori contraddizioni. Ad esempio, lavori sul metodo multiscala variazionale per LES si aspettano un comportamento teorico di conservazione dell’energia per il termine convettivo, mentre la necessità di termini di stabilizzazione è vista più come una peculiarità delle discretizzazioni Galerkin continue piuttosto che una conseguenza del comportamento fisico legato alla dinamica inerziale dei flussi turbolenti. Spesso, la metrica della stabilità energetica e della dissipazione sembra sottorappresentata nella discussione dei metodi LES impliciti rispetto agli aspetti multiscala. Metodi numerici discretamente conservativi vengono spesso progettati senza consapevolezza del fenomeno della dissipazione anomala.
L’obiettivo di questo articolo è fare luce su queste contraddizioni e aggiungere un’altra prospettiva alla discussione, con un focus principale sulla metrica della stabilità energetica (contrapposta alla conservazione dell’energia).
Cosa Rende un Metodo “Compatibile con la Fisica”?
Recentemente si parla molto di metodi numerici “compatibili con la fisica” o “che preservano la struttura”. Spesso, ho notato che questi termini sono usati come sinonimi di schemi numerici che conservano discretamente l’energia/entropia (tipicamente realizzati con formulazioni cosiddette skew-simmetriche).
Ma cosa intendiamo noi per metodi compatibili con la fisica o che preservano la struttura per la turbolenza tridimensionale? Secondo me, un metodo numerico compatibile con la fisica per flussi turbolenti incomprimibili dovrebbe:
- Conservare la massa.
- Soddisfare una disuguaglianza di dissipazione dell’energia (piuttosto che una stretta proprietà di conservazione).
Credo che meccanismi di dissipazione numerica intrinseci siano desiderabili per la compatibilità con dinamiche iperboliche irreversibili o dissipative. Al contrario, uno schema che soddisfa una proprietà di conservazione discreta dell’energia non è di per sé compatibile con la fisica della dissipazione inerziale dell’energia. Per rafforzare l’aspetto dell’irreversibilità o della dissipazione, penso che un metodo numerico che soddisfa una disuguaglianza di dissipazione dell’energia (con la possibilità di dissipare) sia descritto meglio dalla nozione di compatibile con la fisica (o, alternativamente, consapevole della dissipazione) piuttosto che “che preserva la struttura”.
Alla Ricerca delle Singolarità nelle Simulazioni
Identificare singolarità a tempo finito nelle simulazioni di Eulero ha una lunga storia. I metodi principali includono il criterio di blow-up della vorticità (teorema di Beale-Kato-Majda) e il metodo della striscia di analiticità. Lavori recenti hanno riportato evidenze numeriche e persino prove matematiche di singolarità a tempo finito.
Qui voglio concentrarmi sulle tecniche che sfruttano la connessione tra comportamento singolare e dissipazione anomala secondo la congettura di Onsager. Prime idee in questa direzione sono state formulate da Hoffman e Johnson (2008) con il “criterio di blow-up globale”. Similmente, è stato proposto un “approccio indiretto” per la rilevazione di singolarità dissipative (Fehn et al. 2022), che sfrutta proprio questa connessione. Dimostrando la convergenza verso una soluzione di Eulero dissipativa, si ottiene un’evidenza indiretta di una singolarità dissipativa.
Voglio sottolineare una cosa: un blow-up numerico di uno schema non robusto non indica un blow-up fisico. Al contrario, considero la robustezza numerica un prerequisito per la rilevazione del blow-up fisico. I metodi numerici per termini iperbolici che descrivono flussi inviscidi (così come flussi ad alto Re sotto-risolti) dovrebbero essere in grado di gestire comportamenti singolari senza andare in crash.

Metodi agli Elementi Finiti Stabilizzati per la LES Implicita
Adottiamo la prospettiva che il metodo numerico stesso debba essere compatibile con la fisica, nel senso di poter rappresentare/predire la dissipazione inerziale attraverso meccanismi di dissipazione numerica intrinseci. Rispetto ai modelli LES fisici, una motivazione principale per incorporare la dissipazione direttamente nella discretizzazione (LES implicita) è ottenere un filtro più accurato, con il limite di risoluzione numerica il più vicino possibile al numero d’onda di Nyquist.
Consideriamo qui metodi Galerkin (dis)continui (potenzialmente di alto ordine polinomiale) con meccanismi intrinseci di dissipazione numerica (tipicamente chiamati stabilizzazione nei metodi variazionali). Per qualificarsi come LES implicita, le strutture su piccola scala vicine al limite di risoluzione, che non possono essere trasportate accuratamente su una data griglia, devono essere smorzate da meccanismi dissipativi. Questi meccanismi dovrebbero attivarsi solo se viene rilevata localmente una soluzione numerica non liscia. I residui delle equazioni di Navier-Stokes/Eulero servono tipicamente come indicatori di non-liscezza. Termini opportuni nella formulazione debole basati su questi residui (ad esempio, termini simmetrici rispetto alle funzioni test e soluzione, che appaiono come termini quadratici nell’equazione di dissipazione dell’energia) agiscono come meccanismi di dissipazione.
Questo approccio dovrebbe permettere di trovare soluzioni deboli dissipative appropriate per le equazioni di Eulero. Uno schema numerico con uno spazio funzionale a dimensione finita per la velocità, dotato di meccanismi di dissipazione adeguati che assicurano che l’energia cinetica rimanga limitata, produce una soluzione con gradienti di velocità finiti. Quindi, la tecnica complessiva può essere vista come una regolarizzazione delle equazioni di Eulero senza coinvolgere una forma esplicita di filtraggio/coarse-graining o un modello di turbolenza fisico.
Secondo studi numerici (Hoffman et al. 2011; Fehn et al. 2022), i metodi Galerkin (dis)continui stabilizzati potrebbero essere candidati adatti per predire numericamente il fenomeno della dissipazione anomala e, quindi, qualificarsi come metodi numerici compatibili con la fisica.
Panoramica dei Metodi FEM Stabilizzati
Esistono diverse “famiglie” di metodi FEM per flussi incomprimibili, che si differenziano principalmente per lo spazio funzionale scelto per la velocità:
- (H^1)-conformi: Metodi Galerkin continui classici. La velocità è continua attraverso i bordi degli elementi.
- (L^2)-conformi: Metodi Galerkin discontinui. La velocità può essere discontinua ai bordi degli elementi.
- (H(mathrm{div}))-conformi: Un ibrido. La componente normale della velocità è continua, ma quella tangenziale può essere discontinua. Questo spazio è particolarmente interessante per i flussi incomprimibili perché permette di costruire metodi con un campo di velocità esattamente privo di divergenza.
Un aspetto fondamentale è la scelta della coppia di spazi velocità/pressione per garantire la stabilità inf-sup (evitare modi di pressione spuri) e la conservazione della massa. Spesso si usano polinomi di grado misto (p per la velocità, p-1 per la pressione), ma questo di solito non garantisce una conservazione esatta della massa, richiedendo termini di stabilizzazione aggiuntivi. Vedremo come i metodi (H(mathrm{div}))-conformi offrano una soluzione elegante a entrambi i problemi.
Stabilizzazione per Metodi (H^1)-Conformi (Galerkin Continuo)
Le formulazioni deboli standard del termine non lineare convettivo non portano a uno schema energeticamente stabile in (H^1). Questo perché il termine è non lineare e il campo di velocità discreto non è generalmente a divergenza nulla punto per punto. Si può dimostrare che sia la forma convettiva che quella divergente del termine non lineare possono produrre energia artificiale.
Una soluzione classica è usare la formulazione skew-simmetrica, una media delle due forme, che garantisce la conservazione discreta dell’energia per il termine convettivo. Sebbene attraente per la robustezza, come detto prima, questa proprietà non è adatta a descrivere l’accuratezza in presenza di dissipazione anomala, a meno che non si aggiungano altri meccanismi dissipativi.
Ecco perché entrano in gioco le tecniche di stabilizzazione variazionale. Queste aggiungono termini alla formulazione debole che dipendono dai residui delle equazioni. Esempi famosi includono:
- SUPG/PSPG (Streamline-Upwind/Pressure-Stabilizing Petrov-Galerkin): Stabilizzazione basata sui residui per migliorare il comportamento in regime dominato dalla convezione e per aggirare problemi di stabilità inf-sup.
- Grad-Div Stabilization: Aggiunge un termine che penalizza la divergenza della velocità, migliorando la conservazione della massa.
- GLS (Galerkin Least Squares): Una formulazione più generale che include le precedenti.
- VMS (Variational Multiscale Methods) / OSS (Orthogonal Subscales): Interpretano la stabilizzazione come una modellazione delle scale sotto-griglia non risolte.
Questi termini di stabilizzazione, se progettati correttamente (ad esempio, in modo simmetrico), agiscono come meccanismi di dissipazione numerica, fornendo la stabilità energetica necessaria e modellando implicitamente la dissipazione turbolenta. C’è però un trade-off: alcune formulazioni perfettamente stabili energeticamente possono compromettere la consistenza del metodo (cioè quanto bene approssima le equazioni originali), limitando l’accuratezza per soluzioni lisce.

Stabilizzazione per Metodi (L^2)-Conformi (Galerkin Discontinuo)
I metodi DG permettono discontinuità tra gli elementi, gestite tramite flussi numerici sulle facce. Per il termine convettivo, si usano spesso flussi tipo Lax-Friedrichs o upwind, che introducono naturalmente dissipazione. Anche il termine viscoso richiede una gestione speciale (es. metodo Symmetric Interior Penalty – SIPG).
Tuttavia, per flussi incomprimibili, solo i flussi non bastano. Servono termini di stabilizzazione aggiuntivi per:
- Penalizzare la divergenza intra-elemento: Simile al grad-div in (H^1).
- Penalizzare il salto della componente normale della velocità tra elementi: Forzando debolmente la continuità normale.
Questi termini sono cruciali per la robustezza nelle simulazioni turbolente sotto-risolte. Anche qui, la progettazione mira a ottenere consistenza (i termini si annullano per la soluzione esatta) e dissipazione per la stabilità. La prova formale di stabilità energetica per parametri di stabilizzazione finiti è spesso complessa o ancora aperta. Questi termini possono essere visti come un modo per “mimare” le proprietà dello spazio (H(mathrm{div})), forzando debolmente la conservazione della massa e la continuità normale.
Metodi (H(mathrm{div}))-Conformi: Eleganza Matematica
Questi metodi usano spazi funzionali speciali (es. Raviart-Thomas) che garantiscono ( nabla cdot varvec{u}_h equiv 0 ) punto per punto, se accoppiati con lo spazio di pressione giusto (es. polinomi discontinui). Questo è fantastico! Significa che:
- La conservazione della massa è soddisfatta esattamente.
- Non servono termini di stabilizzazione tipo grad-div o penalità sulla divergenza.
- La stabilità inf-sup è spesso garantita dalla costruzione.
La dissipazione necessaria per la stabilità energetica deriva unicamente dal flusso numerico usato per il termine convettivo (es. upwind) che agisce sui salti (ora solo tangenziali) della velocità alle interfacce. Il metodo è provabilmente energeticamente stabile nel limite inviscoso. Non ci sono parametri di stabilizzazione (tau) da scegliere, il che è un vantaggio. Resta aperta la questione se la sola dissipazione di superficie sia sufficiente, specialmente per gradi polinomiali molto alti, dove il metodo si avvicina a uno spettrale.
Altre Tecniche: Gradient Jump Penalty (GJP)
Un altro approccio alla stabilizzazione, applicabile a tutte le famiglie di metodi ( (H^1, L^2, H(mathrm{div})) ), è penalizzare i salti del gradiente della velocità (e/o della pressione) attraverso le facce degli elementi. Questo forza debolmente una maggiore regolarità ((C^1)) della soluzione. Se formulato simmetricamente, questo termine agisce come un meccanismo dissipativo. Sembra un approccio generico e promettente, ma le sue implicazioni pratiche (robustezza, accuratezza, interazione con altre stabilizzazioni) sono ancora oggetto di ricerca.
Un Esempio Pratico: Il Vortice di Taylor-Green Inviscoso
Abbiamo simulato il problema del vortice di Taylor-Green tridimensionale nel limite inviscoso usando un metodo (L^2)-conforme stabilizzato (Fehn et al. 2022). Abbiamo eseguito uno studio di convergenza raffinando la mesh da (8^3) a (8192^3) gradi di libertà per componente di velocità, con grado polinomiale fisso (p=3).
I risultati sono stati notevoli: abbiamo ottenuto soluzioni numeriche stabili in tutti i casi, e la cosa più interessante è che l’evoluzione temporale dell’energia cinetica e del suo tasso di dissipazione sembrano convergere, al raffinarsi della griglia, verso una soluzione con un tasso di dissipazione non nullo. Questo supporta l’idea della dissipazione anomala! Questi risultati sono nuovi rispetto a studi precedenti che riportavano blow-up numerici o che preferivano soluzioni numeriche esattamente conservative per questo problema ad alto numero di Reynolds. L’analisi degli errori relativi mostra una chiara tendenza alla convergenza, anche se piuttosto lenta (ordine < 1). E tutto questo è ottenuto con meccanismi di dissipazione puramente numerici, senza alcun modello di turbolenza fisico aggiunto!

Perché l’Ordine Alto Non Significa Convergenza Veloce nella Turbolenza
Ci si potrebbe aspettare che metodi FEM di ordine alto convergano molto rapidamente. Questo è vero per problemi con soluzioni lisce. Ma la turbolenza è tutt’altro che liscia! Ha uno spettro di scale spaziali enorme.
Possiamo fare un ragionamento semplice basato sullo spettro di energia di Kolmogorov ((E(k) sim k^{-5/3})). Un metodo numerico, anche di ordine alto, ha un limite di risoluzione (un numero d’onda massimo (k_{hp}) che può rappresentare). L’energia contenuta nelle scale più piccole ((k > k_{hp})) viene persa o, meglio, deve essere dissipata dal metodo numerico.
Se calcoliamo l’energia “non risolta” integrando lo spettro di Kolmogorov da (k_{hp}) all’infinito, troviamo che l’errore di interpolazione nell’energia cinetica scala come (k_{hp}^{-2/3}). Poiché (k_{hp}) è inversamente proporzionale alla dimensione della mesh (h) (e debolmente dipendente da (p)), questo suggerisce che la velocità di convergenza in (h) per l’energia cinetica sia limitata a circa 2/3, indipendentemente dall’ordine formale (p) del metodo, purché siamo in un regime turbolento pienamente sviluppato dove lo spettro di Kolmogorov è valido fino a scale molto più piccole di quelle risolte.
Questo spiegherebbe perché osserviamo tassi di convergenza lenti (vicini a 2/3) nelle nostre simulazioni del Taylor-Green vortex. La LES, per sua natura sotto-risolta, è intrinsecamente in conflitto con l’idea di convergenza di ordine alto per quantità globali come l’energia cinetica.
Conclusioni (Provvisorie) e Domande Aperte
L’idea che il termine convettivo trasporti solo energia e che la dissipazione avvenga solo tramite la viscosità non regge nel limite inviscoso, né nelle simulazioni numeriche sotto-risolte di flussi ad alto Re. Uno schema numerico con meccanismi di dissipazione legati al termine non lineare (o a termini di stabilizzazione) è in accordo con il problema continuo, che può dissipare energia nel limite di Eulero.
Seguendo la filosofia della LES implicita, un metodo numerico consistente per la turbolenza è “compatibile con la fisica” se conserva la massa ed è energeticamente stabile grazie a meccanismi di dissipazione numerica che smorzano le alte frequenze. Un metodo discretamente conservativo (senza modelli aggiuntivi) non lo è. La metrica della conservazione discreta dell’energia non è adatta a giudicare l’accuratezza per la turbolenza, perché è insensibile alla risoluzione spaziale e porta alla termalizzazione.
La stabilità energetica globale sembra un concetto consolidato, ma forse dovremmo guardare anche a criteri locali? E come si collegano questi metodi alle “soluzioni deboli dissipative” della teoria matematica? C’è ancora molto da capire e da esplorare! Ad esempio, quale combinazione di meccanismi di dissipazione (volume, superficie, upwind, GJP) funziona meglio? Come interagiscono con schemi temporali efficienti come i metodi a proiezione?
Penso che studi comparativi rigorosi (magari “in cieco”) aiuteranno la comunità LES a identificare gli approcci più promettenti tra la grande varietà di tecniche implicite ed esplicite. La strada è ancora lunga, ma affascinante!
Fonte: Springer