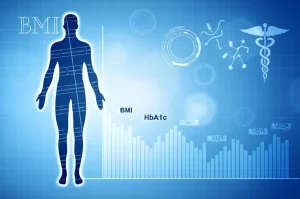Trigger con Agonista GnRH: Allunga la Fase Follicolare Senza Compromettere la Cicogna!
Ciao a tutti, appassionati di scienza e futuri genitori! Oggi voglio parlarvi di qualcosa che tocca da vicino chi affronta un percorso di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), o ART come la chiamano gli addetti ai lavori. Nello specifico, ci tufferemo in uno studio che ho trovato davvero interessante sull’impatto del tipo di “trigger” – quel farmaco che si usa per far maturare gli ovociti prima del prelievo – sulla durata della fase follicolare del ciclo successivo. Sembra un dettaglio, vero? Eppure, come vedremo, può avere implicazioni pratiche non da poco!
Ma cos’è questo “trigger” e perché ne parliamo?
Allora, per chi non è del mestiere, durante la stimolazione ovarica controllata, a un certo punto bisogna dare il segnale finale agli ovociti per dire: “Ok, siete pronti per l’ultimo sprint!”. Storicamente, si usava la gonadotropina corionica umana (hCG), un po’ come un jolly che mima l’azione dell’ormone luteinizzante (LH) naturale. Però, l’hCG ha un “difetto”: può aumentare il rischio di sindrome da iperstimolazione ovarica (OHSS), una complicanza che vogliamo assolutamente evitare, specialmente in donne con una risposta ovarica esuberante.
Ed ecco che entrano in gioco gli agonisti del GnRH (ormone di rilascio delle gonadotropine). Questi farmaci sono una vera furbata: invece di mimare l’LH, stimolano la nostra stessa ipofisi a produrre un picco di LH endogeno, bello potente ma di durata più breve. Il risultato? Maturazione degli ovociti efficace e, soprattutto, un rischio di OHSS drasticamente ridotto. Una vera manna dal cielo in molti casi!
Ma, come ogni intervento medico, anche l’uso dell’agonista GnRH ha delle conseguenze a cascata. Una delle sue caratteristiche è quella di indurre una luteolisi, cioè una “morte” più rapida del corpo luteo, e questo ha portato a studiare protocolli di supporto luteale specifici se si fa un transfer a fresco. Però, ci si è chiesti: cosa succede al ciclo successivo, specialmente se si opta per una strategia “freeze-all” (congelare tutti gli embrioni) e si programma il transfer in un secondo momento?
Lo studio: cosa abbiamo scoperto?
Ed è qui che si inserisce lo studio che mi ha incuriosito, pubblicato su Springer. I ricercatori hanno voluto vederci chiaro: l’uso dell’agonista GnRH come trigger, rispetto all’hCG, modifica la lunghezza della fase follicolare nel ciclo mestruale che segue la stimolazione? Hanno analizzato retrospettivamente i dati di 196 donne che si sono sottoposte a stimolazione ovarica controllata con strategia “freeze-all” per diagnosi genetica preimpianto per malattie monogeniche (PGT-M). Di queste, 132 avevano ricevuto l’agonista GnRH e 64 l’hCG.
I risultati sono stati piuttosto netti. Tenetevi forte: il gruppo che aveva ricevuto l’agonista del GnRH ha mostrato una fase follicolare successiva significativamente più lunga rispetto al gruppo hCG. Parliamo di una media di circa 19 giorni (18.98 ± 3.54) contro i 16 giorni (16.06 ± 3.13) del gruppo hCG. Una differenza di quasi tre giorni, che in termini di ciclo mestruale non è affatto trascurabile!
Non solo: ben il 90.2% delle donne nel gruppo GnRH agonista ha avuto un allungamento della fase follicolare rispetto al proprio ciclo basale, contro il 60.9% del gruppo hCG. E se guardiamo a un allungamento “significativo” (cioè superiore ai due giorni rispetto al basale), le percentuali sono 75.8% contro 37.5%. Insomma, l’agonista GnRH sembra proprio prendersela comoda per far ripartire il follicolo dominante nel ciclo successivo.

L’analisi statistica più approfondita, una regressione multipla (che serve a capire quali fattori influenzano un risultato, tenendo conto di altre variabili), ha confermato che il tipo di trigger (agonista GnRH) è un predittore indipendente significativo della lunghezza della fase follicolare successiva. In pratica, anche considerando altri fattori, l’agonista GnRH “spiega” una buona parte di questo allungamento.
Il protagonista: l’agonista GnRH e la fase follicolare
Ma perché succede questo? Lo studio suggerisce che lo stato “ipogonadotropo” transitorio indotto dall’agonista GnRH (cioè una temporanea soppressione degli ormoni che stimolano le ovaie) potrebbe influenzare le caratteristiche della fase follicolare successiva. È come se l’asse ipotalamo-ipofisi-ovaio avesse bisogno di un po’ più di tempo per “riprendersi” e far ripartire la normale ciclicità follicolare dopo la “botta” data dal trigger con agonista.
È interessante notare che, nonostante queste variazioni nella lunghezza della fase follicolare, la durata totale del ciclo (dal primo giorno del sanguinamento mestruale nel ciclo di stimolazione fino all’ovulazione documentata nel ciclo naturale modificato successivo) è rimasta simile tra i due gruppi. Questo si spiega perché il trigger con hCG è associato a una fase luteale più lunga, mentre quello con agonista GnRH a una fase luteale più corta, che però viene “compensata” da una fase follicolare successiva più lunga. Sembra quasi che il nostro corpo abbia un suo “orologio” interno che cerca di mantenere una certa regolarità complessiva, nonostante le perturbazioni.
E il BMI? Un attore secondario ma interessante
Un altro dato emerso dall’analisi di regressione è che anche l’indice di massa corporea (BMI) è risultato essere un predittore significativo della lunghezza della fase follicolare. Attenzione però: l’effetto, seppur statisticamente significativo, è stato modesto. Parliamo di un aumento di circa 0.2 giorni nella lunghezza della fase follicolare per ogni unità di BMI in più. Gli autori stessi invitano alla cautela nell’interpretare questo dato, sottolineando che necessita di ulteriori conferme in studi più ampi. È una pista intrigante, che si allinea con la letteratura sulle influenze metaboliche sui cicli riproduttivi, ma per ora resta un’osservazione da approfondire.
Niente panico per la cicogna!
Ora, la domanda che sorge spontanea è: questo allungamento della fase follicolare influisce negativamente sulle possibilità di gravidanza? Ebbene, la buona notizia è che, dopo aver aggiustato i dati per tenere conto di altre variabili confondenti (come l’età, il numero di ovociti recuperati, ecc.), i tassi di gravidanza sono risultati comparabili tra i due gruppi. Anche lo spessore endometriale, un altro fattore importante per l’impianto, era simile.
Questo è un punto cruciale! Significa che, sebbene l’agonista GnRH modifichi la tempistica della fase follicolare successiva, non sembra compromettere la capacità dell’endometrio di svilupparsi adeguatamente né, in ultima analisi, le chance di ottenere una gravidanza. Sembra che il sistema riproduttivo abbia una notevole capacità di adattamento.

L’analisi ha anche rivelato che il fattore che più di tutti prediceva il successo della gravidanza era il trasferimento di una blastocisti, il che non sorprende e conferma l’importanza della qualità embrionale.
Cosa significa tutto questo per noi?
Dal punto di vista pratico, queste scoperte sono molto utili. Se sappiamo che dopo un trigger con agonista GnRH è probabile aspettarsi una fase follicolare più lunga (in media, lo studio parla di un aumento di circa 5.3 giorni rispetto ai cicli naturali della paziente), i medici possono pianificare diversamente il monitoraggio per il transfer di embrioni congelati in ciclo spontaneo o modificato. Ad esempio, si potrebbe iniziare il monitoraggio ecografico un po’ più tardi, evitando visite precoci magari inutili e riducendo un po’ lo stress per la paziente.
Questo tipo di informazione aiuta a personalizzare i protocolli e a gestire meglio le aspettative. Sapere che una fase follicolare che si allunga non è necessariamente un segno negativo, ma una conseguenza attesa del tipo di trigger usato, può essere rassicurante.
Un pizzico di cautela e prospettive future
Come ogni studio scientifico, anche questo ha i suoi punti di forza e le sue limitazioni. Tra i punti di forza, c’è l’analisi di una situazione clinica specifica e una metodologia statistica robusta. Tuttavia, è uno studio retrospettivo e condotto in un singolo centro, il che potrebbe limitarne la generalizzabilità. Inoltre, c’erano delle differenze basali tra i due gruppi (ad esempio, livelli di FSH e dosaggi di gonadotropine), che i ricercatori hanno cercato di gestire con l’analisi multivariata, ma non si possono escludere altri fattori confondenti non misurati.
Gli stessi autori sottolineano che, sebbene i risultati siano statisticamente significativi, la loro rilevanza clinica, specialmente per un allungamento medio di circa 5 giorni, necessita di conferme da studi prospettici più ampi e su popolazioni più diversificate. Ad esempio, lo studio si è concentrato solo su cicli PGT-M, quindi l’applicabilità ad altre indicazioni della PMA è da verificare.
In conclusione, questo studio ci dice che il trigger con agonista GnRH allunga significativamente la fase follicolare successiva, ma senza compromettere la ritmicità riproduttiva di base o, cosa più importante, i tassi di gravidanza (una volta considerati altri fattori). Il BMI potrebbe giocare un ruolo, ma molto marginale e da confermare. Queste informazioni sono preziose per ottimizzare i protocolli di monitoraggio nei cicli di transfer di embrioni congelati e per continuare a svelare i complessi meccanismi che regolano la nostra fertilità. La ricerca non si ferma mai, e ogni tassello in più ci aiuta a personalizzare sempre meglio i percorsi di PMA!
Fonte: Springer