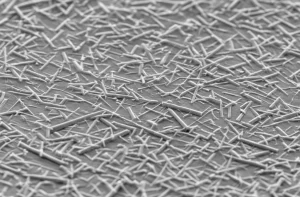Proprietà Addio? Come il Concetto di Possesso Sta Cambiando Sotto i Nostri Occhi (e Perché Dovrebbe Interessarci)
Ammettiamolo, l’idea di “possedere” qualcosa ha un fascino tutto suo, vero? Che sia la nostra casa, l’auto, o persino quel vinile introvabile che abbiamo scovato dopo anni di ricerche. È una sensazione di sicurezza, di appartenenza, quasi un’estensione di noi stessi. Ma se vi dicessi che questo concetto, così radicato in noi, sta subendo una trasformazione silenziosa ma potentissima, quasi sotto i nostri nasi? Mi sono imbattuto di recente in un testo tedesco, “Transformation einer Sozialformation: Überlegungen zum Strukturwandel des Eigentums”, che mi ha fatto riflettere parecchio su questo tema, e vorrei condividere con voi qualche spunto.
Il Concetto di Proprietà: Un Pilastro della Nostra Società (O Così Credevamo)
Partiamo da una base: la proprietà, specialmente quella privata, è sempre stata considerata un’istituzione fondamentale, quasi sacra, delle società moderne. Pensateci un attimo: l’intera impalcatura economica, il mondo del lavoro, persino il welfare state e le istituzioni culturali, poggiano in qualche modo sull’idea di proprietà. L’acquisto, il possesso, la distribuzione, la trasmissione ereditaria di beni – materiali o immateriali che siano – sono al centro del nostro modo di produrre e di vivere. E, non giriamoci intorno, il possedere o non possedere beni e ricchezze definisce in larga parte la stratificazione sociale e le dinamiche di potere.
Dopo il crollo del blocco socialista nel 1989, abbiamo assistito a una vera e propria radicalizzazione del concetto di proprietà privata. Questo si è manifestato in tre modi principali:
- Estensione: la logica della proprietà privata si è allargata a macchia d’olio, invadendo settori prima gestiti diversamente (pensiamo alle privatizzazioni di ferrovie, poste, acqua, persino carceri e ospedali).
- Approfondimento: le politiche neoliberiste hanno “scatenato” la proprietà privata, liberandola da vincoli politici e sociali, attraverso la deregolamentazione.
- Concentrazione: una crescente e massiccia concentrazione di proprietà e ricchezza nelle mani di pochi, con disuguaglianze globali che definire gigantesche è un eufemismo.
Ma la proprietà non è solo una questione istituzionale; plasma profondamente anche la nostra cultura, il nostro modo di relazionarci con il mondo e con noi stessi. Si parla di un vero e proprio “rapporto possessivo con il mondo”, che influenza le nostre aspirazioni, le nostre paure, la nostra stessa identità.
Ma Cosa Sta Succedendo Davvero? I Segnali di un Cambiamento Epocale
Eppure, negli ultimi decenni, qualcosa sta scricchiolando. Sentiamo parlare sempre più spesso di conflitti e dibattiti accesi che riguardano la proprietà: dalla distribuzione sempre più iniqua della ricchezza ai diritti d’autore sui beni digitali, dalla proprietà dei dati generati online o delle sequenze genetiche decodificate, fino ai beni culturali post-coloniali, alla nazionalizzazione di industrie chiave o al sequestro di beni russi dopo l’attacco all’Ucraina. Persino le risorse extraterrestri e marittime sono oggetto di contesa. Siamo di fronte a un cambiamento strutturale fondamentale della proprietà? E se sì, questo cambiamento potrebbe trasformare l’intera formazione sociale della modernità?
Per capirci meglio, dobbiamo distinguere tra “cambiamento sociale”, “cambiamento strutturale” e “trasformazione”. Il cambiamento sociale avviene continuamente, pensiamo alle mode o a nuove forme culturali. Il cambiamento strutturale, invece, tocca le fondamenta istituzionali e gli orientamenti culturali, ed è quello che potremmo osservare oggi per la proprietà. Una trasformazione vera e propria, però, implicherebbe un mutamento della struttura più profonda della società, della sua logica operativa fondamentale.
Curiosamente, Marx ed Engels, nel Manifesto Comunista, parlavano già di una borghesia che “non può esistere senza rivoluzionare continuamente gli strumenti di produzione, quindi i rapporti di produzione, quindi tutte le condizioni sociali”. Questa continua “rivoluzione” e “scuotimento” non erano, per loro, una trasformazione della società capitalista, ma proprio il modo in cui essa si stabilizzava. Io la chiamo stabilizzazione dinamica: una formazione sociale che riesce a mantenere il suo status quo solo attraverso una crescita economica costante, innovazione culturale e accelerazione tecnica. Dietro a questo turbinio di cambiamenti superficiali, si nasconde una profonda rigidità strutturale.

La mia ipotesi, basata sulle riflessioni del testo tedesco, è che un cambiamento strutturale della proprietà sia effettivamente in corso. Le catene di connessione tra la proprietà (il titolo legale) e il possesso (i diritti concreti di disporre di un bene) stanno diventando sempre più lunghe, complesse e, in molti casi, si stanno allentando. Questo porta a una frammentazione dei pacchetti di diritti (e dei corrispondenti doveri di cura) originariamente associati alla proprietà.
Proprietà, Possesso e la Frantumazione dei Diritti: Benvenuti nell’Era dell’Accesso
Sia nella produzione sociale che nel consumo di beni, stiamo assistendo a una sostituzione: l’effettiva proprietà delle cose, con i suoi diritti di disposizione e doveri di cura, lascia il posto a pacchetti limitati di diritti di accesso e di uso. Pensateci: quanti di noi “possiedono” ancora la musica che ascoltano? Una volta compravamo CD, vinili. Ora “streammiamo” da Spotify o Apple Music. Non possediamo l’album, ma abbiamo accesso a milioni di canzoni. Lo stesso vale per i film e le serie TV (Netflix, Prime Video), per i software (Microsoft 365, Adobe Creative Cloud in abbonamento), e persino per i libri con servizi come Kindle Unlimited.
Questa tendenza si sta estendendo. Anche per i beni fisici, come le automobili (car sharing, leasing a lungo termine), le biciclette o i monopattini elettrici (noleggio al minuto), e persino l’abbigliamento (noleggio di abiti da cerimonia o di lusso). Le aziende stesse, sul lato della produzione, adottano strategie simili per molti fattori produttivi.
Cosa implica tutto ciò? Le catene tra proprietà e possesso diventano incredibilmente complesse e spesso invisibili. Prendiamo l’esempio di un appartamento in un grande complesso residenziale. Gli inquilini “possiedono” di fatto l’uso esclusivo della loro casa, ma il proprietario legale potrebbe cambiare più volte nel corso degli anni (da un piccolo fondo a una grande società immobiliare, a un consorzio) senza che gli inquilini se ne accorgano o sappiano chi sia veramente. Se l’immobile appartiene a una società per azioni, neanche gli azionisti sanno esattamente quali appartamenti “possiedono” e non hanno diritti di disposizione diretti, se non quello di vendere le proprie azioni.
I diritti di disposizione e i doveri di cura si frammentano tra una miriade di attori: inquilino, amministratore, società di gestione, proprietario ultimo. E questo non è un fenomeno nuovo, ma sta raggiungendo una qualità e una diffusione inedite.
Questo cambiamento ha conseguenze profonde sul nostro rapporto con il mondo:
- Rapporto con le cose: La “cura” per l’oggetto posseduto tende a svanire. Se noleggio un’auto, non mi preoccupo del cambio dell’olio o della ruggine. La manutenzione è responsabilità del fornitore. La profondità del mio diritto di disporne è limitata (non posso venderla o modificarla), ma il volume di ciò a cui ho accesso aumenta esponenzialmente (con un abbonamento a un servizio di car sharing, ho potenzialmente a disposizione un’intera flotta di veicoli diversi). Le cose diventano, in un certo senso, “usa e getta” o, meglio, “usa e qualcun altro se ne occuperà”.
- Rapporto sociale: La competizione si sposta dalla proprietà di beni concreti ai diritti di accesso.
- Rapporto con sé stessi: La nostra identità, tradizionalmente legata anche a ciò che possediamo, potrebbe ridefinirsi. Non più “sono ciò che possiedo”, ma forse “sono ciò a cui ho accesso”?
Le innovazioni tecnologiche, soprattutto la digitalizzazione, hanno accelerato questo processo. Beni non scarsi e non rivali come software, musica, film, testi, si possono replicare e distribuire a costo quasi zero, rendendo difficile delimitarli con la forma tradizionale della proprietà. D’altro canto, le tecnologie hanno creato economie della conoscenza e della produzione così complesse che i fattori e le infrastrutture necessarie non possono più essere controllati da singoli proprietari, ma da un insieme di attori pubblici e privati.

Un Cambiamento Strutturale, Ma Non (Ancora) una Trasformazione Totale
E qui arriviamo al punto cruciale, quasi paradossale, sollevato dal testo che ho letto. Questo cambiamento strutturale della proprietà, questo passaggio dall’essere proprietari all’essere utenti, non sta affatto invalidando gli imperativi dell’accumulazione di capitale e della stabilizzazione dinamica. Anzi, ne sembra un requisito funzionale! La logica dell’accumulazione di capitale rimane intatta e centrale. Le disuguaglianze sociali continuano ad acuirsi, e le pressioni verso crescita, accelerazione e innovazione, tipiche della stabilizzazione dinamica, non vengono meno.
Perché? Perché la proprietà materiale, quella legata a beni sostanziali, ha un’inerzia. Proprio perché tendiamo a “curare” ciò che è nostro, ci riesce difficile separarcene, “smaltirlo”, buttarlo via. Se faccio fatica a disfarmi del mio vecchio televisore, della lavatrice, del computer, dei libri, dell’auto che “mi appartengono”, allora la proprietà diventa disfunzionale per il processo di accumulazione di capitale, che richiede un ricambio sempre più rapido dei beni.
Se invece questi beni non mi “appartengono” più in senso stretto, ma stipulo contratti di utilizzo, manutenzione, servizio, leasing, allora lo scambio e la sostituzione diventano fluidi e veloci. La funzione di “freno” della proprietà, legata all’attaccamento e alla cura, viene neutralizzata. Un po’ come Max Weber notava che l’involucro d’acciaio del capitalismo vittorioso non aveva più bisogno dello spirito dell’etica protestante che lo aveva originariamente motivato, oggi potremmo dire che l’involucro d’acciaio della stabilizzazione dinamica non ha più bisogno dell’istituzione della proprietà materiale nella sua forma tradizionale. Anzi, essa diventa un ostacolo all’accelerazione da superare.
Quindi, la proprietà come istituzione di base della modernità è in profondo mutamento. Le catene tra il titolo di proprietà (spesso concentrato e astratto) e il possesso/utilizzo concreto si allungano e si sfilacciano. La proprietà diventa, da entrambi i lati della catena, un “bene immateriale” di nuovo tipo. Da un lato, titoli finanziari astratti che non corrispondono a una cura o conoscenza diretta dei beni sottostanti; dall’altro, diritti di accesso temporanei che non implicano un vero possesso o una responsabilità di cura a lungo termine.
Questo non significa la fine del capitalismo, ma una sua riconfigurazione. La logica dello “smaltimento” diventa radicale, permettendo a una società tardo-capitalista di trasformare continuamente il mondo in “rifiuto” (in senso lato, come ciò che viene superato e sostituito rapidamente), perché la proprietà viene concepita sempre più come patrimonio astratto, manifestato in colonne di numeri digitali che però determinano il potere di accesso al mondo.
Siamo dunque di fronte a un cambiamento strutturale significativo che tocca le forme culturali del nostro rapporto con il mondo e le strutture istituzionali di produzione e distribuzione. I modelli di disposizione e cura, individuali e collettivi, sono in fase di rinegoziazione. Questo apre scenari complessi e, forse, la possibilità di un incipiente cambiamento di formazione sociale all’inizio del XXI secolo. Le sue reali sembianze, però, sono ancora tutte da decifrare. Per ora, i principi fondamentali che determinano la nostra formazione sociale sembrano rimanere saldamente al loro posto, paradossalmente rafforzati da questo stesso cambiamento.
Una bella matassa da sbrogliare, non trovate? E le implicazioni per il nostro futuro, per come vivremo, lavoreremo e ci relazioneremo, sono enormi.
Fonte: Springer