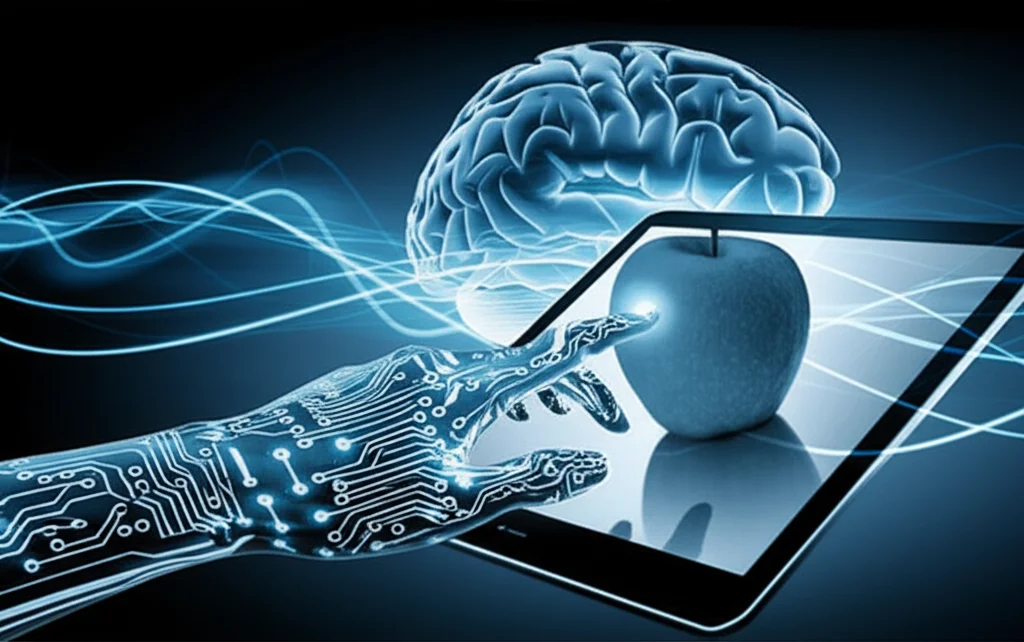Toccare con la Mente: Come la Stimolazione Cerebrale Sta Riscrivendo il Senso del Tatto
Immaginate di poter sentire di nuovo il calore di una tazza, la ruvidità di un asciugamano o la morbidezza del pelo di un gatto, anche dopo una lesione che vi ha privato del senso del tatto. Sembra fantascienza, vero? Eppure, la scienza sta facendo passi da gigante in una direzione che fino a poco tempo fa apparteneva solo ai romanzi: restituire le sensazioni tattili stimolando direttamente il cervello.
Parliamoci chiaro, l’obiettivo finale della ricerca sulle protesi è creare arti artificiali che non siano solo funzionali, ma che si integrino perfettamente con il nostro corpo, quasi facendoci dimenticare di averle. E una componente chiave, forse la più desiderata da chi usa una protesi, è proprio il feedback tattile. Sentire ciò che si tocca è fondamentale per interagire con il mondo in modo naturale e sicuro.
La Sfida: Insegnare al Cervello a “Sentire” di Nuovo
Una delle strade più promettenti è la microstimolazione intracorticale (ICMS) della corteccia somatosensoriale, quella parte del cervello che elabora le informazioni tattili. In pratica, si inviano piccoli impulsi elettrici direttamente ai neuroni giusti per evocare sensazioni localizzate, ad esempio, sulla mano paralizzata di una persona con lesione midollare.
Sembra semplice sulla carta, ma tradurre le caratteristiche di un oggetto – la sua forma, la sua texture, la sua temperatura – in pattern di stimolazione efficaci è un rompicapo. Perché? Beh, innanzitutto non conosciamo ancora tutti i segreti del codice neurale del tatto. Poi, lo spazio dei parametri di stimolazione (intensità, frequenza, pattern temporali, elettrodi coinvolti) è enorme. E infine, come misuriamo oggettivamente una sensazione artificiale? Se chiedo a qualcuno “quanto era forte la pressione?”, potrei influenzare la sua risposta, magari inducendolo a usare la parola “pressione” anche se la sensazione era diversa.
Finora, molti studi si sono concentrati sulla variazione di un parametro alla volta, spesso su modelli animali che, ovviamente, non possono descrivere a parole cosa sentono. Negli studi sull’uomo, i partecipanti descrivono le sensazioni evocate dalla ICMS come “potenzialmente naturali”, riportando qualità come:
- Pressione
- Tocco leggero
- Picchiettio
- Calore
- Stretta
- Pizzicotto
- Vibrazione
- Soffio
- Pelle d’oca
Ma a volte emergono anche sensazioni più “artificiali”, come formicolio o una scossa elettrica. La qualità percepita dipende molto da quali elettrodi vengono stimolati e con quali parametri (ampiezza, frequenza). Esplorare tutte le combinazioni possibili con il metodo classico “stimola e descrivi” è lento e potenzialmente noioso.
Un Nuovo Approccio: Mettere i Partecipanti al Comando
Ed è qui che entra in gioco un’idea affascinante: e se fossero i partecipanti stessi a progettare le proprie sensazioni? In un recente studio, abbiamo coinvolto tre persone con tetraplegia, dotate di impianti di microelettrodi nella corteccia somatosensoriale. Abbiamo creato un’interfaccia su tablet che permetteva loro di “toccare” oggetti virtuali (un gatto, una mela, un asciugamano, un toast e una chiave).
Quando toccavano l’oggetto virtuale con la mano sinistra (usando la funzione residua), il sistema inviava stimolazioni alla corteccia corrispondente alla loro mano destra paralizzata. Ma la cosa più interessante è che potevano modificare in tempo reale quattro parametri di stimolazione:
- Ampiezza: l’intensità della corrente.
- Frequenza: il numero di impulsi al secondo.
- Fattore Biomimetico: un parametro che cercava di imitare i picchi di attività neurale che si verificano naturalmente all’inizio e alla fine del contatto con un oggetto.
- “Drag” (Trascinamento): un parametro che simulava il movimento della mano sull’oggetto stimolando tre elettrodi in sequenza con una certa sovrapposizione temporale.
Per rendere la cosa ancora più rigorosa, i partecipanti erano “ciechi” rispetto ai parametri: ad ogni prova, l’assegnazione dei parametri ai controlli sul tablet (due rettangoli dove muovere dei cursori) e la loro direzione (aumentare o diminuire) venivano randomizzati. Dovevano basarsi esclusivamente sulla sensazione percepita per trovare l’impostazione che, secondo loro, rappresentava meglio l’oggetto visualizzato.

Risultati Sorprendenti: Sensazioni Distinte e Intuitive
Cosa abbiamo scoperto? Innanzitutto, i partecipanti (soprattutto due di loro, P2 e C1) hanno esplorato attivamente lo spazio dei parametri, identificando combinazioni specifiche per ciascun oggetto. Hanno descritto le sensazioni create con aggettivi vividi e appropriati all’oggetto: parlando della mela sentivano qualcosa di “liscio, curvo, un po’ fresco e umido“; per il gatto, una sensazione “molto leggera, come accarezzare un gatto, setosa, persino calda“; per l’asciugamano, qualcosa di “pizzicante, non proprio un picchiettio, ma nemmeno solido, mi ricorda la ruvidità“. Queste descrizioni sono diverse e più ricche rispetto a quelle tipiche riportate con stimolazioni standard.
Ma la prova del nove è arrivata con il “compito di riproduzione” (replay task). Alla fine di ogni sessione, abbiamo riproposto ai partecipanti le stimolazioni che avevano creato, ma questa volta senza mostrare l’immagine dell’oggetto. Dovevano indovinare a quale oggetto corrispondesse la sensazione. Ebbene, P2 e C1 sono riusciti a identificare l’oggetto corretto con una precisione significativamente superiore al caso! Questo dimostra che le stimolazioni create non erano solo soggettivamente soddisfacenti, ma anche percettivamente distinte.
Ancora più interessante: abbiamo addestrato un classificatore lineare (un algoritmo di intelligenza artificiale) a riconoscere gli oggetti basandosi solo sui parametri di stimolazione scelti dai partecipanti. Le prestazioni del classificatore erano molto simili a quelle dei partecipanti umani. E sia gli umani che l’algoritmo tendevano a confondere più spesso oggetti con caratteristiche tattili simili (secondo un sondaggio fatto su persone con sensibilità intatta). Ad esempio, era più facile confondere il gatto con l’asciugamano (entrambi relativamente morbidi) che il gatto con la chiave (uno morbido, l’altra dura).
Il Tatto Artificiale Riflette le Proprietà Reali?
Questa correlazione tra la confondibilità delle sensazioni artificiali e la somiglianza tattile degli oggetti reali è un indizio potente. Suggerisce che i partecipanti non stavano semplicemente creando cinque sensazioni qualsiasi, ma stavano cercando (e in parte riuscendo) a catturare alcune proprietà intrinseche degli oggetti. Analizzando i parametri scelti, abbiamo visto che correlavano in particolare con la cedevolezza (morbido vs. duro) e la temperatura percepita (caldo vs. freddo) degli oggetti reali. Ad esempio, oggetti percepiti come “duri” (mela, chiave, toast) tendevano ad avere profili di stimolazione diversi da quelli “morbidi” (gatto, asciugamano).

Il Ruolo del Contesto Visivo
Certo, il contesto visivo conta. Quando vediamo un gatto e sentiamo una certa stimolazione, è più probabile interpretarla come “morbida” o “pelosa”. Abbiamo verificato che, soprattutto per il partecipante (P3) che aveva esplorato meno lo spazio dei parametri e aveva prestazioni al limite del caso nel compito di riproduzione, la presenza dell’immagine influenzava le descrizioni. Ma per gli altri due partecipanti (P2 e C1), le cui sensazioni erano più distinte, le descrizioni rimanevano coerenti anche senza l’immagine. Questo ci dice che, sebbene la vista contribuisca all’esperienza complessiva (come avviene anche nel tatto naturale!), la microstimolazione della corteccia somatosensoriale può di per sé evocare percezioni tattili distinte e appropriate all’oggetto.
Verso un Futuro Tattile
Questo studio apre scenari entusiasmanti. Dimostra che pattern di stimolazione più complessi e personalizzati possono evocare un repertorio di sensazioni più ricco e intuitivo. L’approccio “auto-guidato”, in cui è la persona stessa a esplorare e definire le sensazioni, non solo è più coinvolgente ma si è rivelato efficace per mappare questo complesso spazio percettivo.
Certo, la strada è ancora lunga. Il numero di partecipanti in questi studi è necessariamente limitato, e abbiamo osservato variabilità tra le persone e anche nelle scelte dello stesso individuo in giorni diversi. Sarà fondamentale capire meglio come ottimizzare la scelta degli elettrodi e i parametri di stimolazione per ottenere sensazioni ancora più stabili e naturali.
Tuttavia, la possibilità di “toccare con la mente”, di restituire un senso così fondamentale attraverso un’interfaccia cervello-computer, è sempre meno fantascienza e sempre più una realtà tangibile. Stiamo imparando a dialogare con il cervello nel suo stesso linguaggio, e i risultati sono, letteralmente, sensazionali.
Fonte: Springer