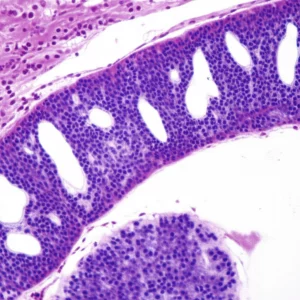Boom Sonico Addomesticato? La Sfida del STRATOFLY MR3!
Il Sogno Supersonico e Quel “Piccolo” Problema Chiamato Boom
Ammettiamolo, chi non ha mai sognato di sfrecciare nei cieli più veloce del suono, magari per un viaggetto intercontinentale in poche ore? Io di sicuro! Ma c’è un “piccolo” dettaglio che ha sempre frenato gli entusiasmi: il boom sonico. Quel frastuono pazzesco, simile a un tuono potentissimo, che si scatena quando un aereo supera la barriera del suono. Un vero e proprio incubo per chi sta a terra, tanto da aver portato al bando dei voli supersonici civili sopra le aree abitate. Ecco, nel quadro del progetto europeo MOREandLess (sotto l’ombrello di Horizon 2020), insieme ai colleghi dell’ISL (Istituto franco-tedesco di ricerche di Saint-Louis) e del CIRA (Centro Italiano Ricerche Aerospaziali), ci siamo messi d’impegno per affrontare questa sfida di petto.
L’obiettivo? Raccogliere una marea di dati sperimentali di altissima qualità sul boom sonico, dati che ci servissero sia per capire meglio come si comporta questo fenomeno, sia per affinare i modelli matematici che cercano di prevederlo. E il nostro “soggetto di studio” è stato un modello in scala ridotta e leggermente modificato del veicolo STRATOFLY MR3, un concept di aereo ipersonico pensato per volare a Mach 5 trasportando più passeggeri del Concorde.
In Campo Aperto: Come Abbiamo “Sparato” al Boom Sonico
Perché dei test all’aperto e non in una comoda galleria del vento? Beh, per studiare come si sviluppano le onde N (la forma caratteristica del boom sonico) a grande distanza, servirebbero gallerie enormi, impraticabili per certi versi. Così, il 4 e 5 ottobre 2022, ci siamo trasferiti al poligono di tiro dell’ISL a Saint-Louis, in Francia. Immaginate la scena: un cannone a polvere da 91 mm che spara il nostro modello STRATOFLY MR3 a una velocità iniziale di circa Mach 4.7! Mica uno scherzo. Questo poligono permette test fino a 1000 metri, con velocità da Mach 0.6 a Mach 6.
Il modello, per poter volare stabile senza fare piroette e per raggiungere il bersaglio (visto che la sua forma originale genera portanza continua), è stato ridimensionato e un po’ modificato nella sua geometria, soprattutto nella parte superiore, rendendolo simmetrico per eliminare la portanza a zero angolo d’attacco. Abbiamo anche tolto canard e alette per semplicità e chiuso le prese d’aria frontali, assicurandoci che il boom sonico osservato fosse comunque rappresentativo. Il modello finale pesava circa 500 grammi ed era lungo poco più di 20 cm. Per lanciarlo correttamente, abbiamo usato un “sabot”, una specie di guscio a quattro petali con un piattello spingitore, che lo centra nella canna e si stacca subito dopo il lancio. E per “ascoltare” il boom, abbiamo disseminato il campo di battaglia con microfoni di precisione, sia a terra che… su droni!
A Caccia di Onde: Microfoni a Terra e in Volo
La parte cruciale, ovviamente, era registrare il boom. L’ISL e il CIRA hanno schierato un arsenale di sensori. A terra, l’ISL ha posizionato quindici microfoni a condensatore BrueleKjaer da 1/4 di pollice, montati a 30 cm di altezza, capaci di registrare da 4 Hz a 70 kHz e con una dinamica fino a 172 dB, perfetti per non andare in saturazione con la botta del boom. Li abbiamo disposti su tre linee, a 70, 85 e 100 metri dalla bocca del cannone, e a cinque diverse distanze laterali (CPA – Closest Point of Approach) dalla traiettoria del proiettile (5, 10, 15, 20 e 30 metri).
Il CIRA, invece, ha messo in campo quattro microfoni a pressione PCB da 1/4 di pollice, anch’essi di Classe 1, con sensibilità e range dinamico adatti, posizionati a circa un metro di altezza e a distanze di circa 5 e 10 metri dalla traiettoria. La diversa altezza dei microfoni ISL (più bassi) e CIRA (più alti) ci ha permesso di catturare il boom diretto con alta fedeltà e, allo stesso tempo, di avere una validazione incrociata dei dati in funzione degli angoli di rollio.
Ma la vera chicca, se vogliamo, sono stati i microdroni. Ne abbiamo usati tre dell’ISL (due DJI Phantom 3 Pro e un DJI Phantom 4 Pro), equipaggiati con microfoni Sennheiser KE4-211-9 e registratori Roland R-07, che volavano in stazionamento a quote tra i 20 e i 40 metri sopra la linea di tiro, perpendicolarmente ad essa. L’idea era di catturare il boom sonico da tutte le angolazioni possibili, o meglio, per tutto l’arco dell’angolo di rollio del modello. Eh sì, perché il nostro modello, durante il volo, ruotava leggermente su se stesso (un rollio non predeterminato, ma dovuto a incertezze di fabbricazione e posizionamento iniziale), e questo ci ha dato l’opportunità di studiare come il boom cambia a seconda dell’orientamento dell’aereo.

Ogni test seguiva un protocollo rigoroso: preparazione, calibrazione dei microfoni, dispiegamento dei droni (che dovevano essere fermi in volo per sicurezza prima di muovere il proiettile), caricamento del modello col sabot nel cannone, avvio della registrazione dati, esecuzione del test, stop registrazione e recupero dei dati, inclusa la misurazione dell’angolo di rollio del modello tramite dei telai di carta (posti all’ingresso e all’uscita della zona di misurazione acustica) attraversati dal proiettile. Sembra semplice, ma vi assicuro che coordinare tutto è stato un bel lavoro di squadra! Per tracciare la velocità e la traiettoria, abbiamo usato un radar Doppler continuo e un sistema di tracciamento ottico 3D ad alta velocità.
Una cosa da tenere a mente: quando spari un proiettile da un cannone, non c’è solo il boom sonico del proiettile. C’è anche il “muzzle blast”, il botto dell’uscita dalla canna, e il boom del sabot (in particolare del piattello spingitore). Ovviamente, il nostro interesse era solo per il boom del modello MR3, quindi abbiamo dovuto “pulire” i segnali da questi disturbi in fase di post-processing. E poi, c’è il fenomeno dell’onda riflessa dal terreno: il microfono capta sia l’onda diretta che quella riflessa, leggermente ritardata e attenuata. Focalizzandoci sul boom del proiettile, si vedono infatti due segnali distinti.
Analisi dei Dati: Tra Rollio e Teoria
Abbiamo eseguito cinque lanci in due giorni. Tre con il modello in posizione iniziale verticale (ali perpendicolari al terreno) e due in posizione orizzontale (ali parallele al terreno). La non assialsimmetria del modello MR3 implica che le firme del boom sonico variano con l’orientamento del modello rispetto ai microfoni. Calcolare l’angolo di rollio esatto per ogni microfono è complesso, quindi abbiamo adottato un’approssimazione pratica, associando il suono catturato in un punto C’ al punto di distacco dell’onda d’urto B, e interpolando linearmente gli angoli di rollio misurati sui due telai di carta. Data la doppia simmetria geometrica del proiettile, gli angoli di rollio sono stati condensati nell’intervallo 0-90°.
I dati hanno mostrato che, come previsto, il tempo di salita dell’onda aumenta con la durata dell’onda stessa, ma questo non era un parametro chiave per noi. Le variazioni nella pressione di picco e nella durata della firma erano dovute principalmente alla diffusione geometrica e agli effetti combinati del moto rotatorio del proiettile e della sua configurazione non assialsimmetrica. Confrontando i segnali registrati dallo stesso microfono in test diversi, si poteva isolare l’effetto della diffusione geometrica. I risultati hanno confermato che le caratteristiche dell’onda d’urto sono significativamente influenzate sia dalla configurazione non assialsimmetrica del proiettile sia dalla sua attitudine di volo, in particolare dall’angolo di rollio.
La Teoria di Whitham Messa alla Prova: Un Matrimonio Possibile?
Una volta raccolti i dati, è arrivato il momento del confronto con la teoria. Abbiamo tirato in ballo la teoria lineare modificata di Whitham, un classico per la stima del boom sonico. Ora, bisogna essere onesti: questa teoria è nata per corpi assialsimmetrici (cioè con una simmetria rotazionale, come un proiettile semplice) e in regime supersonico “basso”. Il nostro MR3 non è assialsimmetrico e volava a Mach 4.7, quindi in pieno regime ipersonico, dove gli effetti non lineari, trascurati da Whitham, diventano importanti.
In più, la “regola delle aree supersoniche”, che si usa per calcolare un’area equivalente del velivolo da dare in pasto alla teoria (considerando sezioni tagliate da un piano inclinato all’angolo di Mach), a Mach 4.7 per il nostro modello dava risultati un po’ strani, con valori negativi della funzione F di Whitham su gran parte del dominio. Questo suggerisce che la regola potrebbe non essere accurata a Mach elevati per corpi snelli non estremamente appuntiti. Così, abbiamo optato per una distribuzione normale delle aree (le sezioni trasversali del modello perpendicolari all’asse longitudinale), calcolata con CATIA V5. Abbiamo anche visto che il contributo della portanza all’area equivalente (stimato con una formula approssimata) era piccolo rispetto a quello del volume, quindi l’abbiamo trascurato per semplificare il calcolo della funzione F di Whitham. Insomma, un po’ di approssimazioni, ma necessarie.

Ebbene, nonostante queste premesse, i risultati sono stati sorprendentemente buoni! Confrontando i valori medi sperimentali di pressione di picco e durata dell’onda N con le previsioni di Whitham (usando valori medi di pressione atmosferica e velocità del suono dai test), abbiamo trovato un accordo più che discreto. Le sovrapressioni di picco previste si discostavano in media dello 0.8% (in dB) dai valori misurati (calcolati come media quadratica), e le durate dell’onda N (media aritmetica) avevano un errore medio del 4.5%. Non male, considerando le limitazioni! Questo è in linea con studi NASA che hanno mostrato buon accordo con le previsioni per modelli complessi a Mach elevati con bassa portanza.
Questione di Angolazione: Come il Rollio Cambia il “Suono”
Uno degli aspetti più interessanti era capire come cambia il boom sonico a seconda dell’angolo di rollio del modello. Immaginate l’aereo che ruota: la forma che “presenta” all’aria e quindi al terreno sottostante cambia continuamente. Per analizzare questo, abbiamo normalizzato tutti i dati (95 osservazioni da 19 microfoni a terra) a una distanza CPA (Closest Point of Approach, il punto di minima distanza) di riferimento di 30 metri, usando le leggi di scala della teoria di Whitham.
Abbiamo analizzato i dati nell’intervallo 0-90° di rollio. E cosa abbiamo visto? Che sia la pressione di picco che la durata dell’onda N tendono a diminuire man mano che l’angolo di rollio aumenta da 0° (pancia dell’aereo verso il basso, o meglio, configurazione orizzontale rispetto al sensore) a 90° (aereo “di taglio”, o configurazione verticale). Questo ha senso: quando l’aereo è di taglio, la sua sezione efficace che genera l’onda è minore, portando a una variazione più graduale della distribuzione dell’area e quindi a un’onda N meno pronunciata. Abbiamo provato a fare un fit dei dati con una regressione quadratica, e questa ha confermato il trend, anche se la diminuzione non è stata così marcata come suggerito da alcune simulazioni numeriche precedenti (propagate anch’esse a 30m CPA). Le simulazioni numeriche indicavano una riduzione più netta.
Una possibile spiegazione per questa discrepanza è che il movimento di rollio, unito alla non-simmetria del modello, produce fronti d’onda che si fondono in un inviluppo dipendente dal tempo. Quindi, i microfoni non catturano un boom “pulito” associato a un singolo angolo istantaneo, ma una sovrapposizione di più onde d’urto. L’onda più intensa, associata all’orientamento a 0°, potrebbe non avere abbastanza tempo per dissiparsi e fondersi con quelle meno intense generate ad angoli di rollio maggiori. Anche una rapida accelerazione angolare all’inizio e l’incapacità di mantenere una velocità di rotazione costante potrebbero giocare un ruolo, sebbene l’analisi video suggerisca un moto di rollio relativamente costante nella zona di misura. Comunque, è chiaro che le caratteristiche geometriche del modello portano a boom sonici più intensi quando generati dalla parte inferiore/superiore dell’aereo rispetto al fianco. Questo è un dato importante per la progettazione di futuri velivoli!
Cosa Abbiamo Imparato (e Cosa Non Ha Funzionato Benissimo)
Tirando le somme, questa campagna di test all’aperto è stata un successo. Abbiamo raccolto una valanga di dati preziosi sul boom sonico del modello STRATOFLY MR3 a velocità ipersoniche.
- Abbiamo caratterizzato la direttività del rumore, vedendo come il rollio influisce sull’intensità e la durata del boom, nonostante una notevole dispersione dei dati.
- Abbiamo confrontato i dati con la teoria di Whitham, ottenendo un accordo ragionevole per i valori medi, il che è notevole date le condizioni operative e le assunzioni fatte (come la distribuzione normale dell’area).
- Abbiamo confermato che i boom più “cattivi” arrivano quando l’aereo presenta la sua sezione maggiore (orientamento a 0° di rollio).
C’è anche da dire cosa non è andato liscio come l’olio. I dati raccolti dai microfoni sui droni, purtroppo, hanno mostrato deviazioni inaccettabili, specialmente a distanze maggiori. Rumore dei motori e delle eliche dei droni, vibrazioni, interazioni delle onde d’urto con la struttura stessa del drone (riflessione, diffrazione, assorbimento), e il fatto che non fossero strumenti di Classe 1… insomma, ottenere misure di precisione con questa tecnica è ancora una bella sfida. Quindi, per le analisi più fini, ci siamo concentrati sui dati dei microfoni a terra, escludendo quelli dei droni.
Anche le piccole oscillazioni viste nei segnali dei microfoni CIRA (vedi Fig. 14 nel paper originale) sembrano più dovute a una risonanza intrinseca dei microfoni o al sistema di acquisizione (nonostante un filtro Butterworth analogico) che a fenomeni fisici reali, visto che i microfoni ISL mostravano forme d’onda più pulite e le oscillazioni erano simili tra microfoni CIRA in posizioni diverse. Effetti atmosferici come vento e turbolenza sono stati considerati trascurabili data la breve distanza di propagazione e l’assenza di eventi ventosi eccezionali, e le variazioni di temperatura e umidità tra i test avevano un impatto minimo (1-2%) sull’ampiezza e durata del boom.
Verso un Futuro Supersonico (e Silenzioso?)
Ogni esperimento come questo aggiunge un tassello importante al grande puzzle del volo supersonico civile. Capire a fondo il boom sonico, come si genera, come si propaga e, soprattutto, come si può ridurre, è fondamentale se vogliamo tornare a volare più veloci del suono senza far impazzire chi sta a terra. Il lavoro sul STRATOFLY MR3 e progetti come MOREandLess vanno esattamente in questa direzione. La strada è ancora lunga, ma ogni “boom” che riusciamo a misurare e analizzare ci avvicina un po’ di più all’obiettivo! Future simulazioni numeriche dinamiche potrebbero aiutare a capire meglio l’impatto della velocità di rollio rispetto a condizioni statiche.
Fonte: Springer