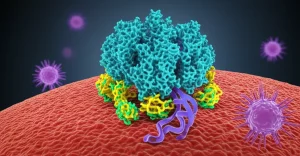Quando l’Età si Vede: Il Ballo Delicato tra Terapeuta Giovane e Paziente Anziano
Parliamoci chiaro, la questione di quanto un terapeuta debba o possa rivelare di sé, volontariamente o meno, è un tema caldo da decenni nel nostro campo. Ma c’è una situazione particolare che spesso mette in difficoltà noi giovani terapeuti, specialmente all’inizio della carriera: lavorare con pazienti anziani. Qui entra in gioco quella che potremmo chiamare “esposizione dedotta”.
Cosa intendo? Semplice: ci sono informazioni su di noi, come la nostra età, che non possiamo scegliere se rivelare o meno. Sono lì, evidenti, impresse sul nostro volto, nel nostro modo di muoverci. Il paziente le “deduce” senza che noi apriamo bocca. In questi casi, la sfida non è *se* rivelare, ma *come* gestire questa informazione in modo costruttivo per la terapia.
La letteratura scientifica, finora, non ci ha dato molti strumenti specifici per navigare queste acque, soprattutto quando la differenza d’età tra noi e il paziente è notevole. Ed è una situazione sempre più comune: oggi molti più anziani cercano un supporto psicologico, spinti magari dai familiari o dai cambiamenti sociali e personali legati all’invecchiamento.
L’Età Che Non Si Può Nascondere: L’Esposizione Dedotta
L’invecchiamento porta con sé tante trasformazioni: le relazioni sociali diventano più importanti, ma la rete sociale tende a restringersi, portando a volte a sentimenti di solitudine. Emozioni come ansia e depressione possono farsi più frequenti. Eppure, la ricerca ci dice che gli anziani rispondono bene alla psicoterapia, a volte persino meglio dei pazienti più giovani!
Il punto è che spesso si trovano di fronte un terapeuta visibilmente più giovane, magari “più giovane dei miei nipoti”, come dicono alcuni. Questa differenza d’età, questa “esposizione dedotta”, porta con sé un carico di significati, aspettative e potenziali pregiudizi. Uno dei più comuni è la percezione, da parte del paziente (e a volte anche nostra), di una nostra presunta mancanza di “esperienza di vita”.
Ricordo ancora Hanna (nome di fantasia, ovviamente), una donna sulla sessantina che incontrai durante il mio tirocinio. Appena entrata nella stanza, mi squadrò e l’odio fu quasi palpabile. Ero giovane, ansiosa, e lei era lì perché suo marito era depresso e lei non sapeva come gestire la situazione. Passò tutta la seduta a cambiare sedia (sei volte!), accusandomi di essere troppo giovane, carina e incapace di capire il suo dolore. La mia ansia schizzò alle stelle. Cercai di commentare il suo (e mio) disagio, ma la feci solo infuriare di più. Alla fine, chiese di essere trasferita a un terapeuta più esperto, e la sua richiesta fu accolta. Non fu facile per me capire Hanna, forse perché ero single all’epoca, o forse perché eravamo entrambe così spaventate. Questo episodio mi ha insegnato quanto sia complesso l’incontro tra un paziente anziano con tanta esperienza di vita e un terapeuta giovane e alle prime armi.
La chiave, credo, sta nella nostra capacità di mentalizzare i significati che il paziente attribuisce alla nostra età e alle informazioni che “deduce” da noi. Dobbiamo essere aperti a esplorare queste dinamiche, magari con l’aiuto della supervisione, senza metterci sulla difensiva.

Aprirsi o Non Aprirsi? Il Dilemma della Self-Disclosure (Rivelazione di Sé)
Il concetto di “esposizione dedotta” si intreccia, ma non coincide perfettamente, con quello più noto di self-disclosure, ovvero la rivelazione volontaria di informazioni personali da parte del terapeuta. La self-disclosure è stata dibattuta fin dai tempi di Freud, che la sconsigliava per non “inquinare” il transfert del paziente. Oggi, però, l’approccio è più sfumato.
Certo, una self-disclosure eccessiva o inappropriata può essere dannosa: può spostare il focus dal paziente, appesantirlo con i nostri problemi, confondere i ruoli. Ma, se usata con criterio, può avere effetti molto positivi:
- Rafforza l’alleanza terapeutica, creando fiducia e rapporto.
- Normalizza le esperienze del paziente, riducendo isolamento e vergogna.
- Offre un modello di comportamento e strategie di coping efficaci.
- Può mettere a proprio agio pazienti molto stressati, specialmente all’inizio.
Il punto cruciale con l’esposizione dedotta (come la nostra giovane età) è che avviene immediatamente, prima ancora che si sia formata un’alleanza terapeutica solida. Non possiamo scegliere il “quando” rivelare la nostra età. È lì, sotto gli occhi del paziente fin dal primo minuto. Questo ci costringe a confrontarci subito con le reazioni e le interpretazioni del paziente.
Pensiamo all’esempio della gravidanza di una terapeuta. Anche questa è una forma di esposizione “inevitabile” (dopo un certo punto), che porta con sé mille significati per il paziente, legati alla vita, alla sessualità, alle tappe esistenziali. Ma di solito la terapeuta ha un po’ di margine per decidere *quando* comunicarlo. Con l’età, questo margine non c’è.
In un caso seguito in supervisione, una giovane terapeuta incinta temeva di turbare una paziente anziana che non aveva potuto avere figli. Invece, parlandone apertamente, la paziente mostrò preoccupazione ed empatia, sentendosi coinvolta e rafforzando il legame. Questo dimostra come affrontare apertamente l’esposizione, anche quella “dedotta”, possa favorire l’intimità e la crescita.
Le Sfide sul Campo: Quando l’Età Conta
Lavorare con pazienti molto più anziani di noi ci mette di fronte a sfide specifiche, legate proprio a questa differenza d’età percepita:
- La “mancanza di esperienza di vita”: Il paziente può dubitare della nostra competenza su temi come la malattia, la perdita, l’ansia di morte, semplicemente perché non li abbiamo (ancora) vissuti sulla nostra pelle. Questo può essere visto come un limite, ma anche come un’opportunità: riconoscere l’esperienza unica del paziente, assumere una posizione di curiosità e valorizzare la sua saggezza.
- Il divario generazionale e culturale: I pazienti anziani hanno vissuto eventi storici, cambiamenti sociali e culturali che noi conosciamo solo dai libri. Questo può creare difficoltà di comunicazione e comprensione reciproca (pensiamo a temi come il divorzio, vissuto diversamente decenni fa). È fondamentale un ascolto attivo e validante, anche senza aver “vissuto” le stesse cose.
- I confronti inevitabili: La nostra giovinezza può rappresentare per il paziente tutto ciò che ha perso o non ha avuto: salute, opportunità, futuro. Questo può scatenare invidia, gelosia, tristezza. È un terreno emotivo delicato da esplorare insieme.
- Controtransfert e Ageismo: Le nostre reazioni emotive (controtransfert) verso il paziente anziano possono essere influenzate da conflitti irrisolti legati ai nostri genitori/nonni, alla nostra idea di invecchiamento e morte, e da pregiudizi legati all’età (ageismo). Riconoscere questi aspetti in supervisione è cruciale per non agire comportamenti discriminatori, come dare per scontato che la sessualità non sia più importante per loro.
- Transfert “inverso”: A volte, il paziente può vederci non come una figura genitoriale, ma come un figlio o nipote. Questo può essere spiazzante sia per noi che per loro, mettendo in discussione il nostro ruolo e la possibilità per il paziente di esprimere i propri bisogni infantili.
- Ambiguità e Diffidenza: L’ambivalenza verso la terapia può essere accentuata negli anziani da preoccupazioni economiche, paura di essere giudicati (specialmente se si “parla male” dei familiari), timore della dipendenza crescente o vissuti di diffidenza verso un mondo che cambia troppo in fretta. Noi giovani terapeuti, magari insicuri, possiamo interpretare questa ambivalenza come un rifiuto personale, chiudendoci o diventando eccessivamente rigidi.

Strategie Vincenti: Trasformare l’Ostacolo in Risorsa
Allora, come possiamo noi, giovani terapeuti, navigare queste complessità e usare l’esposizione dedotta a vantaggio della terapia? Ecco qualche spunto emerso dalla pratica e dalla supervisione:
- Usare il controtransfert come bussola: Le nostre reazioni emotive, anche quelle scomode, possono dirci molto sui bisogni profondi del paziente. Sentire tristezza per le opportunità perdute dal paziente può aiutarci a connetterci empaticamente con il suo lutto. Portare queste emozioni in supervisione è fondamentale.
- Trovare modi giocosi e non difensivi per affrontare il divario: L’umorismo e la leggerezza, usati con sensibilità, possono stemperare la tensione e l’aggressività. Rispondere con ironia alla battuta “hai ancora il latte sulle labbra” può aprire un dialogo sull’età invece di chiuderlo. Normalizzare l’ansia (nostra e del paziente) legata al gap generazionale è importante.
- Adottare il modello dei “due esperti”: Riconoscere che nella stanza ci sono due esperti: noi, con la nostra formazione tecnica, e il paziente, con la sua saggezza derivata dall’esperienza di vita. Questo trasforma la nostra “mancanza di esperienza” da limite a punto di forza, valorizzando il sapere del paziente e invitandolo a condividere la responsabilità del percorso.
- Mantenere il focus sul paziente e chiarire il setting: Anche quando l’esposizione della nostra età (o altre informazioni) sembra allentare i confini, è vitale mantenere la struttura terapeutica. Esplicitare regole, orari, pagamenti e usare routine riconoscibili (es. domande di apertura/chiusura) aiuta a definire il contenitore sicuro in cui il paziente può esplorare liberamente il suo mondo interno, senza che la nostra persona prenda il sopravvento. Lavorare sull’ambivalenza apertamente, senza temerla, rafforza l’alleanza.
La supervisione, in tutto questo, gioca un ruolo chiave. Aiuta noi giovani terapeuti a gestire l’ansia, a riconoscere e usare il controtransfert, a sfidare i nostri pregiudizi sull’età, a imparare dall’esperienza e a trovare modi creativi per usare anche le nostre vulnerabilità a beneficio del paziente.
Come disse una paziente anziana a una giovane collega alla fine di una seduta particolarmente intensa: “È stato davvero un buon incontro, sono sorpresa. Lei è così giovane, e io sono vecchia; come ha fatto a capirmi?”. La risposta della terapeuta fu semplice e potente: “Mi ha insegnato lei. Grazie.”
Ecco, in questo scambio c’è tutto: il riconoscimento del divario, la volontà di discuterne, la sorpresa della scoperta reciproca e il posizionamento non gerarchico che valorizza l’esperienza di entrambi. Un bel modo, credo, per affrontare questo affascinante ballo tra generazioni diverse nella stanza di terapia.
Fonte: Springer