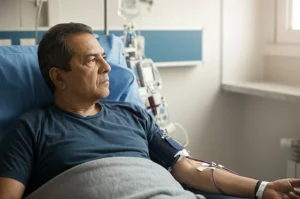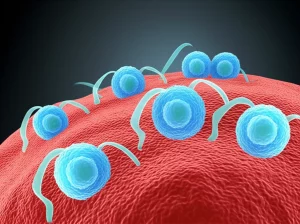Surufatinib: Una Nuova Freccia nell’Arco Contro i Tumori Solidi Avanzati? La Mia Analisi da Appassionato!
Ciao a tutti! Oggi voglio portarvi con me in un viaggio affascinante nel mondo della ricerca oncologica, un campo che, diciamocelo chiaramente, è in continua ebollizione e ci regala speranze sempre nuove. Mi sono imbattuto di recente in uno studio che ha catturato la mia attenzione, uno di quelli che ti fa pensare: “Wow, forse ci siamo!”. Parlo del Surufatinib, un nome che magari non dirà molto ai più, ma che potrebbe rappresentare un’interessante novità per chi lotta contro certi tipi di tumori solidi avanzati.
Ma cos’è esattamente questo Surufatinib?
Immaginate un farmaco intelligente, una piccola molecola sviluppata proprio qui, in Cina, che agisce come un cecchino di precisione. Il Surufatinib è un inibitore della tirosin-chinasi (TKI, per gli amici del settore) che prende di mira specifici “interruttori” delle cellule tumorali: il recettore del fattore di crescita endoteliale vascolare (VEGFR), il recettore 1 del fattore di crescita dei fibroblasti (FGFR1) e il recettore del fattore stimolante le colonie-1 (CSF-1R). In parole povere? Blocca i meccanismi che permettono al tumore di crearsi nuovi vasi sanguigni per nutrirsi (la famosa angiogenesi tumorale) e, di conseguenza, ne frena la crescita. Mica male, eh?
Questo farmaco ha già ricevuto il via libera per il trattamento dei tumori neuroendocrini, sia quelli pancreatici (PNEN) che quelli non pancreatici (N-pNEN), e i risultati degli studi precedenti (SANET-p e SANET-ep) sono stati davvero incoraggianti, tanto da cambiare le carte in tavola per queste patologie. Ma la domanda che si sono posti i ricercatori, e che mi ha incuriosito, è: “Potrebbe funzionare anche per altri tipi di tumori solidi avanzati?”. Ed è qui che entra in gioco lo studio “real world” che voglio analizzare con voi.
Uno Sguardo da Vicino allo Studio “Real World”
Lo studio che ho letto è di tipo retrospettivo, condotto presso l’Ospedale Provinciale del Popolo di Zhejiang tra gennaio 2021 e aprile 2024. Hanno raccolto i dati clinici e di follow-up di 28 pazienti con tumori solidi avanzati, tutti trattati con Surufatinib. L’obiettivo? Valutare l’efficacia e la sicurezza del farmaco nella pratica clinica quotidiana, al di fuori dei rigidi protocolli degli studi clinici controllati.
I pazienti inclusi dovevano avere una diagnosi confermata di tumore solido avanzato, essere in stadio IV con lesioni misurabili, aver ricevuto almeno un ciclo di Surufatinib e avere un’aspettativa di vita di almeno 3 mesi. Insomma, pazienti con una situazione clinica già complessa.
L’efficacia è stata valutata tramite TAC con mezzo di contrasto, seguendo i criteri RECIST 1.1, che classificano la risposta al trattamento in:
- Risposta Completa (CR): sparizione di tutte le lesioni.
- Risposta Parziale (PR): riduzione significativa delle lesioni.
- Malattia Stabile (SD): né miglioramento né peggioramento significativo.
- Progressione di Malattia (PD): aumento delle lesioni o comparsa di nuove.
Da questi dati si calcolano poi l’Objective Response Rate (ORR), cioè la percentuale di pazienti con CR o PR, e il Disease Control Rate (DCR), che include anche i pazienti con SD. E poi, ovviamente, si guarda alla sopravvivenza: la sopravvivenza libera da progressione (mPFS) e la sopravvivenza globale (mOS).
I Risultati: Luci e Ombre
Allora, cosa è emerso da questo studio? Vediamo un po’ i numeri. Su 28 pazienti:
- Nessuna Risposta Completa (0.0%)
- 5 Risposte Parziali (17.9%)
- 7 Malattie Stabili (25.0%)
- 16 Progressioni di Malattia (57.1%)
Questo si traduce in un ORR del 17.9% e un DCR del 42.9%. Non sono numeri da capogiro a prima vista, ma dobbiamo sempre considerare che parliamo di pazienti con malattia avanzata, spesso refrattari ad altre terapie.
La cosa si fa più interessante se suddividiamo per tipo di tumore:
- Pazienti con Tumori Neuroendocrini Pancreatici (PNEN, 9 pazienti): ORR del 33.3%, DCR del 66.7%. La mPFS è stata di 11 mesi e la mOS di 17 mesi. Questi dati sono abbastanza in linea con lo studio SANET-p, il che è rassicurante!
- Pazienti con Tumori Neuroendocrini Non-Pancreatici (N-pNEN, 7 pazienti): ORR del 14.3%, DCR del 42.3%. Qui la mPFS è stata di 6 mesi e la mOS di 7 mesi. La mPFS è risultata inferiore rispetto ai 9.2 mesi dello studio SANET-ep, ma gli autori sottolineano che il campione era piccolo, quindi i risultati sono da prendere con le pinze e necessitano di ulteriori conferme. Potrebbe indicare una prognosi peggiore per i N-pNEN, ma è presto per dirlo.
- Pazienti con Altri Tipi di Tumore (12 pazienti): ORR dell’8.3%, DCR del 25%. La mPFS è stata di 2 mesi e la mOS di 2 mesi. Qui i risultati sono meno entusiasmanti, ma è un gruppo molto eterogeneo.

Un dato curioso: analizzando i fattori prognostici per i pazienti con tumori neuroendocrini, è emerso che avere meno di 3 siti metastatici, un buon performance status (ECOG PS 0-1) e livelli basali di acidi grassi liberi (FFA) > 635.5 µmol/L erano associati a una sopravvivenza globale più lunga. Avere meno di 3 metastasi era anche legato a una PFS più lunga. Questi sono spunti interessanti che meriterebbero approfondimenti.
E la Sicurezza? Un Profilo Gestibile
Passiamo ora a un aspetto cruciale: gli effetti collaterali. Nessun farmaco ne è esente, e il Surufatinib non fa eccezione. Le reazioni avverse più comuni riportate nello studio sono state:
- Ipoproteinemia (bassi livelli di proteine nel sangue)
- Proteinuria (presenza di proteine nelle urine)
- Soppressione del midollo osseo
- Tossicità gastrointestinale
La buona notizia è che la maggior parte di questi effetti è stata di grado 1 o 2, quindi lievi o moderati e generalmente gestibili. Solo in rari casi si sono verificati eventi di grado 3 o superiore (proteinuria e reazioni gastrointestinali nel 7.1% dei casi), che si sono risolti con trattamenti sintomatici o con la sospensione del farmaco. Non sono stati osservati eventi avversi di grado 4 o superiore. Questo è un punto a favore, perché un farmaco, per quanto efficace, deve anche essere tollerabile dal paziente.
Interessante notare come l’incidenza di reazioni cutanee, come la sindrome mano-piede, sia risultata inferiore rispetto ad altri farmaci simili. Questo potrebbe essere legato a differenze nel profilo dei pazienti o nelle terapie precedenti ricevute.
Surufatinib vs. Fruquintinib: Un Breve Confronto
Gli autori dello studio fanno un breve parallelo con un altro TKI, il Fruquintinib, anch’esso sviluppato da Hutchison Whampoa Pharma. Entrambi sono inibitori tirosin-chinasici, ma con qualche differenza. Il Surufatinib ha un profilo di inibizione più ampio, andando a colpire, oltre ai VEGFR, anche FGFR1 e CSF-1R, mentre il Fruquintinib si concentra principalmente sui VEGFR-1, -2, e -3. Questo potrebbe tradursi in meccanismi d’azione leggermente diversi e, potenzialmente, in efficacia su spettri tumorali differenti.
Un altro aspetto tecnico, ma non meno importante, riguarda la farmacocinetica. Il Surufatinib sembra avere una concentrazione plasmatica massima (Cmax) più alta rispetto al Fruquintinib, ma un’emivita (t1/2, il tempo che impiega il corpo a eliminare metà del farmaco) più breve. Questo, secondo gli autori, potrebbe ridurre il rischio di accumulo di tossicità del farmaco nell’organismo. Sono dettagli, ma fanno la differenza nella gestione clinica.
Dosaggio e Prospettive Future
Un punto che mi ha fatto riflettere è la questione del dosaggio. La dose standard di Surufatinib è di 300 mg al giorno. Tuttavia, nello studio si è visto che solo il 21.4% dei pazienti ha mantenuto questa dose, con riduzioni dovute principalmente a eventi avversi o a scelte terapeutiche in caso di terapie combinate. Addirittura, un paziente con tumore pancreatico ha ottenuto una risposta parziale con soli 100 mg di Surufatinib. Questo solleva una domanda: è sempre necessaria la dose piena di 300 mg? I pazienti che hanno ricevuto la dose standard hanno mostrato un ORR del 50.0% e un DCR del 66.7%, tassi significativamente più alti rispetto al gruppo con dose ridotta (ORR: 9.1%; DCR: 36.4%), sebbene le differenze non fossero statisticamente significative, probabilmente a causa del piccolo numero di pazienti.
È chiaro che servono studi più ampi per capire meglio il dosaggio ottimale per i diversi tipi di tumore e per confermare questi risultati preliminari, specialmente per i tumori diversi dai neuroendocrini. Lo studio stesso riconosce i suoi limiti: è retrospettivo, monocentrico e con un campione ridotto. Questo può influenzare la stabilità dei dati. Per questo, come sottolineano gli stessi ricercatori, c’è un disperato bisogno di studi prospettici, multicentrici e con campioni più grandi per definire meglio il ruolo del Surufatinib.
Nonostante ciò, il Surufatinib ha dimostrato un’efficacia promettente nei pazienti con PNEN e N-pNEN, e un certo potenziale terapeutico anche in altri tumori solidi avanzati, il tutto con un profilo di tossicità generalmente gestibile. Per i pazienti con tumori solidi avanzati che non rispondono più alle terapie standard, avere una nuova opzione terapeutica è sempre una notizia importante.
Personalmente, trovo che studi come questo, pur con i loro limiti, siano fondamentali. Ci offrono uno spaccato della “vita reale” dei farmaci, al di là dei trial clinici, e aprono la strada a ulteriori ricerche. Il Surufatinib si aggiunge quindi all’arsenale di farmaci mirati, e non vedo l’ora di leggere i risultati di studi futuri che ne esploreranno ulteriormente le potenzialità. La lotta contro il cancro è una maratona, non uno sprint, e ogni passo avanti, piccolo o grande che sia, conta!
Fonte: Springer