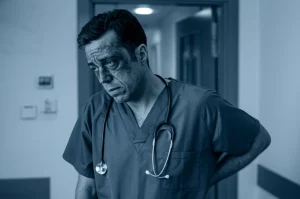NAKO: Viaggio nel Cuore della Salute Tedesca – Reclutamento, Risposte e Segreti dei Dati
Ciao a tutti! Oggi voglio portarvi dietro le quinte di un progetto davvero mastodontico, uno di quelli che cerca di capire come stiamo, cosa ci fa ammalare e come potremmo vivere meglio e più a lungo. Parliamo della German National Cohort, o NAKO, come la chiamiamo noi addetti ai lavori. È la più grande ricerca epidemiologica mai fatta in Germania, un’impresa titanica che ha coinvolto centinaia di migliaia di persone. Ma come si fa a mettere in piedi una cosa del genere? E soprattutto, come si convincono le persone a partecipare? Ve lo racconto io, con un linguaggio semplice e diretto.
Cos’è la NAKO e Perché è Importante?
Immaginate di voler scattare una fotografia super dettagliata della salute di un’intera nazione, o almeno di una sua fetta rappresentativa. Ecco, la NAKO fa proprio questo. Tra il 2014 e il 2019, abbiamo bussato (virtualmente e non) alla porta di oltre 1,3 milioni di tedeschi tra i 20 e i 69 anni, selezionati a caso in 16 diverse regioni della Germania. L’obiettivo? Studiare le cause delle malattie croniche più diffuse – pensate al diabete, alle malattie cardiovascolari, ai tumori, alle demenze. Capire perché insorgono, chi colpiscono di più e come prevenirle o diagnosticarle precocemente. Un lavoro ambizioso, coordinato da una rete di 18 centri studio sparsi per il paese, un vero sforzo collettivo del mondo scientifico tedesco.
L’Impresa del Reclutamento: Come Abbiamo Fatto?
Mettere insieme oltre 200.000 partecipanti (questo era il nostro obiettivo iniziale, e ci siamo arrivati!) non è stata una passeggiata. Abbiamo seguito un protocollo di reclutamento super standardizzato. Tutto iniziava con una lettera d’invito spedita per posta, insieme a un opuscolo informativo e una busta preaffrancata per rispondere. Se la persona era interessata, poteva rimandare indietro il modulo o chiamare direttamente il centro studi locale.
E se non rispondeva? Niente paura, avevamo il piano B (e C!): due lettere di sollecito a distanza di un paio di settimane. Per chi avevamo il numero di telefono (trovato tramite elenchi pubblici o commerciali), facevamo fino a cinque tentativi di contatto telefonico. L’ultimo passo era una lettera intitolata “La tua ultima occasione per partecipare”, che includeva anche un questionario per capire perché le persone decidevano di non aderire.
Ogni centro studi aveva un po’ di margine per personalizzare l’invito, magari aggiungendo una lettera di supporto da parte di autorità locali o personaggi famosi. Alcuni offrivano rimborsi per i trasporti o buoni parcheggio, altri cercavano di coinvolgere i datori di lavoro per concedere permessi retribuiti. Insomma, abbiamo cercato di rendere la partecipazione il più agevole possibile.
Il tutto era gestito e documentato da un software specifico, MODYS, che tracciava ogni singola interazione: lettere inviate, telefonate fatte, risposte ricevute. Un tesoro di dati non solo sui partecipanti, ma anche sul processo stesso di reclutamento (quelli che noi chiamiamo paradata).

I Numeri Parlano Chiaro: Chi Ha Risposto (e Chi No)?
E qui arriviamo al punto dolente, ma anche affascinante. Nonostante tutti gli sforzi, la risposta generale è stata del 15,6%. Sembra poco? Beh, diciamocelo, convincere le persone a dedicare tempo (e campioni biologici!) alla ricerca non è facile, e la tendenza alla partecipazione è in calo da decenni un po’ ovunque nel mondo. Questo tasso, anche se inferiore alle aspettative iniziali (puntavamo al 50%!), è in linea con altre grandi coorti avviate di recente in altri paesi. Studi tedeschi più vecchi avevano tassi più alti, ma parliamo di reclutamenti fatti oltre 20 anni fa.
La cosa interessante è che la risposta non è stata uniforme: variava tantissimo da centro a centro, dal 7,6% di Berlino-Süd al 30,7% di Augsburg! E non siamo riusciti a spiegare queste differenze solo guardando a quante lettere di sollecito o telefonate in più faceva un centro rispetto a un altro. Sembra che le chiamate attive abbiano aiutato un po’, ma non è stata la bacchetta magica.
Abbiamo però notato dei trend comuni:
- Le donne hanno partecipato più degli uomini (17,5% contro 14,1%).
- La partecipazione aumentava con l’età: dal 10,2% tra i più giovani (20-29 anni) fino al 20,7% tra i più grandi (60-69 anni). Questo in parte era voluto, perché abbiamo volutamente “sovra-campionato” le fasce d’età più adulte, dove le malattie croniche sono più frequenti.
- La risposta era più alta nelle aree rurali (22,3%) rispetto alle città e periferie (17,2%) e alle grandi città (14,5%).
E chi non ha partecipato? La maggior parte semplicemente non ha mai risposto (oltre il 50% degli invitati!). Un altro 23% circa ha rifiutato esplicitamente, per vari motivi (mancanza di tempo, disinteresse, preoccupazioni sulla privacy…). Una piccola percentuale non era idonea (deceduti, trasferiti, non parlavano tedesco senza traduttore) o non è stato possibile determinarne l’idoneità (indirizzo sconosciuto).
Il Ritratto dei Partecipanti: Un Campione Rappresentativo?
Questa è la domanda chiave. Se partecipa solo una fetta della popolazione invitata, questa fetta assomiglia al resto della popolazione? Confrontando i nostri partecipanti con i dati generali della popolazione nelle regioni studiate, abbiamo visto delle differenze:
- I partecipanti con bassa e media istruzione erano sottorappresentati, mentre quelli con alta istruzione erano sovrarappresentati.
- Anche le persone con nazionalità non tedesca e con un background migratorio erano sottorappresentate.
- Chi viveva da solo era sottorappresentato, mentre chi viveva in famiglie più numerose (2 o più persone) era sovrarappresentato.
Questi risultati non sono sorprendenti, anzi, confermano un trend noto: chi partecipa alla ricerca sulla salute tende ad avere uno status socio-economico più alto e forse uno stile di vita più sano (il cosiddetto “healthy volunteer bias”). C’è da dire che alcune di queste differenze (istruzione, dimensione del nucleo familiare) potrebbero essere in parte legate alla nostra scelta di includere più persone anziane, che hanno caratteristiche diverse dai giovani.

Il Trucco della Ponderazione: Come Rendere i Dati Affidabili?
Se il nostro campione non è uno specchio perfetto della popolazione, come facciamo a ottenere stime affidabili, per esempio sulla prevalenza di una malattia? Qui entrano in gioco i pesi campionari (survey weights). È una tecnica statistica che assegna un “peso” diverso a ciascun partecipante. L’idea è di dare più importanza ai gruppi sottorappresentati e meno importanza a quelli sovrarappresentati, per far sì che il campione “pesato” assomigli di più alla popolazione di riferimento.
Noi della NAKO forniamo questi pesi insieme ai dati. Li abbiamo calcolati in due passaggi:
- Pesi di disegno: correggono per il fatto che non tutti avevano la stessa probabilità di essere selezionati all’inizio (a causa della stratificazione per età e sesso e del campionamento complesso).
- Pesi di calibrazione: aggiustano per le differenze tra chi ha partecipato e chi no, usando variabili come età, sesso, nazionalità, background migratorio, istruzione e dimensione del nucleo familiare, confrontandole con i dati ufficiali del Microcensimento tedesco per ogni distretto amministrativo.
È fondamentale usare questi pesi quando si vogliono fare stime descrittive (quanti diabetici ci sono? qual è l’esposizione media a un fattore di rischio?) da generalizzare alla popolazione delle regioni studiate. Attenzione: non abbiamo la pretesa che il campione sia rappresentativo dell’intera Germania (le regioni non sono state scelte a caso), ma della popolazione specifica da cui abbiamo attinto in quelle 16 aree. Per analisi più complesse, come quelle sulle cause delle malattie (ricerca eziologica), l’uso dei pesi è meno cruciale e va deciso caso per caso.
Cosa Ci Dice Tutto Questo (e Cosa Non Ci Dice)?
Insomma, reclutare per uno studio come la NAKO è stato un lavoraccio, con risultati che riflettono le sfide attuali della ricerca epidemiologica. La bassa risposta è un dato di fatto, ma non invalida necessariamente lo studio, soprattutto per la ricerca sulle cause delle malattie. Le differenze tra i partecipanti e la popolazione generale ci sono, ma possiamo affrontarle statisticamente con la ponderazione per ottenere stime descrittive più accurate a livello regionale.
Le grandi variazioni tra i centri studio, nonostante un protocollo standard, suggeriscono che fattori locali, forse legati alla fiducia nelle istituzioni, alle infrastrutture o a dinamiche specifiche del reclutamento, giocano un ruolo importante che merita ulteriori indagini. I paradata raccolti con MODYS saranno preziosi per questo.
Guardando al Futuro: La Sfida della Fedeltà
Ora che la fase di reclutamento iniziale è conclusa, la sfida si sposta: dobbiamo mantenere i nostri preziosi partecipanti coinvolti per i follow-up futuri. La NAKO è uno studio longitudinale, il suo vero valore sta nel seguire le persone nel tempo. Motivare le persone a restare “fedeli” alla ricerca è forse ancora più difficile che convincerle a entrare.
Dobbiamo trovare modi nuovi per comunicare con loro, offrire benefici tangibili (come informazioni sulla loro salute), farli sentire parte integrante del processo scientifico. Le nuove tecnologie digitali possono aiutare, ma alla fine conta molto la motivazione personale: contribuire al progresso scientifico, saperne di più sulla propria salute, curiosità verso la ricerca. Su questo dobbiamo continuare a lavorare.
La NAKO, con i suoi oltre 205.000 partecipanti e la ricchezza di dati raccolti, resta comunque un patrimonio inestimabile per capire e migliorare la salute in Germania e non solo. Un viaggio appena iniziato!
Fonte: Springer