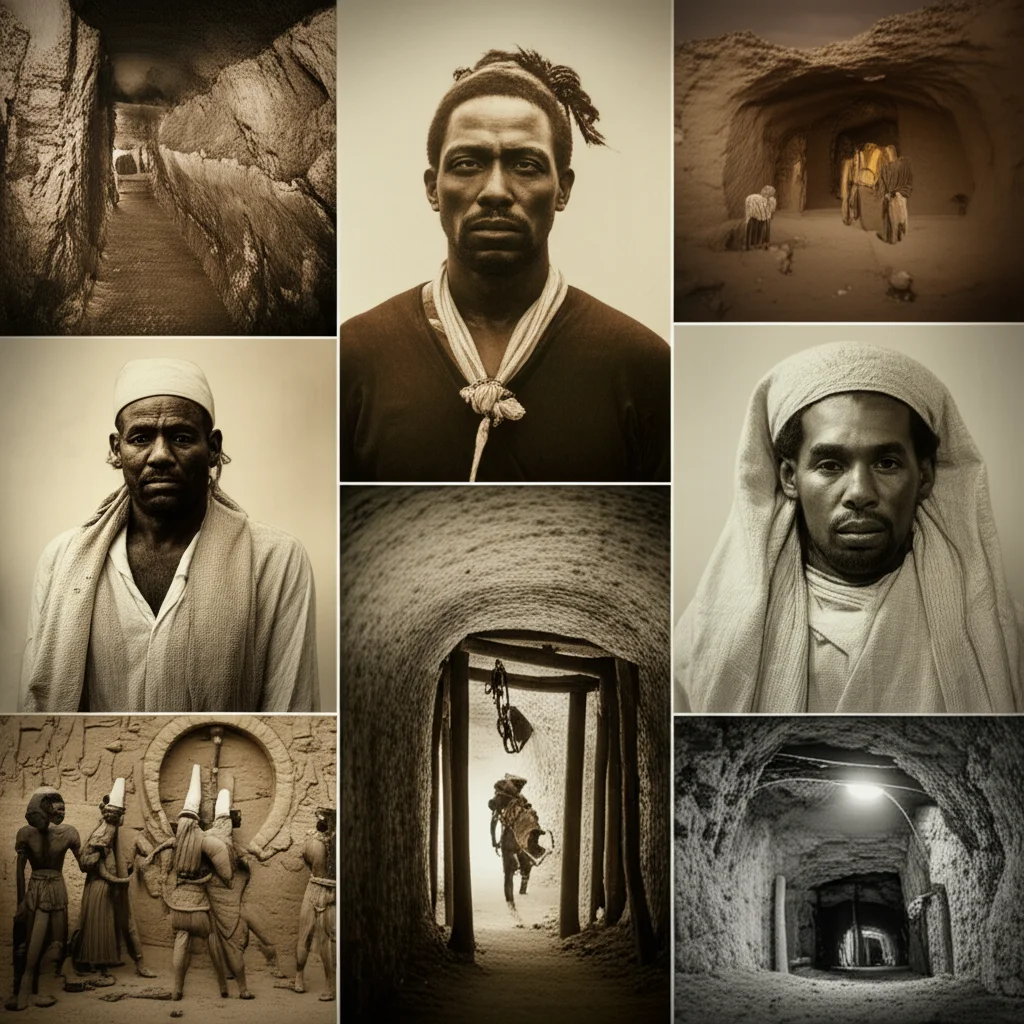Africa: Un Viaggio Millenario nella Salute sul Lavoro, tra Sfruttamento e Speranza
Ciao a tutti! Oggi voglio portarvi in un viaggio affascinante, un po’ insolito forse, ma incredibilmente importante: la storia della salute sul lavoro nel continente africano. Pensateci un attimo: l’Africa è la culla dell’umanità, eppure, quante volte ci siamo soffermati a riflettere sulle condizioni di chi ha faticato e costruito in quelle terre, millennio dopo millennio? Pochissimo, vero? Ecco, è proprio di questo che voglio parlarvi, un percorso che parte dall’antico Egitto, attraversa imperi e colonizzazioni, fino ad arrivare alle sfide dei giorni nostri.
Adottare una prospettiva storica, vedrete, ci aiuterà a capire meglio non solo il presente, ma anche a immaginare il futuro della salute e sicurezza per milioni di lavoratori africani. È una storia fatta di luci e, purtroppo, di molte ombre, segnata spesso da condizioni di lavoro durissime, specialmente nell’estrazione mineraria. Lo sfruttamento coloniale, poi, ha spesso peggiorato problemi già esistenti, lasciando un’eredità con cui si fa i conti ancora oggi.
L’Antico Egitto: Pionieri a Sorpresa della Medicina del Lavoro?
Partiamo da lontano, dall’antico Egitto. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, l’economia egizia non si basava prevalentemente sulla schiavitù. Certo, c’erano schiavi, ma per i grandi progetti – spedizioni militari, miniere, cave e costruzioni imponenti come le piramidi – spesso si reclutavano lavoratori dalla popolazione generale. Immaginate i contadini, per esempio: durante le piene del Nilo, quando non potevano coltivare, venivano “arruolati” per queste opere colossali. E sapete una cosa? Venivano pagati! Il salario dipendeva dalle loro abilità e dal loro status sociale.
Ma la cosa ancora più sorprendente è che esistevano servizi sanitari dedicati. Sì, avete capito bene: medici per i lavoratori! Le fonti scritte, insieme a pitture e sculture nelle tombe, ci raccontano di condizioni di lavoro estreme: caldo torrido, sforzi fisici immani, esposizione a materiali pericolosi. Non stupisce che ci fossero proteste e scioperi, come documentato dal famoso “Papiro dello Sciopero” (1187–1157 a.C.), dove i lavoratori lamentavano compensi e cibo inadeguati.
Nella vasta necropoli di Tebe, il caposquadra teneva un registro meticoloso delle assenze per malattia o infortunio. Questo ci dice che c’era un principio, quasi moderno, di concedere riposo ai malati. Addirittura, a Tebe c’era un medico che accompagnava i lavoratori, una sorta di antesignano del medico del lavoro di oggi! Questi medici non solo curavano ferite, ma davano consigli sull’alimentazione (grano, orzo, cipolle) e sull’organizzazione del lavoro, con turni che non superavano le 8 ore. Il Papiro Edwin Smith (circa 1600-1500 a.C.) è una miniera d’oro di informazioni sulla diagnosi e il trattamento di traumi, fratture e lesioni oculari, problemi tipici di chi svolgeva lavori pesanti. E le pitture nella tomba dello scultore Ipuy (circa 1279–1213 a.C.) mostrano interventi medici come la riduzione di fratture e la cura di malattie degli occhi. Un quadro davvero completo!
Certo, non era tutto rose e fiori. I minatori nel deserto, molti dei quali schiavi di guerra, probabilmente inalavano polvere di silice, come suggeriscono le analisi istologiche dei polmoni dell’epoca. Pescatori e contadini affrontavano morsi di animali, infezioni parassitarie e punture d’insetto. Artigiani come scultori e falegnami avevano i loro problemi respiratori. La “Satira dei Mestieri” (circa 1900-1800 a.C.) descrive vividamente le dure condizioni di un vasaio, sottolineando i problemi di qualità dell’aria. I panettieri rischiavano ustioni e problemi respiratori (l’asma da farina!), mentre gli imbalsamatori soffrivano di patologie spinali e infezioni. È chiaro che i lavoratori egizi si ammalavano e si infortunavano a causa del loro mestiere, e l’assenza di protezioni individuali o collettive non aiutava. L’introduzione di medici del lavoro, pagati dal faraone o dagli appaltatori, fu un modello unico per l’epoca, un approccio quasi paternalistico che non troviamo in altre civiltà antiche come Grecia e Roma, forse per la loro diversa struttura sociale e il ruolo più dominante della schiavitù.

Dal Nilo al Maghreb: L’Eredità Greco-Romana e Islamica
Con la conquista di Alessandro Magno nel 332 a.C., l’Egitto e il Nord Africa entrarono nell’orbita culturale greco-romana per oltre un millennio. Questo significò anche una fusione tra la tradizione medica egizia e quella greco-romana. Nel periodo tolemaico, i papiri medici mostrano pratiche sincretiche di origine egizia, ebraica, greca e, infine, cristiana. Purtroppo, le testimonianze scritte sulla salute dei lavoratori di quel periodo sono scarse, ma possiamo immaginare che alcune pratiche egizie siano sopravvissute a livello locale. La mancanza di grandi progetti infrastrutturali statali probabilmente segnò la fine dell’apparato di sanità del lavoro faraonico. Durante l’epoca romana, Alessandria perse un po’ del suo smalto come centro scientifico, ma gli scheletri rinvenuti a Mons Claudianus (un insediamento legato a cave di granodiorite nel deserto egiziano orientale) mostrano segni di sollevamento pesi continui e duro esercizio fisico, come nodi di Schmorl e osteofitosi, ma nessuna prova di carenze alimentari.
L’arrivo dell’Islam nel VII secolo portò un’altra ondata di influenze. La medicina islamica, costruita anch’essa sull’eredità greco-romana, non fu una rottura traumatica. I medici islamici furono profondamente influenzati da Galeno e Ippocrate. Tradussero i testi greci in arabo e poi produssero nuova conoscenza medica, sistematizzando il vasto e talvolta incoerente sapere greco-romano in enciclopedie e sommari. Il “Canone della Medicina” di Ibn Sina (Avicenna, circa 980–1037) è un esempio lampante: tradotto in latino, divenne un testo fondamentale in Europa e nel mondo musulmano, con descrizioni di malattie che oggi definiremmo professionali. Pensate che nel XV e XVI secolo fu pubblicato in Europa più di 35 volte! Ad esempio, una delle cause di dispnea (“usrun nafas” nel Canone) è descritta come “secchezza o restringimento del polmone che può causare rigidità polmonare”, una possibile antica descrizione della pneumoconiosi.
Medici musulmani ed ebrei di Qayrawan (Kairouan, in Tunisia) nel X secolo scrissero opere in arabo che, tradotte in latino, formarono il nucleo dell’educazione medica in Europa fino al Rinascimento. Figure come Maimonide (1138–1204), rabbino, filosofo e medico personale del Saladino, vissuto per gran parte della sua vita in Egitto, lasciarono un segno profondo. Il suo trattato “Regimen Sanitatis” sottolineava l’importanza della medicina preventiva, dell’igiene pubblica e, udite udite, della qualità dell’aria! Nel suo “Trattato sull’Asma”, Maimonide osservava che “…l’aria della città è stagnante, torbida e densa… si dovrebbe almeno scegliere per residenza un sito ampiamente aperto… i quartieri abitativi sono meglio situati a un piano superiore… i servizi igienici dovrebbero essere il più lontano possibile dalle aree abitative. L’aria dovrebbe essere mantenuta asciutta in ogni momento… La preoccupazione per l’aria pulita è la prima cosa per preservare la salute del corpo e dell’anima…”. Parole incredibilmente moderne, non trovate?
L’Impero Ottomano e le Prime Luci nell’Africa Sub-Sahariana
Dal XVI secolo, il Nord Africa fu annesso all’Impero Ottomano, dove iniziò un timido processo di industrializzazione. Nel 1865 fu pubblicato il “Regolamento Dilaver Paşa”, il primo tentativo di normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro ottomana (anche se poi non approvato dal Sultano). Questo documento di 100 articoli prevedeva l’assegnazione di medici e miglioramenti delle condizioni di lavoro, come un limite di 10 ore lavorative giornaliere, periodi di riposo e luoghi per dormire.
Nel frattempo, nell’Africa sub-sahariana, le testimonianze scritte sulla medicina erano scarsissime. L’esploratore scozzese Mungo Park, nei suoi “Viaggi nell’Interno dell’Africa” (1799), notava che, nonostante la longevità non fosse comune, le malattie sembravano poche. La dieta semplice e la vita attiva proteggevano da molti disturbi. Febbri e flussi erano i più comuni e fatali, ma osservò anche una certa abilità nel trattare fratture e lussazioni con stecche e bendaggi semplici.

L’Era Coloniale: Sfruttamento e Prime Consapevolezze
Arriviamo a un periodo cruciale e doloroso: l’era coloniale. Le politiche sanitarie in Africa si concentrarono principalmente sul controllo delle malattie infettive endemiche, come la malattia del sonno o la malaria, che minacciavano gli espatriati europei, le spedizioni militari e, in parte, le popolazioni locali. La letteratura scientifica sulla salute e sicurezza sul lavoro durante il colonialismo è sorprendentemente scarsa, con l’eccezione dell’industria mineraria in Sudafrica (di cui parleremo meglio dopo).
Un caso ben documentato riguarda le miniere di fosfati nei protettorati francesi del Nord Africa. In Tunisia, nella regione mineraria di Gafsa, uno studio affrontò i problemi di salute dei lavoratori della Compagnie des phosphates et des chemins de fer de Gafsa: infortuni sul lavoro (inclusi quelli “falsi”), infezioni da parassiti intestinali, rischi da polveri e la fluorosi dentale (“darmous”) nella popolazione circostante a causa dell’inquinamento ambientale da fluoro. In Marocco, l’estrazione industriale di fosfati iniziò negli anni ’20. Nel 1953, Jean Rodier documentò (anche con filmati!) il manganismo tra i minatori di fosfati e descrisse una serie di problemi di salute nelle miniere marocchine: condizioni di lavoro dure con alte temperature e umidità, malattie causate da piombo, manganese, antimonio, cobalto, arsenico, polveri inalate, basso ossigeno, gas tossici, fluoro e anchilostoma. Interessante notare che, dopo la scoperta dell’anchilostomiasi nel 1937, un programma intensivo di esami delle feci portò a una significativa riduzione dell’infestazione grazie a una migliore igiene e trattamenti. Rodier concluse con considerazioni piuttosto progressiste per l’epoca sulle misure preventive collettive e individuali.
Anche il dominio coloniale italiano, specialmente durante il fascismo, lasciò il segno. In Libia e nell’Africa Orientale Italiana, i lavoratori indigeni furono sottoposti a lavoro forzato in condizioni ambientali e lavorative terribili. Progetti infrastrutturali come strade, ferrovie e sviluppi agricoli esponevano i lavoratori africani a colpi di calore, malattie infettive, malnutrizione e malattie respiratorie. Nonostante la propaganda fascista esaltasse sistemi sanitari coloniali moderni ed efficienti, questi erano in gran parte orientati ai bisogni dei coloni italiani, con investimenti minimi per la salute della forza lavoro africana. In Eritrea, le politiche agricole coloniali italiane peggiorarono le condizioni sanitarie dei lavoratori, con alti tassi di malnutrizione e infezioni parassitarie. Un altro aspetto fu l’estensione dei meccanismi di assicurazione sociale alle colonie. L’INFAIL (Istituto Nazionale Fascista per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) aprì filiali in Africa, ma anche questi servizi privilegiavano i coloni, offrendo una protezione minima ai lavoratori indigeni.
Il Caso Emblematico del Katanga nel Congo Belga
Permettetemi di soffermarmi su un caso emblematico: l’industria mineraria del Katanga durante il dominio coloniale belga. Sotto la proprietà privata di Re Leopoldo II (Stato Libero del Congo, 1885-1908), lo sfruttamento si concentrò su avorio e gomma naturale. Nel 1908, divenne Congo Belga. Qui, l’estrazione di minerali divenne una fonte dominante di profitto per la metropoli. Il Katanga fu descritto come uno “scandalo geologico” per la sua ricchezza mineraria. L’Union Minière du Haut-Katanga (UMHK), creata nel 1906, ottenne il monopolio. La produzione di rame crebbe esponenzialmente, e l’UMHK divenne uno dei principali produttori mondiali, fornendo anche l’uranio per la bomba atomica di Hiroshima.
L’ideologia paternalistica belga (“dominare per servire”) mascherava pratiche di sfruttamento. La governance coloniale si basava sulla “trinità coloniale”: Stato, compagnie private (come l’UMHK) e Chiesa (che forniva servizi sociali). Inizialmente, l’UMHK affrontò una grave carenza di manodopera. Migliaia di uomini furono reclutati, spesso con la forza. La mortalità tra i lavoratori era altissima (fino a 200 per 1000!), dovuta a condizioni di viaggio disastrose, malnutrizione, suscettibilità alle infezioni respiratorie, alloggi rudimentali, freddo e scarsa preparazione al lavoro minerario. Le conseguenze economiche di questa carenza portarono, nel 1928, a una politica di “stabilizzazione” della forza lavoro, fortemente voluta dai medici dell’UMHK. Si migliorarono le condizioni di reclutamento, alloggio, sanità e alimentazione. Gli uomini furono incoraggiati a portare con sé le famiglie. Furono istituiti ospedali e scuole (rigorosamente segregati), ma i sindacati erano proibiti. Nonostante ciò, ci furono forme di resistenza, come uno sciopero violentemente represso nel 1941.
Il servizio medico dell’UMHK si concentrò sull’assicurare una forza lavoro in buona salute per il beneficio economico dell’azienda. Le procedure di reclutamento erano severe: potenziali reclute venivano portate in “campi di concentrazione” per riposare e mangiare, poi in “campi di preparazione” per una selezione rigorosa e preparazione medica (vaccinazioni, sverminazione), e infine in “campi di acclimatazione” per adattarsi al nuovo stile di vita. I rapporti annuali del dipartimento medico dell’UMHK (1917-1965) si concentravano quasi esclusivamente su malattie infettive come malaria, polmonite, tubercolosi e malattie intestinali. Gli infortuni sul lavoro erano responsabili di gran parte dei ricoveri, spesso complicati da ulcere tropicali. Tuttavia, c’è una sorprendente assenza di dati sulla prevenzione o epidemiologia di malattie professionali specifiche causate da metalli, gas, radiazioni, rumore o disturbi muscoloscheletrici. La consapevolezza del rischio di silicosi esisteva, ma i casi iniziarono ad apparire nei rapporti solo dal 1941, circa dieci anni dopo l’inizio dell’attività della miniera sotterranea di Kipushi, e furono documentati in modo superficiale. In sintesi, la medicina dell’UMHK fu un esempio di “medicina mineraria” al servizio degli interessi imperiali, focalizzata più sulla gestione delle malattie tropicali che sulla prevenzione specifica dei rischi professionali.

L’Era Post-Coloniale: Eredità Pesanti e Sfide Attuali
Il passaggio all’indipendenza non cancellò di colpo le strutture coloniali. La salute dei lavoratori, già di bassa priorità, continuò a esserlo in molti paesi africani, influenzata dalle economie emergenti post-coloniali, spesso ancora dipendenti dall’agricoltura, dall’estrazione mineraria o, più tardi, dal settore petrolchimico. Piantagioni, miniere e giacimenti petroliferi rimasero spesso di proprietà o sotto la gestione di entità legate all’ex centro coloniale.
Le condizioni di lavoro nelle fattorie coloniali/post-coloniali erano generalmente pessime, con malattie tropicali diffuse e incidenti frequenti. Nelle miniere, la situazione non era dissimile. L’estrazione di risorse come l’uranio nell’Africa sub-sahariana ha comportato un aumento del rischio di cancro non solo per i lavoratori, ma anche per le comunità esposte alle montagne di sterili minerari. Esempi simili si trovano nelle miniere di fosfati in Tunisia e Marocco e nelle miniere di rame-cobalto nella “Copperbelt africana”.
Laddove il lavoro salariato dipendeva dalla popolazione indigena, i servizi sociali, inclusa la salute dei lavoratori, rimasero una priorità secondaria. Con l’espansione economica e la continua presenza di espatriati coloniali, divenne necessario migliorare le condizioni sanitarie, dando origine a una “medicina imperiale” interessata a controllare le epidemie, che avevano gravi conseguenze economiche. Ci sono prove di organizzazioni sindacali e resistenza dei lavoratori nel primo periodo post-coloniale, principalmente riguardo alle condizioni di lavoro generali. In Ghana, la sindacalizzazione crebbe rapidamente. I minatori africani iniziarono a organizzarsi all’inizio del ‘900 in Sudafrica, portando a grandi scioperi negli anni ’40, e i minatori di rame zambiani nel 1935. Anche la scoperta del petrolio in Nord Africa vide la nascita di forti organizzazioni di lavoratori.
Ci sono stati casi in cui l’azione dei lavoratori ha portato a cambiamenti. In Nigeria, la reazione alle cattive condizioni di lavoro portò all’istituzione di alcuni servizi di sanità del lavoro e all’emanazione del Factory Act nel 1958. In Sudafrica, la necessità di proteggere “l’investimento” della manodopera importata dall’Europa portò a sistemi di salute sul lavoro di riferimento internazionale già all’inizio del XX secolo. La conferenza globale sulla silicosi tenutasi a Johannesburg nel 1930 ne è una testimonianza. Gli enti di ricerca sulla salute sul lavoro istituiti in Sudafrica in quel periodo permisero di documentare nuove malattie, come il mesotelioma nel 1960.
Tuttavia, la lenta industrializzazione in altri paesi africani significò che la salute dei lavoratori rimase una bassa priorità. La stagnazione economica tra il 1975 e il 2000 influenzò negativamente questi sistemi. In Sudafrica, l’emergere dell’epidemia di HIV/AIDS aumentò il rischio di tubercolosi professionale tra i lavoratori esposti alla silice. Secondo un’analisi dell’OMS del 2004, solo il 5-10% dei lavoratori africani aveva accesso a servizi di salute sul lavoro, una percentuale rimasta quasi invariata per decenni. Nel 2001, solo il 48% dei paesi africani aveva una legislazione in materia, e spesso era scarsamente applicata.
Negli ultimi decenni, l’ingresso di multinazionali ha portato all’adozione di standard internazionali di salute e sicurezza, ma spesso i servizi di salute sul lavoro esistono principalmente all’interno di queste grandi aziende. Un’altra sfida enorme è la crescente diffusione dell’economia informale, che rappresenta dal 20% al 90% delle economie in vari paesi. I lavoratori informali e le piccole imprese raramente hanno le risorse per la protezione della salute, rimanendo scoperti se lo Stato non interviene.

Riflessioni Finali: Imparare dal Passato per Costruire il Futuro
Raccontare millenni di storia in poche righe è una sfida, e abbiamo solo scalfito la superficie di molti argomenti. Ma spero che questo viaggio vi abbia dato un’idea della complessità e della lunga durata dei problemi legati alla salute sul lavoro in Africa. Le cattive condizioni di lavoro, specialmente nell’estrazione mineraria, sono una costante. Lo sfruttamento coloniale ha solo aggravato la situazione. Riconoscere queste ingiustizie storiche è fondamentale per sviluppare politiche efficaci che diano priorità alla sicurezza e al benessere dei lavoratori.
Sebbene siano stati fatti progressi, molti di questi schemi storici persistono, soprattutto nei settori del lavoro informale e nelle industrie legate ai mercati globali. Problemi come il lavoro precario, l’esposizione a sostanze tossiche e i rischi professionali legati al cambiamento climatico sono sfide attuali che affondano le radici in questo passato. Un approccio integrato alla storia della salute sul lavoro nel continente africano ci fornisce il contesto per comprendere meglio i problemi odierni e anticipare le tendenze future. Imparando dal passato, l’Africa può muoversi verso un futuro in cui la salute sul lavoro sia promossa attivamente come un diritto fondamentale per tutti.
Fonte: Springer