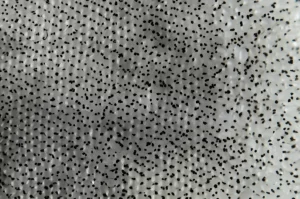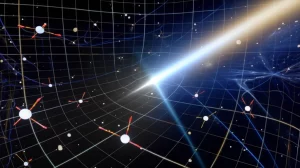Fisica Quantistica tra le Righe: Le Parole Seguono Davvero le Leggi dell’Incredibilmente Piccolo?
Amici lettori, preparatevi a un viaggio che potrebbe sembrarvi uscito da un romanzo di fantascienza, ma che affonda le sue radici in una ricerca scientifica serissima e, lasciatemelo dire, tremendamente affascinante! Vi siete mai chiesti se le parole che usiamo tutti i giorni, quelle che compongono i nostri libri preferiti, possano nascondere segreti legati nientemeno che alla meccanica quantistica? Sembra un’idea bizzarra, vero? Eppure, è proprio quello che un team di ricercatori, inclusi noi, ha esplorato, concentrandosi questa volta sui testi della nostra amata lingua italiana.
Un’idea un po’ folle: la fisica quantistica nel linguaggio?
Partiamo da un presupposto: in fisica, quando si ha a che fare con un gran numero di “entità” identiche, come le particelle in un gas, il loro comportamento statistico è descritto da leggi ben precise. Nella fisica classica, si parla di statistica di Maxwell-Boltzmann. Immaginate tante biglie in una scatola: ognuna è distinguibile dall’altra e si muove per i fatti suoi. Semplice, no?
Poi, però, è arrivata la meccanica quantistica a scompigliare le carte. Qui le cose si fanno più strane. Le particelle identiche, come i fotoni (le particelle di luce) o gli elettroni, non sono poi così “indipendenti” e, soprattutto, sono considerate indistinguibili. Questo porta a due tipi principali di statistiche quantistiche:
- La statistica di Bose-Einstein: riguarda particelle chiamate bosoni (come i fotoni). La cosa curiosa è che i bosoni amano stare insieme, tendono ad “ammucchiarsi” nello stesso stato energetico. Pensate a un concerto rock: se una zona sotto il palco è particolarmente “energetica”, attirerà più persone!
- La statistica di Fermi-Dirac: riguarda i fermioni (come gli elettroni). Questi, al contrario, sono più solitari e seguono il principio di esclusione di Pauli: non più di un fermione può occupare lo stesso stato quantico. Un po’ come i posti a sedere numerati in un teatro.
La cosa che ci ha incuriosito è che questa “tendenza a raggrupparsi” dei bosoni è legata a un concetto chiave della fisica quantistica: l’entanglement, o correlazione quantistica. È come se queste particelle fossero misteriosamente connesse, anche a distanza.
E se le parole fossero… bosoni? La nostra indagine sui testi italiani
Ora, tenetevi forte. Ci siamo chiesti: e se le parole in un testo si comportassero in modo simile? Dopotutto, parole identiche sono, beh, identiche. Potrebbero mostrare una tendenza a “raggrupparsi” in un testo in un modo che ricorda la statistica di Bose-Einstein?
Per scoprirlo, abbiamo preso in esame diversi testi di grandi autori italiani del XIX e XX secolo, pescati dalla biblioteca digitale “BibIt”. Parliamo di capolavori come “Cuore” di De Amicis, “Le Avventure di Pinocchio” di Collodi, “Senilità” di Svevo, “Del Romanzo Storico” di Manzoni e “Le Ultime Lettere di Jacopo Ortis” di Foscolo. Mica robetta!
Come abbiamo fatto? Abbiamo sviluppato un quadro teorico, già testato su testi in lingua inglese con risultati promettenti. In pratica, abbiamo trattato le parole di un testo come se fossero delle entità, che abbiamo battezzato “cognitoni” (i quanti fondamentali del linguaggio umano, un po’ come i fotoni lo sono per la luce). A ogni parola diversa nel testo abbiamo assegnato un “livello di energia”, basato sulla sua frequenza: la parola più frequente ha l’energia più bassa, e così via a salire.
Analizzando la distribuzione di queste parole nei vari livelli energetici, abbiamo confrontato i dati reali con quello che ci si aspetterebbe secondo la statistica di Maxwell-Boltzmann (classica) e quella di Bose-Einstein (quantistica).
I risultati? Sorprendenti! In tutti i testi analizzati, la distribuzione delle parole si adattava in modo quasi perfetto alla statistica di Bose-Einstein, mentre si discostava significativamente da quella di Maxwell-Boltzmann. È come se le parole identiche avessero una naturale tendenza a “condensarsi”, ad apparire più spesso di quanto ci si aspetterebbe se fossero entità completamente indipendenti. Proprio come i bosoni!

Prendiamo ad esempio “Cuore”. La parola “Di” era la più frequente (livello energetico 0), seguita da “Che” (livello energetico 1). Andando avanti, abbiamo visto che la distribuzione complessiva delle frequenze delle parole ricalcava splendidamente il modello bosonico. Questo suggerisce che c’è una sorta di “dinamica cognitiva intrinseca” che governa come usiamo le parole, e sembra essere indipendente dalla lingua specifica (visto che avevamo già osservato pattern simili in inglese).
Il colpo di scena: cosa succede se “mescoliamo” il significato?
Ma non ci siamo fermati qui. Ci siamo chiesti: cosa c’entra il significato in tutto questo? L’ipotesi è che sia proprio il significato a creare questa “coerenza” che porta le parole a comportarsi come bosoni. Le parole non sono messe a caso in un testo; sono lì per costruire un senso complessivo.
Per testare questa idea, abbiamo fatto un esperimento un po’ diabolico: la “randomizzazione delle parole“. Abbiamo preso uno dei testi, ad esempio “Senilità” di Svevo, e abbiamo mantenuto lo stesso numero totale di parole e lo stesso insieme di parole uniche. Però, abbiamo rimescolato casualmente la frequenza con cui ogni parola appariva, pur mantenendo il numero totale di parole costante. Immaginate di avere un sacchetto con tutte le parole del libro e di pescarle a caso per riscrivere il testo, alterando così quante volte compare ogni singola parola rispetto all’originale.
Cosa è successo? La statistica di Bose-Einstein era ancora un buon modello, ma – e qui sta il bello – anche la statistica di Maxwell-Boltzmann ha iniziato a descrivere i dati molto meglio di prima! La differenza tra i due modelli si è assottigliata parecchio.
La nostra interpretazione è che la randomizzazione, distruggendo parzialmente la coerenza di significato originale del testo, ha un effetto simile a quello di un aumento di temperatura in un sistema fisico. L’aumento di temperatura, in fisica, tende a “scompigliare” l’ordine e a far prevalere comportamenti più classici, meno “quantistici”. Allo stesso modo, togliendo parte della struttura di significato, le parole hanno iniziato a comportarsi in modo un po’ più “indipendente”, avvicinandosi al modello classico.
È come se il significato originale del testo creasse una sorta di “campo di coerenza” che spinge le parole a raggrupparsi. Quando questo campo si indebolisce a causa della randomizzazione, l’effetto “quantistico” si attenua.
Il Significato come “Entanglement Linguistico”
Questo ci porta a un’ipotesi ancora più profonda: il modo in cui il significato si forma nella combinazione delle parole assomiglia incredibilmente alla formazione dell’entanglement quantistico. Ogni volta che aggiungiamo una parola a un testo, questa non solo porta il suo significato, ma “aggiorna contestualmente” il significato dell’intero testo. Si crea una rete di interconnessioni, un “entanglement” tra le parole, guidato dalla necessità di mantenere una coerenza complessiva.
Le parole identiche, avendo lo stesso significato, tendono naturalmente a “collaborare” in questo processo, raggruppandosi e rafforzando certi filoni di senso. Questo spiegherebbe la loro tendenza a seguire la statistica di Bose-Einstein. Pensate a un testo come “No, no, no, no!”, urlato per fermare un bambino che sta per toccare una stufa rovente. È un esempio estremo, quasi un “condensato di Bose-Einstein” linguistico, dove la ripetizione ossessiva della stessa parola massimizza l’impatto comunicativo su quel singolo concetto.

La coerenza quantistica, quindi, potrebbe essere una firma della presenza di significato in un testo. E la randomizzazione? Sarebbe l’equivalente linguistico della “decoerenza” che un aumento di temperatura provoca nei sistemi fisici, distruggendo le delicate correlazioni quantistiche.
Spunti per la Fisica e oltre
Queste scoperte non sono solo una curiosità per linguisti e appassionati di letteratura. Potrebbero avere implicazioni più ampie. Curiosamente, agli albori della meccanica quantistica, persino Albert Einstein si interrogava su una “forza misteriosa” che sembrava far attrarre i fotoni in un gas, prima che il postulato di simmetria di scambio venisse introdotto per spiegare formalmente queste statistiche.
La nostra ipotesi è che, forse, ciò che osserviamo nel linguaggio – l’entanglement attraverso l’aggiornamento contestuale – potrebbe essere un meccanismo più fondamentale, che si manifesta anche nei domini fisici. Invece di postulare l’indistinguibilità assoluta come causa primaria, potremmo pensare a una dinamica collaborativa intrinseca delle entità (siano esse parole o particelle) per ridurre l’incertezza complessiva e mantenere la coerenza, entro i limiti imposti dall’energia del sistema (o dalla “temperatura”).
Questo lavoro si inserisce in un filone di ricerca più ampio chiamato “cognizione quantistica“, che applica il formalismo matematico della meccanica quantistica per modellare fenomeni cognitivi complessi. E suggerisce persino una nuova interpretazione della meccanica quantistica stessa, la “conceptuality interpretation”, che vede le entità fisiche più come “concetti” che come oggetti materiali puri e semplici.
Insomma, la prossima volta che leggerete un libro, pensateci: tra quelle righe potrebbe nascondersi non solo una bella storia, ma anche un pizzico della magia elusiva e affascinante del mondo quantistico. E noi continueremo a esplorare questo confine, perché l’universo delle parole, proprio come quello dei quanti, sembra avere ancora tantissimi segreti da svelarci!
Fonte: Springer