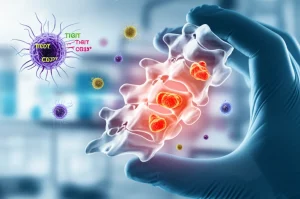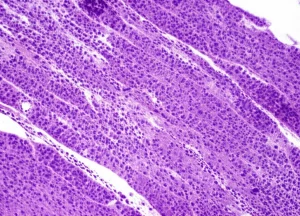Statine e Cancro al Seno HER2+: Un Legame Inaspettato? La Verità dallo Studio APHINITY
Ciao a tutti! Oggi voglio portarvi con me in un tuffo nel mondo affascinante, e a volte complesso, della ricerca sul cancro al seno. In particolare, parleremo di un tipo specifico, quello HER2-positivo (HER2+), e di una domanda che stuzzica non poco la curiosità: farmaci comunissimi come le statine, usate per abbassare il colesterolo, potrebbero influenzare la sopravvivenza delle pazienti? Sembra strano, vero? Eppure, c’è una base scientifica che ha spinto i ricercatori a indagare.
Mi sono imbattuto in un’analisi molto interessante proveniente da uno studio clinico enorme e importante, chiamato APHINITY. Questo studio, di fase III, aveva come obiettivo principale valutare l’efficacia dell’aggiunta di pertuzumab a trastuzumab e chemioterapia come trattamento adiuvante (cioè dopo l’intervento chirurgico) per le pazienti con cancro al seno HER2+ in stadio iniziale. Ma, come spesso accade nella ricerca, i dati raccolti possono essere esplorati per rispondere anche ad altre domande. E una di queste riguardava proprio le statine.
Perché proprio le statine? La scienza dietro l’ipotesi
Prima di addentrarci nei risultati, facciamo un passo indietro. Perché mai si è pensato che le statine potessero avere un ruolo nel cancro al seno? Beh, la faccenda è legata a un processo biochimico chiamato via del mevalonato. Questa via è fondamentale per produrre colesterolo, ma non solo. Produce anche altre molecole (intermedi isoprenoidi) che, ahimè, possono inviare segnali che favoriscono la crescita e la sopravvivenza delle cellule tumorali.
Le statine agiscono bloccando un enzima chiave (HMG-CoA reduttasi) di questa via. L’idea, supportata da studi preclinici (su cellule in laboratorio e modelli animali), era che bloccando questa via, le statine potessero non solo ridurre il colesterolo, ma anche indurre la morte delle cellule tumorali (apoptosi), ridurre la crescita del tumore, la formazione di nuovi vasi sanguigni (angiogenesi) e la capacità di dare metastasi. Addirittura, alcuni modelli suggerivano che la via del mevalonato potesse essere un meccanismo di “fuga” per le cellule di cancro al seno HER2+ diventate resistenti alle terapie anti-HER2 specifiche. Insomma, le premesse sembravano promettenti!
Però, quando si è passati a studi osservazionali su pazienti reali, i risultati sono stati un po’ un’altalena:
- Alcuni studi suggerivano un’associazione protettiva: chi usava statine sembrava avere una migliore sopravvivenza specifica per il cancro al seno e/o sopravvivenza globale.
- Altri studi, invece, non trovavano alcun effetto positivo significativo.
- Anche riguardo alle recidive, i dati erano contrastanti: a volte le statine sembravano correlate a risultati migliori, altre volte no.
Una delle difficoltà nel confrontare questi studi è che spesso definivano “utilizzatore di statine” in modi diversi. C’era quindi bisogno di dati più solidi, magari provenienti da grandi studi clinici controllati, anche se analizzati in modo retrospettivo (cioè guardando i dati dopo che lo studio principale è stato completato). Ed è qui che entra in gioco l’analisi dello studio APHINITY.

L’analisi nello studio APHINITY: cosa abbiamo cercato?
Nello studio APHINITY sono state arruolate quasi 5000 pazienti con cancro al seno HER2+ in stadio iniziale. I ricercatori hanno deciso di andare a vedere, all’interno di questo grande gruppo, se ci fosse una differenza negli esiti di sopravvivenza tra le pazienti che assumevano statine e quelle che non le assumevano.
Sono state considerate “utilizzatrici di statine” le pazienti che le prendevano già al momento dell’arruolamento nello studio o che avevano iniziato a prenderle entro un anno dalla randomizzazione (l’assegnazione casuale a uno dei bracci di trattamento dello studio). Questo per evitare distorsioni legate al tempo.
Gli obiettivi principali di questa sotto-analisi erano valutare l’associazione tra l’uso di statine e tre parametri chiave:
- Sopravvivenza libera da malattia invasiva (IDFS): il tempo trascorso senza che si verifichi una recidiva locale, a distanza, un nuovo tumore al seno controlaterale o il decesso per qualsiasi causa.
- Intervallo libero da ricadute a distanza (DRFI): il tempo trascorso senza la comparsa di metastasi a distanza.
- Sopravvivenza globale (OS): il tempo trascorso fino al decesso per qualsiasi causa.
Il follow-up mediano (cioè il periodo di osservazione per metà delle pazienti) era di circa 6,2 anni, un tempo sufficientemente lungo per osservare gli eventi.
Chi erano le pazienti che usavano statine?
Su 4804 pazienti analizzate, 423 (circa l’8,8%) sono state classificate come utilizzatrici di statine. Confrontando questo gruppo con le non utilizzatrici, sono emerse differenze significative già al punto di partenza:
- Erano più anziane (età mediana 62 vs 50 anni).
- Erano più frequentemente in post-menopausa (91,1% vs 47,6%).
- Avevano un indice di massa corporea (BMI) più alto.
- Avevano più spesso altre condizioni mediche come diabete, ipertensione, malattie coronariche e iperlipidemia (colesterolo alto, il motivo principale per cui prendevano le statine!).
- Curiosamente, avevano tumori di dimensioni più piccole al momento della diagnosi.
- Erano state trattate più spesso con chirurgia conservativa della mammella (quadrantectomia) rispetto alla mastectomia.
- Avevano ricevuto meno frequentemente regimi di chemioterapia contenenti antracicline (farmaci potenzialmente cardiotossici, forse evitati proprio per le loro condizioni preesistenti).
Queste differenze sono fondamentali! Ci dicono che i due gruppi (utilizzatrici vs non utilizzatrici di statine) non erano uguali fin dall’inizio. Le utilizzatrici di statine erano, in generale, un gruppo con più problemi di salute concomitanti, anche se con tumori inizialmente meno estesi. Questo rende cruciale l’uso di analisi statistiche avanzate (come i modelli multivariati) per “aggiustare” i risultati tenendo conto di queste differenze.

I risultati: le statine fanno la differenza? Tenetevi forte…
Dopo un follow-up mediano di oltre 6 anni, si sono verificati 508 eventi IDFS (12,8% tra le utilizzatrici di statine e 10,4% tra le non utilizzatrici) e 272 decessi (8,5% vs 5,4%, rispettivamente). A prima vista, questi numeri grezzi potrebbero far pensare a un risultato peggiore per chi usava statine. Ma attenzione, ricordate le differenze di base tra i gruppi?
L’analisi statistica più importante è quella multivariata, che tiene conto di fattori come età, stato menopausale, BMI, dimensioni del tumore, stato dei linfonodi, stato dei recettori ormonali, presenza di comorbidità e braccio di trattamento APHINITY. Ebbene, i risultati di questa analisi sono stati chiari:
L’uso di statine NON è risultato associato a una differenza significativa né nella sopravvivenza libera da malattia invasiva (IDFS), né nell’intervallo libero da ricadute a distanza (DRFI), né nella sopravvivenza globale (OS).
In termini tecnici, gli Hazard Ratio (HR), che misurano il rischio relativo, erano vicini a 1 e gli intervalli di confidenza includevano l’1, indicando assenza di associazione statisticamente significativa (IDFS HR 1.11; DRFI HR 1.21; OS HR 1.16). Anche analisi di sensibilità aggiuntive hanno confermato questi risultati.
C’è stato un trend verso una peggiore sopravvivenza globale (OS) nell’analisi univariata (quella che non corregge per i fattori confondenti), ma questo è probabilmente dovuto al fatto che le pazienti che prendevano statine erano più anziane e avevano più comorbidità, quindi un rischio di morte per altre cause intrinsecamente più alto. Infatti, la percentuale di decessi non correlati al cancro al seno era numericamente maggiore nel gruppo statine (41,7% vs 29,7%). Quando si è analizzato specificamente il rischio di morte per cancro al seno (usando un’analisi di rischio competitivo), l’uso di statine non ha mostrato alcuna associazione.
Cosa ci dice tutto questo? Interpretazione e cautele
Quindi, nonostante le promettenti basi precliniche e alcuni dati osservazionali precedenti (spesso però relativi a tumori al seno non specificamente HER2+ o con recettori ormonali positivi), questa analisi approfondita all’interno del grande studio APHINITY non supporta l’idea che le statine migliorino gli esiti nelle pazienti con cancro al seno HER2+ in stadio iniziale trattate con chemioterapia e terapia anti-HER2 (trastuzumab con o senza pertuzumab).
È importante sottolineare alcune limitazioni di questa analisi:
- È di natura esploratoria: l’ipotesi non era stata definita all’inizio dello studio APHINITY.
- Per molte pazienti mancavano dati precisi sull’inizio, la fine e l’aderenza al trattamento con statine. Non sappiamo se le abbiano prese costantemente o solo per brevi periodi.
- La documentazione delle cause di morte potrebbe non essere stata perfetta.
- Non sono stati raccolti dati sui livelli di colesterolo, quindi non si può correlare l’effetto (o la sua assenza) alla reale efficacia ipolipemizzante.
Tuttavia, la forza di questa analisi sta nel grande numero di pazienti incluse, nella natura prospettica dello studio APHINITY e nelle informazioni dettagliate disponibili sulle caratteristiche delle pazienti e della malattia. Ad oggi, è la più ampia analisi focalizzata sull’uso di statine in pazienti con cancro al seno HER2+ in stadio precoce.
Conclusione: statine sì o no per il cancro HER2+?
La conclusione pratica che possiamo trarre da questo studio è che, al momento, non ci sono prove sufficienti per raccomandare l’uso delle statine specificamente per migliorare la prognosi del cancro al seno HER2-positivo in stadio iniziale. Le statine vanno ovviamente continuate o iniziate se ci sono le indicazioni classiche (prevenzione cardiovascolare, ipercolesterolemia), ma non come “terapia aggiuntiva” contro il tumore basandosi su questi dati.
Solo uno studio randomizzato prospettico (in cui le pazienti vengono assegnate casualmente a ricevere statine o placebo specificamente per questo scopo) potrebbe dare una risposta definitiva. Ma, come sottolineano gli stessi autori, realizzare uno studio del genere sarebbe estremamente costoso e complesso, ed è improbabile che venga fatto.
Quindi, per ora, la risposta alla nostra domanda iniziale, almeno per le pazienti con malattia HER2+ precoce nello studio APHINITY, sembra essere: le statine non appaiono né amiche né nemiche particolari nella lotta contro il cancro, ma semplicemente farmaci da usare per le loro indicazioni consolidate. Una conclusione forse meno “affascinante” delle premesse, ma scientificamente onesta.
Fonte: Springer