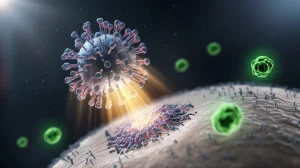Spondilodiscite: Chirurgia Subito o Terapia Conservativa? Il Dilemma dei Ricoveri Ripetuti
Ciao a tutti! Oggi voglio parlarvi di un osso duro, nel vero senso della parola: la spondilodiscite (SD). Si tratta di un’infezione insidiosa che colpisce la colonna vertebrale, specificamente i dischi intervertebrali e le vertebre adiacenti. E credetemi, sta diventando un bel grattacapo per i sistemi sanitari di mezzo mondo. Perché? Beh, per prima cosa, la sua incidenza è in aumento. Uno studio recente in Inghilterra ha mostrato un incremento del 33% dei casi tra il 2012 e il 2021, con un picco pazzesco del 133% nella fascia d’età 59-75 anni!
Le ragioni sono diverse: popolazione che invecchia, più persone con sistemi immunitari compromessi o con molteplici malattie, ma anche i progressi nelle tecniche di imaging che ci permettono di scovarla più facilmente. Il problema è che, nonostante la tecnologia ci dia una mano, la diagnosi tempestiva e l’inizio rapido del trattamento restano una sfida. La spondilodiscite ha spesso un esordio subdolo, con sintomi variabili che possono trarre in inganno.
La Giungla dei Trattamenti: Manca una Bussola
Una volta diagnosticata, inizia un altro capitolo complesso: come trattarla? Qui le cose si complicano ulteriormente. Non esistono algoritmi standardizzati universalmente accettati, né linee guida basate su prove scientifiche solide che dicano “fai così e basta”. Ci si muove un po’ a vista, spesso basandosi sull’esperienza individuale più che su protocolli condivisi.
In generale, le opzioni principali sono due:
- Trattamento non chirurgico (o conservativo): Si basa principalmente su terapia antibiotica mirata e prolungata, immobilizzazione (con busti o riposo) e gestione del dolore. La maggior parte dei pazienti, fortunatamente, risponde bene a questo approccio.
- Trattamento chirurgico: Di solito riservato ai casi più gravi: deficit neurologici, deformità spinale progressiva o instabilità, oppure quando la terapia medica fallisce nel controllare l’infezione.
Tuttavia, alcuni studi suggeriscono che un intervento chirurgico precoce potrebbe portare a tassi di fallimento e mortalità inferiori rispetto alla sola terapia conservativa, oltre a ridurre i tempi di degenza ospedaliera. Ma quando è davvero “presto”? E per chi è indicato? Domande aperte. Esiste persino uno strumento, il SITE-Score, che cerca di aiutare nella decisione basandosi su parametri clinici e radiografici oggettivi, ma i suoi benefici a lungo termine non sono ancora del tutto chiari. Sappiamo anche che una percentuale non trascurabile di pazienti (fino al 13% o più, secondo alcuni studi) inizialmente trattati in modo conservativo finisce comunque sotto i ferri.
Il Problema delle Riammissioni: Una Porta Girevole?
C’è un aspetto particolarmente frustrante della spondilodiscite: il tasso di riammissione ospedaliera. Immaginate di aver passato settimane in ospedale, aver seguito una terapia lunga e faticosa, e poi, poco dopo essere tornati a casa, dover rifare le valigie per un nuovo ricovero. Purtroppo, non è un’eventualità rara. Un precedente studio parlava di un tasso di riammissione del 34.9% a 90 giorni, una cifra notevolmente alta se confrontata con altre patologie della colonna vertebrale (pensate che per la chirurgia lombare elettiva siamo intorno al 2.3%!).

Questa alta percentuale di “porte girevoli” solleva una domanda cruciale: il tipo di trattamento iniziale influisce sulla probabilità di essere riammessi in ospedale? È proprio qui che si inserisce uno studio interessante che ho analizzato di recente, basato su un enorme database americano (il Nationwide Readmissions Database, NRD) relativo all’anno 2020.
Lo Studio NRD: Cosa Ci Dicono i Numeri?
I ricercatori hanno setacciato i dati di oltre 6.000 pazienti adulti con diagnosi primaria di spondilodiscite. L’obiettivo era chiaro: confrontare i tassi di riammissione a 90 giorni per qualsiasi causa tra chi aveva ricevuto un trattamento chirurgico durante il primo ricovero e chi era stato trattato in modo conservativo.
I risultati sono stati piuttosto illuminanti:
- Tasso di riammissione generale: Lo studio ha confermato l’alto tasso di riammissione, trovando un valore del 35% a 90 giorni. Praticamente un paziente su tre torna in ospedale entro tre mesi! Il tempo medio prima della riammissione era di circa 36 giorni.
- Chirurgia vs. Non Chirurgia: Qui arriva il dato forse più significativo. I pazienti trattati chirurgicamente durante il primo ricovero avevano un tasso di riammissione significativamente più basso (29.3%) rispetto a quelli trattati in modo conservativo (36.41%).
- Tempo alla Riammissione: Non solo i pazienti chirurgici venivano riammessi meno frequentemente, ma quando succedeva, tendeva ad accadere più tardi. Il tempo medio alla riammissione per il gruppo chirurgico era di quasi 42 giorni, contro i 34.5 giorni del gruppo non chirurgico.
L’analisi statistica più approfondita (regressione multivariata, per i più tecnici) ha confermato che il trattamento chirurgico al momento del primo ricovero era un fattore protettivo indipendente contro la riammissione. In pratica, scegliere la via chirurgica inizialmente sembra ridurre le probabilità di dover tornare in ospedale.
E Dopo la Riammissione?
Lo studio ha anche guardato a cosa succedeva ai pazienti una volta riammessi. Interessante notare che la maggior parte (circa l’8.4% del totale iniziale, anche se la conclusione dello studio dice 8.7% – usiamo questa cifra) non ha cambiato tipo di trattamento tra il primo e il secondo ricovero.
- Chi era stato operato la prima volta e ha subito un nuovo intervento (chirurgico-chirurgico) rappresentava solo lo 0.8% del totale, ma aveva il tempo più lungo prima della riammissione (quasi 51 giorni).
- Chi era stato trattato conservativamente entrambe le volte (non chirurgico-non chirurgico) era il gruppo più numeroso tra i riammessi (25.7% del totale) e aveva il tempo più breve prima del secondo ricovero (circa 34 giorni).
- Il passaggio da un trattamento all’altro era meno comune: dal chirurgico al non chirurgico nel 5.2% dei casi, e dal non chirurgico al chirurgico nel 3.2%.
Questi dati suggeriscono che, anche in caso di riammissione, chi era stato operato inizialmente sembrava avere un decorso leggermente più favorevole in termini di tempo.

Un Fattore di Rischio Inaspettato: Il Ricovero Non Elettivo
Un altro dato emerso dall’analisi è che essere ammessi in ospedale in modo non elettivo (cioè d’urgenza o comunque non programmato) rappresentava un fattore di rischio indipendente per la riammissione. Questo potrebbe sembrare controintuitivo, ma i ricercatori ipotizzano che un ricovero non programmato possa essere spia di una diagnosi tardiva o di un inizio ritardato del trattamento, fattori che sappiamo peggiorare l’esito della spondilodiscite. Potrebbe anche essere che un ricovero programmato (elettivo), pur sembrando un “ritardo”, permetta una pianificazione migliore e forse un trattamento più mirato fin dall’inizio, anche se questo cozza un po’ con l’idea che prima si interviene meglio è. È un punto che merita ulteriori approfondimenti.
Cosa Portiamo a Casa?
Questo studio, pur con i limiti di un’analisi retrospettiva su dati amministrativi (e condotta durante il periodo pandemico, che potrebbe aver influito), ci lascia alcuni messaggi importanti.
La spondilodiscite è una bestia complessa con un alto tasso di riammissioni. Il trattamento chirurgico iniziale, però, sembra associato a un minor rischio di tornare in ospedale e a un intervallo di tempo più lungo prima che ciò accada. Questo non significa che tutti debbano essere operati subito, ovviamente! Le indicazioni chirurgiche restano quelle legate alla gravità del quadro clinico.
Tuttavia, questi risultati, uniti alla mancanza di standardizzazione globale nei trattamenti, rafforzano l’idea che forse dovremmo essere un po’ più “aggressivi” o quantomeno più strutturati nel decidere il percorso terapeutico. L’implementazione di algoritmi decisionali basati su punteggi oggettivi, come il già citato SITE-Score, potrebbe essere un passo nella giusta direzione.
Forse, per alcuni pazienti selezionati, ampliare le indicazioni per un intervento chirurgico più precoce potrebbe non solo migliorare l’esito clinico (come suggerito da altri studi su mortalità e tempi di degenza) ma anche ridurre il fastidioso fenomeno delle “porte girevoli” ospedaliere. La strada è ancora lunga, ma capire come i diversi approcci influenzano non solo la guarigione ma anche il percorso del paziente nel sistema sanitario è fondamentale per offrire cure sempre migliori.

Fonte: Springer