Medici di Famiglia: Eroi Solitari? Quando la Solitudine Colpisce Chi Cura
Sapete, quando pensiamo ai medici di famiglia, ci immaginiamo figure sempre circondate da persone: pazienti in sala d’attesa, colleghi in corsia, studenti da formare. Eppure, dietro quel camice bianco e quel sorriso rassicurante, può nascondersi un nemico invisibile e insidioso: la solitudine. Sì, avete capito bene. Noi, che dovremmo essere il faro della connessione umana e della cura, a volte ci sentiamo profondamente soli. E questo non è solo un “problemino” personale, ma qualcosa che può avere un impatto reale sul nostro lavoro clinico e sull’insegnamento. Recentemente, uno studio ha voluto vederci chiaro, e i risultati, ve lo dico, fanno riflettere.
Ma quanto è diffusa questa solitudine? I numeri parlano chiaro
Immaginate di fare un sondaggio tra i vostri colleghi medici di famiglia, quelli che lavorano in ambito accademico negli Stati Uniti. Bene, è quello che hanno fatto i ricercatori del Council of Academic Family Medicine Educational Research Alliance (CERA). Hanno inviato un questionario online tra ottobre e novembre 2024 e hanno ricevuto risposta da oltre mille di noi. E cosa è emerso? Che quasi un terzo, per la precisione il 27,8%, ha riportato punteggi sulla scala di solitudine UCLA-3 tali da indicare una solitudine considerevole. Avete letto bene, più di uno su quattro!
Ma non è tutto. Questa sensazione di isolamento sembra colpire in modo particolare alcune categorie:
- Le donne medico (31,1%)
- Coloro che si identificano come appartenenti a minoranze sottorappresentate in medicina (36,1%)
- In particolare, i colleghi afroamericani, tra i quali la percentuale sale addirittura al 40,3%.
Questi numeri sono impressionanti, soprattutto se pensiamo che superano quelli riscontrati tra i nostri stessi pazienti e nella popolazione generale. Sembra un paradosso, vero? Passiamo le giornate immersi nelle interazioni umane, eppure… la connessione significativa a volte latita.
Perché proprio noi? Le radici del problema
Viene da chiedersi: come è possibile sentirsi soli quando si è costantemente a contatto con gli altri? Beh, forse essere “circondati” non significa automaticamente sentirsi “connessi”. Lo studio suggerisce che questa disconnessione potrebbe essere una caratteristica particolare di chi svolge professioni d’aiuto. E pensateci: noi medici di famiglia in ambito accademico siamo ancora più “socialmente inseriti”, tra insegnamento a specializzandi e studenti, partecipazione a società scientifiche e lavoro in reti istituzionali più ampie.
D’altro canto, c’è il rovescio della medaglia. Quante ore passiamo davanti al computer per la documentazione clinica? A volte, sembra più tempo di quello dedicato alla cura diretta del paziente. Questa burocrazia crescente, la frammentazione dell’interazione medico-paziente, la mancanza di tempo per un confronto sereno con i colleghi durante giornate frenetiche, gli ambulatori separati… tutto contribuisce a un senso di isolamento professionale, nonostante la vicinanza fisica. E se questo accade a noi formatori, che abbiamo più occasioni di contatto, chissà cosa succede ai colleghi che lavorano in contesti non accademici, dove il rischio burnout, spesso legato alla solitudine, potrebbe essere ancora più alto.
Certo, ognuno di noi ha un “livello ottimale” di connessione sociale diverso, e non tutti coloro che rientrano nei criteri di solitudine la percepiscono come un problema. Questo è un aspetto importante da considerare, che potrebbe spiegare perché non sempre c’è una correlazione diretta tra solitudine e problemi di salute fisica, come alcuni studi recenti hanno evidenziato.
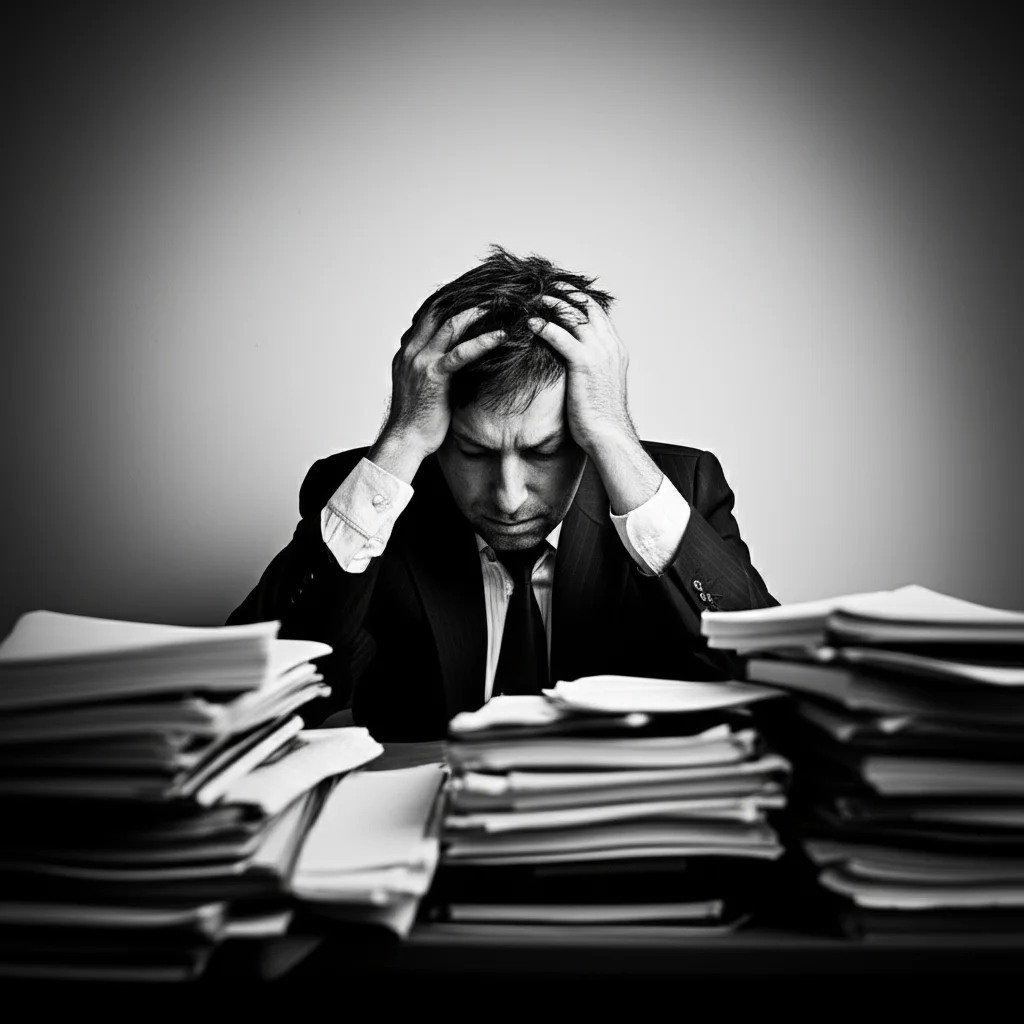
L’impatto sulla pratica clinica e sull’insegnamento: un circolo vizioso?
La cosa che forse colpisce di più è come la nostra esperienza personale di solitudine possa influenzare il nostro approccio al problema nei confronti dei pazienti. Lo studio ha rivelato che noi medici che ci sentiamo più soli tendiamo a:
- Discutere meno frequentemente di solitudine con i nostri pazienti (23,7% contro il 32,0% di chi non si sente solo).
- Avere meno partnership con programmi comunitari per affrontare l’isolamento sociale.
- Insegnare meno frequentemente questi argomenti ai nostri specializzandi e studenti (il 50,9% di noi “soli” non ne parla quasi mai, contro il 43,3% dei colleghi).
È come se la nostra stessa vulnerabilità ci rendesse meno propensi ad affrontare l’argomento, forse per una sorta di protezione, o perché percepiamo di avere meno risorse interne per gestirlo. Questo è un punto cruciale, perché se non ne parliamo e non formiamo le nuove generazioni di medici su questo tema, come potremo mai spezzare questo circolo?
Chi sono i più colpiti? Uno sguardo alle disparità
Abbiamo già accennato che le donne e le minoranze sembrano soffrire di più. Per i colleghi afroamericani, con quel 40,3% di solitudine significativa, la situazione è particolarmente allarmante. Spesso, questi professionisti vivono esperienze di razzismo e discriminazione sul posto di lavoro, anche sotto forma di microaggressioni da parte di pazienti e colleghi. Questo, unito alla persistente sottorappresentazione delle minoranze etniche nel personale sanitario, può contribuire a un profondo senso di disconnessione. Sebbene tassi elevati di solitudine siano stati osservati anche nella popolazione generale afroamericana, i dati emersi in questo studio specifico sul contesto della medicina di famiglia accademica mostrano una disparità ancora più marcata.
Interessante notare anche alcune differenze nelle attitudini: le colleghe donne, ad esempio, supportano più fortemente lo screening per la solitudine rispetto agli uomini. I colleghi ispanici/latini considerano la solitudine più importante e supportano di più lo screening. I colleghi asiatici sono più d’accordo sulla responsabilità del medico nella gestione della solitudine, mentre i colleghi bianchi mostrano livelli di supporto inferiori sia per lo screening che per la gestione.
Cosa ne pensiamo noi medici? Tra consapevolezza e senso di responsabilità
Nonostante tutto, la maggioranza di noi (54,1%) ritiene che l’isolamento sociale e la solitudine (SIL) siano importanti o molto importanti nella medicina di famiglia. E una percentuale ancora più alta (68,2%) è d’accordo o molto d’accordo sul fatto che i medici di famiglia dovrebbero fare regolarmente uno screening per la SIL. Fin qui, tutto bene.
Il “problema” sorge quando si parla di responsabilità. Solo il 32,5% di noi è convinto che sia compito del medico affrontare e gestire la SIL. Un buon 29,9% non è d’accordo e un significativo 37,6% è indeciso. Questa esitazione riflette un dibattito più ampio nella società: la solitudine è un problema di salute pubblica o una questione individuale? Gli americani, ad esempio, sono quasi equamente divisi su questo punto.
La mancanza di risorse: un ostacolo concreto
Un altro dato che salta all’occhio è la carenza di strumenti. Ben il 71,0% di noi ha riferito che le risorse interne per affrontare la SIL nelle nostre cliniche sono assenti o inadeguate. E quasi la metà (49,1%) ha dichiarato di non collaborare mai o raramente con programmi comunitari. Questo è un peccato, perché in molte comunità esistono risorse valide, come i programmi PACE per gli anziani, “Meals on Wheels”, centri diurni o programmi psicosociali per persone con malattie mentali gravi. Evidentemente, c’è un gap da colmare tra ciò che esiste e la nostra capacità di utilizzarlo o, forse, la nostra consapevolezza della sua esistenza.
Le donne, ancora una volta, riportano meno frequentemente di avere risorse adeguate rispetto agli uomini. E chi di noi sperimenta la solitudine in prima persona, percepisce ancora meno risorse disponibili (solo il 7,7% contro il 18,2% di chi non si sente solo).

Cosa possiamo fare? Un appello alla professione
Allora, che si fa? Questo studio, pur con i suoi limiti (tasso di risposta moderato, potenziale bias di non risposta, focus su contesti accademici), ci lancia un messaggio forte. Prima di pensare a iniziative di screening su larga scala per la solitudine nei pazienti, dobbiamo affrontare due sfide fondamentali all’interno della nostra professione.
La prima priorità è capire come noi medici possiamo mantenere connessioni sociali significative all’interno dei nostri ruoli professionali così esigenti. Non si tratta solo di “stare insieme”, ma di coltivare legami autentici.
La seconda sfida chiave è creare una cultura più socialmente connessa all’interno della medicina di famiglia stessa. Dobbiamo prenderci cura di noi stessi e dei nostri colleghi. Forse, l’efficacia di qualsiasi intervento sulla solitudine rivolto ai pazienti dipenderà, in ultima analisi, dalla nostra capacità di affrontare prima queste dimensioni professionali e culturali all’interno della nostra disciplina.
Servono studi qualitativi per capire più a fondo come le nostre esperienze personali di solitudine influenzino il nostro impegno professionale sul tema. E poi, è essenziale sviluppare strumenti clinici pratici, basati sull’evidenza, che ci aiutino a integrare la gestione della SIL nella pratica quotidiana, magari attraverso brevi interventi o guide per incorporarla nel colloquio motivazionale.
Insomma, la strada è ancora lunga, ma la consapevolezza è il primo passo. Forse, riconoscendo la nostra stessa vulnerabilità, possiamo diventare ancora più empatici e preparati ad aiutare chi, come a volte noi, si sente un po’ troppo solo in questo mondo iperconnesso ma spesso superficiale.
Fonte: Springer







