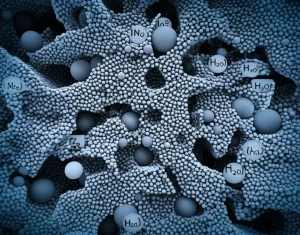Nichel e Acridina: La Strana Coppia che Rivoluziona la Chimica (e Produce Idrogeno!)
Ciao a tutti, appassionati di scienza e curiosi! Oggi voglio raccontarvi una storia che ha dell’incredibile, una di quelle scoperte che ti fanno dire “Wow!” quando meno te lo aspetti. Immaginate di poter prendere delle molecole semplici, aggiungere un pizzico di metallo (il nichel, nel nostro caso) e, come per magia, vederle trasformarsi in qualcosa di completamente nuovo e super utile. È un po’ quello che abbiamo fatto nel nostro laboratorio!
Le Acridine: Piccole Molecole, Grandi Potenzialità
Prima di tuffarci nel vivo della nostra ricerca, lasciatemi spendere due parole sulle protagoniste silenziose di questa storia: le acridine. Forse il nome non vi dirà molto, ma queste molecole sono delle vere e proprie star nel mondo della chimica e della medicina. Pensate che alcuni derivati dell’acridina, come le 9-amminoacridine, hanno mostrato una potente attività chemioterapica contro il cancro al pancreas. Mica male, eh? Non solo, grazie alle loro proprietà fluorescenti, le acridine vengono anche impiegate come sensori chimici, capaci di “accendersi” o “spegnersi” in presenza di determinate sostanze.
Nonostante il loro vasto utilizzo in campo biologico e sensoristico, i complessi metallici a base di acridina come catalizzatori sono un territorio ancora relativamente poco esplorato. Eppure, alcuni esempi, come certi complessi di rutenio, si sono già distinti per la loro efficacia in trasformazioni organiche importanti, come la produzione di ammine primarie o la conversione di alcoli in acetali ed esteri.
La Sfida della Sintesi: Vecchi Metodi e Nuove Idee
Sintetizzare queste meraviglie, però, non è sempre una passeggiata. I metodi tradizionali, come la famosa reazione di Bernthsen, che prevede la condensazione di difenilammina con un acido carbossilico e cloruro di zinco, richiedono spesso condizioni “brutali”: temperature superiori ai 200 °C e tempi di reazione che possono arrivare fino a 24 ore! Insomma, un vero stress per le molecole (e per i chimici!). Si pensa che acidi di Lewis come AlCl3, ZnCl2 o FeCl3 facilitino il riarrangiamento della difenilammina con un gruppo aldeidico o imminico per formare il nucleo acridinico.
Ed è qui che entriamo in gioco noi! Ci siamo chiesti: e se potessimo usare un metallo, come il nichel, per “guidare” la reazione in modo più dolce ed efficiente? L’ispirazione ci è venuta da un lavoro pionieristico di Brooker e collaboratori, che avevano dimostrato la sintesi di complessi di cobalto(II) a base di acridina partendo da un precursore simile, la difenilammina-2,2′-dicarbossialdeide (2,2′-dpadc), in condizioni blande. Questa scoperta ci ha aperto un mondo: perché non esplorare ulteriormente questa strategia, magari con altri metalli e per applicazioni catalitiche? E se fosse anche una via più “verde” per ottenere composti acridinici?
La Nostra “Ricetta”: Nichel, dpadc e TREN
Così, ci siamo messi all’opera. L’idea era di partire proprio dal 2,2′-dpadc (pensatelo come il nostro ingrediente base A) e farlo reagire con un’altra molecola chiamata tris(2-amminoetil)ammina (TREN) (il nostro ingrediente B), il tutto in presenza di ioni nichel(II). Inizialmente, il nostro obiettivo era sintetizzare dei macrocicli di nichel(II) a coordinazione pentadentata, simili ad altri che avevamo già studiato. Ma la chimica, si sa, è piena di sorprese!
Con nostra grande meraviglia, i dati cristallografici hanno rivelato una formazione inaspettata: invece del macrociclo atteso, avevamo ottenuto due nuovi complessi isomorfici di nichel(II) che incorporavano un legante a base di acridina, che abbiamo chiamato [NiLACR](X)2·CH3CN (dove X è BF4– per il complesso 1 e ClO4– per il complesso 2, e LACR è il nostro nuovo legante acridinico). E la resa? Un soddisfacente 60% circa, con una reazione “one-pot”, cioè tutto nello stesso recipiente. Un bel colpo!

A quanto ne sappiamo, questo è solo il secondo esempio di un riarrangiamento mediato da un metallo a partire dal 2,2′-dpadc per formare un complesso metallico a base di acridina. Questo risultato non fa che confermare la validità di questi approcci “metal-mediated” come promettenti alternative per la sintesi di composti acridinici.
Identikit dei Nuovi Complessi
Ovviamente, da bravi scienziati, non ci siamo fidati solo dei nostri occhi. Abbiamo “interrogato” i nostri nuovi complessi con tutte le tecniche possibili e immaginabili:
- Cristallografia a raggi X: Questa tecnica ci ha permesso di vedere la loro struttura tridimensionale esatta. Immaginate una sorta di “carta d’identità” molecolare. Il nichel(II) al centro è coordinato da cinque atomi di azoto del legante, in una geometria a bipiramide trigonale distorta. È affascinante vedere come queste molecole si organizzano nello spazio, formando addirittura dei dimeri supramolecolari grazie a interazioni π-π tra i nuclei acridinici e poi delle colonne unidimensionali tramite legami a idrogeno!
- Spettroscopia UV-vis: Abbiamo studiato come assorbono la luce. E qui, una conferma importante: abbiamo osservato una banda di assorbimento caratteristica intorno ai 360 nm, tipica proprio del gruppo acridinico.
- Analisi elementare CHN: Per confermare che ci fossero tutti gli atomi giusti (Carbonio, Idrogeno, Azoto) nelle proporzioni corrette.
- Analisi termogravimetrica (TGA): Per testare la loro stabilità al calore.
- Voltammetria ciclica: Per studiare le loro proprietà elettrochimiche, cioè come si comportano quando vengono sottoposti a un potenziale elettrico.
Il Meccanismo: Come Avviene la “Magia”?
Ma come avviene questo riarrangiamento così particolare? Basandoci sul precedente lavoro con il cobalto, abbiamo proposto un meccanismo plausibile. Immaginate il nichel come un abile regista:
- Inizialmente, il 2,2′-dpadc reagisce con il TREN attraverso una condensazione di Schiff, formando un “braccio” imminico.
- Successivamente, questo braccio imminico viene “attivato” dal nichel(II). Questo rende l’atomo di carbonio dell’immina più elettrofilo, cioè più prono a subire un attacco.
- A questo punto, avviene una ciclizzazione a 6 membri.
- Seguono un paio deprotonazioni per ri-aromatizzare il sistema, portando alla formazione del nucleo acridinico con un “braccio” carbonilico pendente. Nel frattempo, il sale di nichel(II) e il TREN vengono rilasciati di nuovo in soluzione.
- Infine, l’acridina con il braccio carbonilico e il TREN subiscono un’ulteriore condensazione di Schiff, questa volta templata dal nichel, per formare il complesso finale a base di acridina.
Sembra complesso, ma è un elegante balletto molecolare orchestrato dal nichel!
Perché Proprio il Nichel?
Una domanda sorge spontanea: perché proprio il nichel funziona così bene in questa reazione? Abbiamo provato anche con altri ioni metallici di transizione, come Co(BF4)2, Fe(acac)3, o persino con un acido di Lewis non metallico come BF3. Purtroppo, in questi casi, non abbiamo osservato la caratteristica banda di assorbimento dell’acridina a 360 nm, segno che il riarrangiamento non avveniva o portava a sostanze non identificate.
Curiosamente, usando Cu(BF4)2, abbiamo ottenuto un complesso macrociclico diverso, [CuLN5MCC](BF4), senza alcuna traccia di formazione di acridina. Utilizzando invece Cu(ClO4)2, abbiamo ottenuto una miscela di prodotti, tra cui un complesso di rame con il nostro legante acridinico, [CuLACR(ClO4)]+, e il macrociclo [CuLN5MCC]+. Purtroppo, non siamo riusciti a isolare il complesso acridinico di rame puro per una caratterizzazione completa.
Quindi, tra i sali metallici testati, solo Ni(BF4)2 e Ni(ClO4)2 sono stati in grado di mediare efficacemente il riarrangiamento del 2,2′-dpadc con TREN per dare i nostri complessi acridinici purificati. L’esclusività degli ioni Ni2+ in questa particolare reazione potrebbe essere attribuita alle loro dimensioni e alla loro acidità di Lewis, ma è un aspetto che merita ulteriori approfondimenti, magari con calcoli DFT.
Un’Applicazione Scintillante: Produzione di Idrogeno!
Ma a cosa servono questi nuovi complessi, oltre ad essere affascinanti dal punto di vista strutturale? Qui arriva un’altra parte entusiasmante: abbiamo testato il nostro complesso 1 ([NiLACR](BF4)2) per la reazione di sviluppo di idrogeno (HER). L’idrogeno, come sapete, è considerato un combustibile pulito del futuro, e trovare modi efficienti ed economici per produrlo è una delle sfide cruciali del nostro tempo. Molti complessi di nichel(II) con leganti imminici si sono già dimostrati promettenti in questo campo.
Abbiamo quindi messo alla prova il complesso 1. In una soluzione di DMF contenente acido acetico come fonte di protoni, abbiamo applicato un potenziale elettrico e… voilà! Abbiamo iniziato a vedere un aumento della corrente catalitica, segno che il nostro complesso stava lavorando per produrre idrogeno. E lo faceva decisamente meglio del semplice sale di nichel(II) (Ni(BF4)2) da solo.
Per quantificare, abbiamo condotto un’elettrolisi a potenziale controllato (-2.1 V vs. Fc/Fc+) per un’ora. Il risultato? Una produzione di 16 micromoli di H2 con un’efficienza faradica del 40%. Questo significa che il 40% della corrente elettrica fornita è stata effettivamente utilizzata per produrre idrogeno. Inoltre, la corrente è rimasta stabile per tutta l’ora di elettrolisi, indicando una buona stabilità del nostro catalizzatore in queste condizioni operative.

Certo, un’efficienza del 40% è considerata moderata se confrontata con altri catalizzatori a base di nichel riportati in letteratura (che arrivano anche al 46-94%), ma è un punto di partenza decisamente incoraggiante! Ci sono ampi margini di miglioramento, ad esempio modificando ulteriormente la struttura del legante o immobilizzando il nostro catalizzatore molecolare su materiali carboniosi per aumentarne l’efficienza e la stabilità.
Conclusioni e Prospettive Future
In conclusione, abbiamo messo a punto una sintesi facile e “one-pot” per nuovi complessi pentadentati di nichel(II) contenenti un legante a base di acridina, ottenuti tramite un interessante riarrangiamento mediato dal nichel. La presenza dell’acridina è stata confermata da diverse tecniche, inclusa la cristallografia a raggi X.
Ma la cosa più entusiasmante è che questo approccio sintetico apre la strada alla progettazione razionale e alla sintesi agevole di una vasta gamma di nuovi leganti a base di acridina. E questo, a sua volta, facilita l’esplorazione di questi leganti e dei loro corrispondenti complessi metallici in svariate applicazioni, che vanno dalle trasformazioni organiche all’elettrocatalisi (come abbiamo visto con la produzione di idrogeno), alla fotocatalisi e persino ad applicazioni biologiche.
Insomma, la chimica è un’avventura continua, piena di sorprese e di potenzialità. E noi siamo entusiasti di aver aggiunto un piccolo, ma speriamo significativo, tassello a questo affascinante puzzle. Chissà quali altre meraviglie ci riserveranno in futuro questi versatili composti a base di acridina!
Fonte: Springer