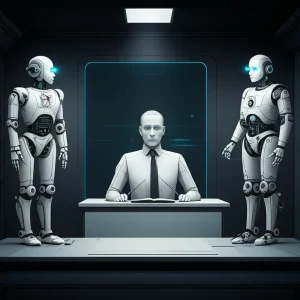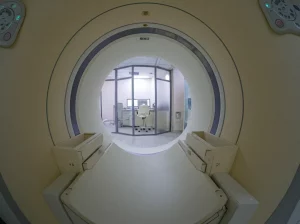IA e Cervelli Umani: L’Alleanza Inaspettata per Far Decollare l’Economia?
Amici, mettetevi comodi perché oggi parliamo di un tema che scotta, uno di quelli che ci fa chiedere: “Ma dove andremo a finire?”. Sto parlando del rapporto, sempre più stretto e, diciamocelo, un po’ inquietante, tra Intelligenza Artificiale (IA) e noi, esseri umani, o meglio, il nostro capitale umano. E la domanda da un milione di dollari è: questa strana coppia può davvero essere la chiave per una crescita economica che non si ferma mai? Vi anticipo subito: la risposta è complessa, ma affascinante.
Un Modello per Capire: L’IA entra in Scena
Immaginatevi un laboratorio di economisti che, invece di alambicchi e provette, usa modelli matematici. Ecco, l’articolo da cui prendo spunto fa proprio questo: costruisce un modello analitico per esplorare come la graduale sostituzione del lavoro umano con processi automatizzati, grazie all’IA, impatti la crescita. E qui salta fuori una parola chiave: simbiosi. Sembra quasi una storia d’amore hi-tech, dove l’espansione dell’IA e l’accumulo di capitale umano (cioè le nostre competenze, la nostra formazione) si alimentano a vicenda, diventando il motore di una crescita sostenuta nel lungo periodo.
Però, come in ogni buona storia, ci sono diverse versioni. Il modello ne analizza due principali. Nella prima, abbiamo il “capitalista rappresentativo”, una sorta di pianificatore super-ottimale, mentre i lavoratori, che non sono tutti uguali ma hanno diversi livelli di produttività, consumano tutto quello che guadagnano (i cosiddetti “hand-to-mouth consumers”). Nella seconda versione, invece, la distinzione è meno netta: tutti gli agenti economici, che siano lavoratori o investitori, pianificano il loro futuro finanziario, consumando e risparmiando. Perché questa differenza è così importante? Beh, perché ci aiuta a capire chi, alla fine della fiera, si metterà in tasca i benefici delle tecnologie che “rubano” il lavoro.
Lavoro Eterogeneo e il Dilemma dell’Automazione
Un punto cruciale su cui si basa tutto il ragionamento è che il lavoro non è un blocco monolitico. Siamo tutti diversi, con livelli di produttività distinti. Più sei produttivo, più le tue competenze sono raffinate, più i compiti che puoi svolgere sono sofisticati. E, in un mercato competitivo, il tuo stipendio riflette questa produttività. Fin qui, tutto abbastanza intuitivo.
Ora, entra in gioco l’IA. Quando conviene a un’azienda sostituire un lavoratore umano con una macchina o un algoritmo? Semplice: quando il costo dell’automazione per svolgere lo stesso compito, con lo stesso risultato, è inferiore al salario del lavoratore. I salari variano con la produttività, ma i costi dell’automazione seguono una logica diversa, legata al concetto di polarizzazione del lavoro. Questo fenomeno, che magari avete già sentito nominare, ci dice che i lavori a media qualifica, quelli più routinari e codificabili, sono i primi a saltare, perché automatizzarli costa relativamente poco. I lavori ai due estremi della scala delle competenze, invece, resistono di più: da un lato quelli altamente creativi e sofisticati (costosi da automatizzare efficacemente), dall’altro quelli che richiedono un “tocco umano” – pensate alla cura dei bambini, ai parrucchieri – che, pur non richiedendo competenze stratosferiche, implicano una sorta di conoscenza tacita (buon senso, empatia) che le macchine faticano ad avere. Anche se, attenzione, l’IA sta imparando in fretta anche questo!

Quando l’IA diventa più efficiente e “conquista” sempre più mansioni umane, i lavoratori vengono ricollocati. Alcuni, incapaci di acquisire nuove competenze, scivolano verso lavori a bassa produttività. Altri, invece, assimilano nuove skill e vengono promossi a impieghi altamente qualificati. Si crea così una sorta di “spaccatura” nella distribuzione della produttività del lavoro, con un vuoto centrale dominato dall’IA.
La Simbiosi che Genera Crescita Endogena
Ed è qui che la magia, o meglio la simbiosi, entra in gioco. La crescita sostenuta, secondo questo modello, nasce proprio da questa interazione: la penetrazione dell’IA porta a lavori più qualificati, che a loro volta permettono ai lavoratori di sviluppare ulteriori soluzioni di IA. Una volta implementate queste nuove soluzioni, spingono un’altra parte dei lavoratori ancora più a destra nella scala della produttività. È un circolo virtuoso, un loop che non finisce mai e che si traduce in crescita endogena, cioè una crescita che si autoalimenta dall’interno del sistema.
Ma, e c’è sempre un ma, tutti beneficiano di questa sostituzione progressiva degli umani con macchine e algoritmi? La risposta, come accennavo prima, dipende dalla struttura economica che ipotizziamo.
- Se viviamo in un’economia dove ogni singolo individuo è un pianificatore ottimale, che lavora, consuma e risparmia (investe), allora la transizione verso l’economia dei robot e dell’IA è favorevole a tutti. I guadagni di ognuno cresceranno tanto quanto l’economia.
- Se, invece, c’è una netta separazione tra capitalisti e lavoratori, e questi ultimi consumano tutto il loro stipendio, la faccenda cambia. Il reddito del proprietario del capitale e i salari dei lavoratori altamente qualificati potrebbero crescere al ritmo dell’economia, ma il salario dei lavoratori poco qualificati rimarrebbe costante. Una bella fregatura per alcuni, non trovate?
La storia della crescita economica è anche la storia delle scoperte tecnologiche. Ogni volta che l’ingegno umano ha generato idee capaci di creare valore, l’economia è progredita e il tenore di vita è migliorato. Le recenti ondate di innovazione, come l’automazione intensiva e la rapida diffusione dell’IA, sono particolarmente impattanti. C’è chi la vede nera: sostituzione massiccia del lavoro, pressione al ribasso sui salari, disoccupazione, aumento delle disuguaglianze e tensioni sociali. Le prove che i robot “rubino” posti di lavoro e che il lavoro umano stia diventando obsoleto in molti settori non mancano.
Dall’altro lato, c’è chi è più ottimista e vede l’IA come una nuova “tecnologia general purpose” con il potenziale di avere un impatto positivo e pervasivo. L’IA potrebbe non solo aumentare la produttività, ma anche essere uno strumento vitale per creare lavori nuovi e migliori. Si parla addirittura di “singolarità”, un momento in cui le macchine raggiungeranno una superintelligenza rendendo obsoleto tutto il lavoro umano. Anche se, diciamocelo, questa sembra più fantascienza per ora. Un motivo per non saltare a conclusioni affrettate è che l’IA, nonostante le sue capacità prodigiose, è essenzialmente una tecnologia di predizione. Ma per generare valore, le aziende hanno bisogno anche di decisione, e la decisione è (e dovrebbe rimanere) un compito eminentemente umano. Quindi, più che una minaccia, l’IA potrebbe essere un’opportunità per spostare i lavoratori dai compiti di predizione a quelli decisionali.

La verità, probabilmente, sta nel mezzo. Siamo a un bivio: politiche efficaci possono indirizzarci verso un percorso virtuoso di crescita della produttività, equa distribuzione del reddito e innovazione che valorizza il lavoro; politiche mal concepite potrebbero spingerci verso un circolo vizioso di concentrazione del potere di mercato, forte disuguaglianza e società senza lavoro.
Il Percorso di Crescita Bilanciata e le Implicazioni Distributive
Il modello analizza anche cosa succede nel lungo periodo, nel cosiddetto “percorso di crescita bilanciata” (BGP). In questo scenario ideale, ci si aspetta che alcune variabili chiave (come il limite inferiore della produttività dei lavori non automatizzati) rimangano costanti, mentre altre (come il parametro legato ai costi di creatività dell’IA e il limite superiore della produttività dei lavori automatizzabili) crescano a un tasso costante. Anche la produttività dei lavori a bassa qualifica tenderebbe a rimanere costante, mentre quella dei lavori ad alta qualifica e la produttività “delle macchine” crescerebbero. Di conseguenza, anche il capitale aggregato e il reddito crescerebbero a questo tasso costante.
Ma torniamo alla domanda cruciale: chi ci guadagna?
Nel BGP, se c’è separazione tra capitalisti e lavoratori “hand-to-mouth”:
- I rendimenti del capitalista crescono al tasso di crescita dell’economia.
- I salari dei lavoratori altamente qualificati crescono anch’essi al tasso di crescita dell’economia.
- I salari dei lavoratori poco qualificati, ahimè, rimangono stagnanti.
Il divario tra chi ha competenze elevate (e magari capitale) e chi no si allarga a dismisura.
Se invece tutti sono pianificatori ottimali (lavorano, consumano, risparmiano/investono):
- Il reddito di tutti i gruppi di agenti (sia a bassa che ad alta qualifica) cresce al tasso di crescita dell’economia.
In questo caso, il “premio” per le competenze elevate (skill premium) rimane costante nel tempo una volta raggiunto il BGP, perché tutti beneficiano della crescita generale, anche se in misura diversa in base alla loro produttività iniziale e alla loro capacità di accumulare capitale.
Cosa Possiamo Imparare?
Da tutta questa analisi, cosa mi porto a casa? Alcune idee fondamentali:
- La polarizzazione del lavoro è reale. I lavoratori “spiazzati” dall’IA o si accontentano di lavori meno qualificati e peggio pagati, o si adattano, acquisiscono nuove competenze e si spostano verso lavori più qualificati. La performance dell’economia dipende molto da quanti scelgono (o possono scegliere) la seconda strada.
- La simbiosi tra capitale umano qualificato e IA può davvero generare crescita endogena. Più cervelli al lavoro per migliorare l’IA, migliore l’IA che a sua volta crea spazio per lavori ancora più qualificati. Un bel circolo, se funziona.
- Gli effetti redistributivi sono enormi e dipendono dalla struttura socio-economica. Se c’è una netta divisione tra chi possiede il capitale e chi lavora per vivere alla giornata, i lavoratori meno qualificati rischiano di rimanere indietro. Se, invece, tutti hanno la possibilità di risparmiare, investire e quindi partecipare ai rendimenti del capitale (incluso quello “incorporato” nell’IA), allora tutti possono beneficiare delle nuove tecnologie.
Si potrebbe pensare che la soluzione sia semplice: stimolare tutti a diventare pianificatori ottimali. Bello a dirsi, ma non sempre possibile. C’è chi non può risparmiare perché deve arrivare a fine mese, chi non ha le competenze finanziarie per farlo, chi semplicemente non ha l’autocontrollo. Ed è qui che l’intervento pubblico diventa cruciale: per aiutare i lavoratori nella transizione verso lavori di qualità, per promuovere l’alfabetizzazione finanziaria, e sì, anche con politiche redistributive per mitigare gli impatti negativi dell’automazione e rendere i benefici dell’IA accessibili a tutti.
Insomma, la sfida è complessa, ma capire queste dinamiche è il primo passo per provare a governarle, invece di subirle. E voi, cosa ne pensate? Siamo pronti per questa simbiosi?

Fonte: Springer