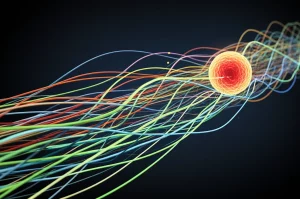Sicurezza Ambientale e Sviluppo: Sveliamo il Legame Nascosto con Fonti e Flussi!
Ciao a tutti! Oggi voglio parlarvi di qualcosa che mi affascina profondamente: il legame, spesso sottovalutato ma assolutamente vitale, tra l’ambiente che ci circonda, la nostra sicurezza e il nostro sviluppo. Sembrano concetti separati, vero? Da una parte la natura, dall’altra la nostra crescita economica e sociale, e in un angolo la sicurezza, quasi fosse solo una questione militare o di polizia. Ma se vi dicessi che sono facce della stessa medaglia, strettamente intrecciate proprio grazie all’ambiente?
Perché Separare Ciò Che è Unito?
Vedete, per troppo tempo abbiamo studiato lo sviluppo (pensate alla crescita economica, al benessere sociale) e la sicurezza (come la protezione da minacce, carestie, disastri) come se fossero compartimenti stagni. Anche discipline importanti come la Geografia Economico-Ambientale (EEG) o gli studi sui Servizi Ecosistemici (ES) si sono concentrate molto sui benefici che traiamo dall’ambiente, su come le risorse naturali alimentano le nostre economie o su come gli ecosistemi ci “servono”. Importantissimo, certo! Ma cosa succede quando l’ambiente, invece di darci una mano, diventa una fonte di rischio? Pensate alla scarsità d’acqua, all’insicurezza alimentare, ai disastri climatici. Questi aspetti, legati alla sicurezza, spesso rimangono ai margini.
Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite ci spingono proprio a guardare il quadro completo, a integrare la sostenibilità con la sicurezza energetica, l’equità, il benessere. Serve un modo nuovo, più olistico, per capire come l’ambiente influenzi *entrambi* gli aspetti: la nostra prosperità e la nostra vulnerabilità.
La Mia Proposta: Un Framework Basato su Fonti e Flussi
Ed è qui che entra in gioco l’idea che voglio esplorare con voi. Ho pensato a un quadro concettuale, che ho chiamato Sicurezza Ambientale e Sviluppo (ESD), che cerca proprio di unire questi puntini. L’idea di base è semplice ma potente: analizzare l’impatto ambientale sulla sicurezza e sullo sviluppo di un “sistema” (che può essere una comunità, una città, una regione, persino un ecosistema) attraverso i concetti di Fonte e Flusso.
Non sto parlando solo di fiumi! Immaginate l’ambiente come un insieme di “fonti”. Alcune sono benefiche (le chiameremo Be-source): risorse naturali, aria pulita, informazioni utili, infrastrutture efficienti. Altre sono deleterie (De-source): inquinamento, eventi climatici estremi, scarsità di risorse essenziali, disinformazione.
Queste fonti generano dei “flussi” (Be-flow e De-flow) che possono raggiungere il nostro sistema. Ma attenzione, non è automatico! Qui entra il terzo elemento chiave: l’Accesso. Il sistema deve poter accedere ai flussi benefici e, idealmente, bloccare o gestire quelli deleteri. Ecco il concetto di Fonte-Accesso-Flusso (SAF).

Il Modello Cella: Semplificare per Capire
Per rendere tutto più chiaro, ho immaginato un modello semplificato, il Modello Cella. Pensate a una cellula (il nostro sistema) immersa nel suo ambiente. Ignorando per un attimo le complessità interne della cellula, la sua salute (sicurezza) e la sua crescita (sviluppo) dipendono da cosa assorbe dall’esterno.
- Se assorbe più “nutrimento” (flussi benefici) che “tossine” (flussi deleteri), cresce e prospera (sviluppo).
- Se assorbe più “tossine” che “nutrimento”, soffre e rischia di deperire (problema di sicurezza).
- Se non ci sono flussi significativi, in questa visione semplificata, rimane stabile.
Questo modello ci aiuta a visualizzare come l’equilibrio tra flussi positivi e negativi dall’ambiente sia cruciale. La cosa interessante è che sviluppo e sicurezza diventano due lati della stessa interazione: quando il flusso ambientale è positivo, parliamo di sviluppo; quando è negativo, la questione si sposta sulla sicurezza.
Mappare l’Ambiente: La Bussola Cella
Ma come sono distribuite queste fonti benefiche e deleterie intorno al nostro sistema? La realtà è complessa, tridimensionale, a volte persino immateriale (pensate alle informazioni!). Per non perderci, ho proposto un altro strumento di semplificazione: la Bussola Cella (CC). Immaginiamo di dividere l’ambiente circostante in quattro direzioni cardinali: Nord, Est, Sud, Ovest. Per ogni direzione, possiamo indicare se prevale una fonte benefica (che indichiamo con 1) o deleteria (-1).
Questo ci dà 16 possibili “pattern” ambientali. Li ho raggruppati in categorie principali:
- Full: Tutte le direzioni sono benefiche (P1 – il top!) o tutte deleterie (P6 – il peggio!).
- Half: Un equilibrio tra fonti benefiche e deleterie (P3 e P4).
- Partial: Una maggioranza di fonti benefiche (P2) o deleterie (P5).
Ovviamente, per uno sviluppo efficiente, un sistema dovrebbe “preferire” ambienti come P1, P2 o P3, dove le fonti benefiche abbondano o sono almeno bilanciate, e cercare di evitare P4, P5 e P6. La classifica intuitiva è: P1 > P2 > P3 > P4 > P5 > P6.

Le Strategie del Sistema: Agire e Reagire
Ma non basta trovarsi nell’ambiente giusto. Il sistema deve anche agire! Deve decidere come interagire con le fonti circostanti. Anche qui, possiamo usare la Bussola Cella per mappare le azioni del sistema. Per ogni direzione, il sistema può scegliere di essere “accessibile” (1) o “inaccessibile” (0).
Questo genera altre 16 possibili strategie di azione, che ho classificato in base al numero di direzioni accessibili:
- Isola (A1): 0 accessi. Il sistema si chiude completamente. Ottimo per la sicurezza in un ambiente ostile, pessimo per lo sviluppo se l’ambiente è ricco di opportunità.
- Penisola (A2, A5): 1 o 3 accessi. Il sistema è parzialmente aperto, con un lato protetto o esposto.
- Valle/Canyon (A3, A4): 2 accessi. Un equilibrio tra apertura e chiusura.
- Pianura (A6): 4 accessi. Massima apertura. Ideale per lo sviluppo in un ambiente totalmente benefico, ma estremamente rischioso in un ambiente deleterio.
La scelta della strategia giusta dipende ovviamente dal pattern ambientale! Un sistema saggio cercherà di adottare una strategia “Pianura” (A6) in un ambiente “Full Be-source” (P1) e una strategia “Isola” (A1) in un ambiente “Full De-source” (P6).
Valutare il Risultato: Sviluppo o Rischio?
Come valutiamo l’esito di questa interazione tra pattern ambientale e strategia del sistema? Ho proposto un modo semplice per calcolare un “Tipo di Sviluppo” (DT). In pratica, si moltiplica il valore della fonte in ogni direzione (1 o -1) per il valore dell’azione in quella direzione (1 o 0) e si sommano i risultati.
Un esempio?
Ambiente P1 (1, 1, 1, 1) + Azione A6 (1, 1, 1, 1) = Risultato R1. DT = (1*1)+(1*1)+(1*1)+(1*1) = 4 (Massimo sviluppo!)
Ambiente P6 (-1, -1, -1, -1) + Azione A1 (0, 0, 0, 0) = Risultato R6. DT = (-1*0)+(-1*0)+(-1*0)+(-1*0) = 0 (Nessun impatto negativo, sicurezza garantita ma zero sviluppo da fonti esterne).
Ambiente P6 (-1, -1, -1, -1) + Azione A6 (1, 1, 1, 1) = Risultato R?. DT = (-1*1)+(-1*1)+(-1*1)+(-1*1) = -4 (Massima insicurezza/declino!).
Analizzando le combinazioni (sono 256 in totale!), possiamo classificare i risultati e capire quali combinazioni ambiente-azione portano a un maggiore sviluppo e quali invece a maggiori rischi per la sicurezza.

Oltre la Teoria: Efficienza, Complessità e Applicazioni
Finora abbiamo semplificato molto. Nella realtà:
- Fonti Statiche vs Dinamiche: Alcune fonti richiedono un investimento attivo per essere sfruttate (es. estrarre petrolio – fonte statica), altre arrivano “gratis” (es. la pioggia – fonte dinamica). Questo influenza i costi e l’efficienza.
- Soggettività: Ciò che è benefico per un sistema potrebbe non esserlo per un altro, o potrebbe cambiare nel tempo.
- Trasformazione: A volte, con la tecnologia o l’ingegno, possiamo trasformare una fonte deleteria in benefica (pensate ai rifiuti riciclati).
Per tener conto di questo, ho anche abbozzato dei modi per calcolare il Livello di Sviluppo (DL) (benefici – perdite – investimenti) e l’Efficienza dello Sviluppo (DE) (livello di sviluppo / investimenti totali). Questo ci permette di confrontare strategie diverse: a parità di risultato, una strategia che richiede meno investimenti è più efficiente.
Dove si applica tutto questo? Beh, potenzialmente ovunque! Dalla scelta di dove fondare una città (considerando risorse idriche, terreni coltivabili, vie di trasporto, ma anche rischi di inondazioni o clima avverso) alla gestione della salute pubblica (come abbiamo visto analizzando la diffusione del COVID-19 in relazione alla conformazione del territorio, che influenza flussi e accessi). Anche la pianificazione di spazi verdi urbani per il benessere e la resilienza rientra in questa logica.
Un Lavoro in Corso, Ma un Passo Avanti
Certo, questo framework ESD e il Modello Cella sono ancora in fase teorica. È una base, un modo nuovo di pensare che integra sicurezza e sviluppo sotto l’ombrello dell’influenza ambientale. C’è ancora tanto lavoro da fare: testare il modello con dati reali, studiare casi specifici, affinare i metodi di calcolo, considerare la dinamica evolutiva (come i sistemi modificano l’ambiente e viceversa).
Ma spero che questo approccio basato su fonti, accessi e flussi possa offrirci una lente più potente e integrata per affrontare le complesse sfide del nostro tempo, dove la salute del pianeta e la nostra sono indissolubilmente legate. Dobbiamo imparare a leggere meglio i messaggi che l’ambiente ci manda, sia quelli positivi che quelli negativi, per navigare con più saggezza verso un futuro che sia davvero sicuro e sostenibile per tutti.

Fonte: Springer