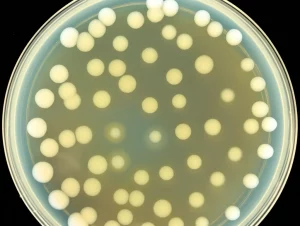Seta di Ragno dal Muschio: La Rivoluzione Verde nei Biomateriali!
Ciao a tutti! Oggi voglio parlarvi di qualcosa che sembra uscito da un film di fantascienza, ma che sta diventando realtà grazie alla biotecnologia: la seta di ragno prodotta… dal muschio! Sì, avete capito bene. Quel materiale incredibile, noto per essere una delle fibre naturali più resistenti e tenaci, potrebbe presto essere prodotto in modo sostenibile ed efficiente grazie a una piccola pianta, il muschio Physcomitrella patens.
La Seta di Ragno: Un Materiale da Sogno con una Produzione da Incubo
Partiamo dalle basi. La seta di ragno, in particolare quella “dragline” che i ragni usano per la struttura portante della ragnatela e come linea di sicurezza, è un vero portento della natura. Combina una resistenza alla trazione pazzesca (paragonabile a quella di molte fibre sintetiche commerciali) con un’elasticità notevole. Questa combinazione la rende incredibilmente tenace, capace di assorbire enormi quantità di energia prima di rompersi.
Le applicazioni potenziali sono vastissime:
- Industria tessile: per creare tessuti ad alte prestazioni.
- Materiali compositi: per rinforzare altri materiali.
- Plastiche biodegradabili: un’alternativa ecologica.
- Medicina: è biocompatibile, non scatena reazioni immunitarie ed è quindi perfetta per suture, guarigione delle ferite, ingegneria tissutale (come vasi sanguigni artificiali o supporto per la rigenerazione nervosa), biosensori degradabili e scaffold per la crescita cellulare.
Il problema? Ottenere questa seta in grandi quantità è praticamente impossibile. I ragni sono creature territoriali e cannibali, il che rende l’idea di “allevamenti” di ragni per la seta del tutto impraticabile su scala industriale. Un vero peccato, vista la meraviglia che producono!
La Sfida della Produzione Ricombinante
Qui entra in gioco la biotecnologia. L’idea è semplice: prendiamo i geni responsabili della produzione delle proteine della seta di ragno (le cosiddette spidroine, in particolare le MaSp1 e MaSp2 per la seta dragline) e li inseriamo in un altro organismo che possa fungere da “fabbrica biologica”. Sembra facile, no? Beh, non proprio.
Negli anni, abbiamo provato di tutto:
- Batteri (come E. coli): Spesso le proteine della seta, con le loro sequenze ripetitive, tendono ad aggregarsi in modo errato o a degradarsi.
- Lieviti (come Pichia pastoris): Anche qui, problemi di bassa espressione e degradazione delle proteine.
- Cellule di mammifero e animali transgenici (come capre): Si è riusciti a produrre seta nel latte di capra, ma le rese sono generalmente basse e i costi alti.
- Insetti: Evolutivamente più vicini ai ragni, ma i processi sono lenti.
- Piante (come tabacco e Arabidopsis): Hanno mostrato qualche successo, ma le rese rimangono basse e le proprietà meccaniche delle fibre prodotte non eguagliano quelle naturali.
La struttura stessa delle spidroine è complessa. Sono proteine grandi, con una lunga regione centrale ripetitiva (che conferisce le proprietà meccaniche) fiancheggiata da due domini terminali, l’N-terminale (NTD) e il C-terminale (CTD). Questi domini sono cruciali: aiutano la proteina a rimanere solubile all’interno della ghiandola del ragno e poi giocano un ruolo chiave nell’innescare la formazione della fibra quando serve, spesso in risposta a cambiamenti di pH o stress meccanici. Produrre queste proteine complete e funzionali in un altro organismo è una vera sfida ingegneristica.

Physcomitrella: Il Muschio che Potrebbe Cambiare Tutto
E qui arriviamo alla nostra star: il muschio Physcomitrella patens (recentemente rinominato Physcomitrium patens). Perché proprio il muschio? Beh, Physcomitrella è un organismo modello fantastico per la produzione di proteine ricombinanti complesse.
Ecco alcuni dei suoi superpoteri:
- Ingegneria genetica precisa: È incredibilmente facile modificare il suo genoma con alta precisione, inserendo geni esattamente dove vogliamo.
- Produzione di proteine complesse: Ha già dimostrato di saper produrre proteine umane complesse e difficili da esprimere altrove, come l’eritropoietina o il Fattore H del complemento (una proteina da 150 kDa con 20 domini ripetitivi!).
- Modifiche post-traduzionali: È capace di eseguire modifiche come la glicosilazione (l’aggiunta di zuccheri alle proteine), che potrebbero essere importanti per la funzione di alcune proteine, anche se nel caso della seta di ragno il loro ruolo è ancora dibattuto.
- Secrezione delle proteine: Possiamo ingegnerizzarlo per secernere le proteine prodotte direttamente nel mezzo di coltura, semplificando enormemente la purificazione.
- Coltivazione in fotobioreattori: Può essere coltivato su larga scala in bioreattori illuminati, in modo controllato e sicuro.
Insomma, sembrava il candidato ideale per affrontare la sfida della seta di ragno.
Il Nostro Esperimento: Far Produrre Seta al Muschio
Cosa abbiamo fatto, quindi? Abbiamo preso il gene per una delle proteine chiave della seta dragline del ragno vedova nera occidentale (Latrodectus hesperus), la LhMaSp1. Abbiamo scelto questa perché la sua seta è nota per la sua forza ed estensibilità.
Abbiamo ingegnerizzato il gene per includere sia il dominio NTD che il CTD, essenziali per una corretta formazione della fibra, insieme a una porzione della regione ripetitiva centrale (abbiamo testato versioni con 8 e 12 blocchi ripetitivi). Abbiamo anche “ottimizzato” la sequenza del DNA per renderla più “gradita” al macchinario di produzione proteica del muschio (codon usage optimization) e abbiamo aggiunto un piccolo segnale (peptide segnale APsp) per indirizzare la proteina verso la via secretoria, sperando di facilitarne la purificazione. Per poterla seguire e purificare, abbiamo aggiunto anche dei tag: una proteina fluorescente (citrina) per vederla al microscopio e un tag di istidina (His-tag) per la purificazione.
Prima abbiamo fatto dei test rapidi, inserendo temporaneamente il gene in singole cellule di muschio (protoplasti). Usando un microscopio confocale, abbiamo visto che la proteina veniva prodotta! La fluorescenza ci ha mostrato che si localizzava correttamente nel reticolo endoplasmatico (ER), il primo passo della via secretoria, anche se sembrava formare degli aggregati, forse simili alle micelle che si pensa siano precursori della fibra nella ghiandola del ragno.

Poi siamo passati alla produzione stabile. Abbiamo creato delle linee di muschio geneticamente modificate che producessero costantemente la nostra proteina LhMaSp1 (la versione con 8 ripetizioni e His-tag). Abbiamo coltivato queste linee prima in beute agitate e poi in fotobioreattori da 5 litri.
Verifica e… Sorpresa! I Multimeri Misteriosi
Come abbiamo verificato che tutto funzionasse?
- Western Blot: Usando anticorpi specifici per l’His-tag, abbiamo confermato la presenza della proteina. Abbiamo visto una banda della dimensione attesa (circa 56 kDa), ma anche segnali a peso molecolare molto più alto, come dei “multimeri” o aggregati della proteina. La cosa positiva è che non abbiamo visto frammenti più piccoli, segno che la proteina non veniva degradata, un problema comune in altri sistemi.
- Purificazione: Siamo riusciti a purificare la proteina usando il suo His-tag, confermando che era accessibile.
- Spettrometria di Massa (MS): Questa tecnica potentissima ci ha permesso di “leggere” pezzi della sequenza aminoacidica della proteina prodotta. Abbiamo confermato che era proprio la nostra LhMaSp1, con una copertura del 62% della sequenza! Abbiamo anche visto che il peptide segnale era stato correttamente rimosso e che i domini NTD e CTD erano presenti e integri.
La spettrometria di massa ci ha anche dato qualche indizio sulle modifiche post-traduzionali. Abbiamo trovato una prolina idrossilata (un’aggiunta di un gruppo -OH) nel dominio CTD, ma non abbiamo trovato prove di una glicosilazione estesa (come l’aggiunta di arabinogalattani), che avrebbe potuto spiegare gli alti pesi molecolari visti nel Western Blot.
Quindi, da dove vengono quei multimeri ad alto peso molecolare? Abbiamo fatto diversi test: abbiamo cambiato il pH dell’ambiente (la formazione della fibra nel ragno è sensibile al pH acido), abbiamo usato diversi buffer di estrazione, abbiamo aggiunto agenti riducenti (DTT) per rompere eventuali ponti disolfuro… ma niente, i multimeri rimanevano lì, solubili e apparentemente stabili.
La nostra ipotesi è che questi multimeri si formino già all’interno della cellula del muschio, forse nell’apparato del Golgi, che ha un ambiente leggermente acido che potrebbe favorire una sorta di polimerizzazione iniziale della proteina. Questo potrebbe anche essere un vantaggio, preparando la proteina per la successiva filatura in vitro. Oppure potrebbero essere aggregati non perfettamente formati. È un aspetto che richiederà ulteriori indagini.

Crescita in Bioreattore e Resa Promettente
Un aspetto cruciale era verificare se la produzione di questa proteina aliena influenzasse la crescita del muschio. Abbiamo coltivato fianco a fianco il muschio normale (wild type, WT) e la nostra linea produttrice (L33, una delle migliori) nei fotobioreattori da 5 litri per 17 giorni.
I risultati? Fantastici! La linea L33 è cresciuta praticamente come il WT, raggiungendo quasi 3 grammi di peso secco per litro di coltura, senza mostrare differenze morfologiche. Questo è importantissimo, perché significa che la produzione della proteina della seta non sembra essere tossica o stressante per il muschio, almeno a questi livelli.
E la resa? Confrontando l’intensità del segnale nel Western Blot con quella di un’altra linea di muschio di cui conosciamo la resa (la linea PK1 che produce 0.82 mg di proteina per grammo di peso fresco in condizioni ottimizzate), abbiamo stimato che la nostra linea L33 produce più di 0.82 mg di LhMaSp1 per grammo di peso fresco di muschio. È una resa molto promettente, superiore a molte riportate per altri sistemi vegetali, e apre le porte a una produzione su scala industriale economicamente vantaggiosa.

Il Futuro è Intessuto nel Muschio?
Questo studio dimostra che il muschio Physcomitrella è una piattaforma robusta, scalabile ed efficiente per produrre proteine ricombinanti della seta di ragno, incluse le versioni che contengono i domini NTD e CTD fondamentali.
Certo, la strada è ancora lunga. Dobbiamo ottimizzare ulteriormente la purificazione, capire meglio la natura dei multimeri e, ovviamente, passare alla fase successiva: provare a filare questa proteina prodotta dal muschio per ottenere delle fibre vere e proprie e testarne le proprietà meccaniche. Potremmo anche usare tecniche di assemblaggio genico per creare versioni della proteina con regioni ripetitive più lunghe, più simili a quelle naturali.
Ma i risultati sono incredibilmente incoraggianti. L’idea di poter coltivare muschio in bioreattori per produrre in modo sostenibile uno dei materiali più straordinari della natura non è più solo un sogno. Potrebbe davvero essere l’inizio di una rivoluzione verde nel campo dei biomateriali avanzati. Tenetevi forte, perché il futuro potrebbe essere intessuto… nel muschio!
Fonte: Springer