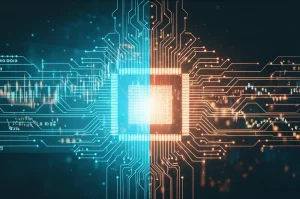Decifrare i Misteri di un Antico Tesoro: Le Impronte Molecolari Svelano i Segreti di un Manufatto in Pelle Laccata
Amici appassionati di storia e misteri, preparatevi per un viaggio affascinante nel tempo, fino alla dinastia Tang cinese (618–907 d.C.)! Oggi voglio parlarvi di come noi scienziati, un po’ come dei detective del passato, riusciamo a far parlare oggetti antichi, anche quando sono ridotti a frammenti e sembrano aver perso ogni speranza di raccontarci la loro storia. Immaginatevi di fronte a un reperto in pelle laccata, un tempo magnifico, ora segnato dal tempo e dalla terra che lo ha custodito per secoli. Come facciamo a sapere di cosa è fatto esattamente e come è stato creato?
Un Tesoro dalla Tomba: Il Contesto della Scoperta
Tutto inizia con un ritrovamento: un manufatto in pelle laccata, scoperto in una tomba della dinastia Tang nella provincia di Henan, in Cina, nel dicembre 2020. Non un oggetto qualsiasi, ma probabilmente una borsa, che al suo interno custodiva un altro pezzo da novanta: uno specchio in bronzo decorato con motivi di vita marina e uva, tipico di quel periodo. Pensate, questi oggetti erano spesso corredi funerari, simboli dello status sociale del defunto. La tomba stessa, con il suo lungo passaggio inclinato e la camera principale con soffitto a volta, insieme alla posizione dello scheletro, ci ha subito indirizzato verso la dinastia Tang. La zona del ritrovamento, l’antica contea di Shanyang (oggi Jiaozuo), era un crocevia importante all’epoca, con un’economia fiorente. Questo ritrovamento è una perla rara, perché la combinazione di pelle e lacca, sebbene esistente, non è così ampiamente documentata nell’archeologia cinese come altri materiali.
La Sfida dei Materiali Organici: Perché è Così Difficile?
A differenza della ceramica o dei metalli, i materiali organici come la pelle sono dei veri e propri “deboli di cuore”. Umidità, temperatura, microbi… tutto congiura contro di loro nel corso dei secoli. La pelle, composta principalmente da collagene, è particolarmente sensibile. Immaginate le sue fibre che si degradano, la sua struttura che cambia, i dettagli della lavorazione che svaniscono. Questo rende lo studio e la conservazione di questi reperti una vera e propria corsa contro il tempo e una sfida per la nostra ingegnosità. E quando parliamo di pelle laccata, la faccenda si complica ulteriormente, perché abbiamo due materiali organici, ognuno con le sue vulnerabilità, uniti in una tecnica artigianale complessa e di grande valore estetico.
Le Nostre Armi Segrete: Le “Impronte Molecolari”
Ma come facciamo a svelare i segreti di un manufatto così deteriorato? Qui entra in gioco la magia della scienza, o meglio, delle “impronte molecolari”. Abbiamo utilizzato un arsenale di tecniche analitiche avanzate:
- Spettroscopia Infrarossa a Trasformata di Fourier (FTIR): Questa tecnica è come un faro che illumina i gruppi funzionali chimici presenti nel campione. Ci aiuta a identificare sia il collagene della pelle sia i componenti della lacca.
- Microscopia Elettronica a Scansione con Spettroscopia a Dispersione di Energia (SEM-EDS): Con questa, andiamo a vedere la microstruttura del materiale e la sua composizione elementare. È fantastica per scovare fibre residue, magari nel terreno circostante il reperto, e capire di che elementi sono fatte.
- Gascromatografia-Spettrometria di Massa con Pirolisi (Py-GC-MS): Questa è la vera star per i materiali organici complessi. “Spezzettiamo” il campione con il calore (pirolisi) e poi separiamo e identifichiamo i frammenti molecolari. È potentissima per riconoscere le “firme” chimiche specifiche, anche in campioni molto degradati.
Abbiamo anche dato un’occhiata al terreno di sepoltura con la Diffrazione dei Raggi X (XRD) per capire quali minerali fossero presenti e come l’ambiente avesse potuto interagire con il nostro manufatto.

Cosa Abbiamo Scoperto: La Pelle e la Lacca Parlano!
Analizzando i frammenti del nostro reperto e persino il terreno circostante, abbiamo iniziato a mettere insieme i pezzi del puzzle. Con il SEM-EDS, abbiamo trovato fibre residue nel terreno, composte principalmente da carbonio, azoto e ossigeno. Bingo! Questi sono gli elementi chiave del collagene, la proteina della pelle. L’analisi XRD del suolo ha rivelato la presenza di quarzo, calcite e albite, minerali che ci danno indizi sull’ambiente di sepoltura.
Poi è toccato all’FTIR. Nonostante il forte deterioramento, che aveva fatto sparire alcuni segnali tipici del collagene, abbiamo rilevato picchi caratteristici che indicavano la presenza sia di gruppi amminici (N-H) e ossidrilici (O-H) – tipici delle proteine e di altri composti organici – sia di legami C=O dell’ammide I. Un segnale importante intorno a 1031 cm-1 era dovuto alla sovrapposizione di vibrazioni di legami carbonio-ossigeno (C-O) e silicio-ossigeno (Si-O), quest’ultimo proveniente dai silicati del terreno, confermando i dati XRD. E, cosa cruciale, abbiamo visto segnali riconducibili a legami C-H di anelli benzenici sostituiti, un indizio per la lacca!
Il Cuore della Lacca: Urushiol dalla Cina
La Py-GC-MS è stata la chiave di volta per la lacca. Le lacche asiatiche provengono dalla linfa di alberi specifici. In Cina, Giappone e Corea si usa principalmente il Toxicodendron vernicifluum, la cui linfa contiene urushiol. Altre specie, come il Toxicodendron succedaneum (Vietnam, Taiwan) producono laccol, e il Gluta usitata (Sud-est asiatico) il thitsiol. La differenza sta principalmente nella lunghezza delle catene alchiliche legate ai catecoli: l’urushiol ha catene C15, il laccol C17, e il thitsiol catene ω-fenilalchiliche C10 e C12. Queste differenze si mantengono nel polimero finale e ci permettono di distinguere l’origine della lacca.
Ebbene, nel nostro manufatto, la Py-GC-MS ha rivelato la presenza di aldeidi alifatiche, catene di carbonio insature, anelli benzenici e idrocarburi a catena lunga. Più specificamente, abbiamo identificato catecoli alchil-sostituiti (con sostituzioni massime C12, e segnali principali per C6-C12) e alchilbenzeni (con sostituzioni più lunghe, principali per C11-C15). Non abbiamo trovato catecoli o benzeni con sostituzioni a catena molto lunga. Questi risultati puntano dritti all’urushiol, e quindi a una lacca proveniente dal T. vernicifluum, l’albero della lacca più diffuso in Cina. È stato come trovare una firma molecolare lasciata dall’artigiano di secoli fa!
Abbiamo anche confrontato il campione del reperto con una lacca preparata di fresco. Le differenze erano evidenti: il campione antico mostrava molti frammenti a basso peso molecolare, segno dell’invecchiamento e della rottura della struttura reticolata della lacca. La lacca nuova, invece, era più stabile termicamente. Questo confronto non solo ha confermato la presenza della lacca, ma ci ha anche dato informazioni sul suo stato di conservazione e sui meccanismi di degrado.

Un Tuffo nel Passato: Il Valore di Queste Scoperte
Capire la composizione e le tecniche di fabbricazione di questi manufatti in pelle laccata della dinastia Tang è di un valore inestimabile. Non si tratta solo di soddisfare la nostra curiosità scientifica. Queste scoperte arricchiscono la nostra comprensione della cultura materiale, delle tecnologie artigianali, degli scambi culturali e persino delle usanze funerarie della dinastia Tang. L’uso della lacca non solo migliorava la durabilità e l’estetica degli oggetti in pelle, ma simboleggiava anche lo status e la ricchezza. Ogni frammento analizzato aggiunge un tassello alla grande storia dell’ingegno umano.
In sintesi, combinando queste tecniche di “impronte molecolari”, siamo riusciti a confermare che il nostro misterioso reperto era effettivamente composto da pelle laccata, e che la lacca era molto probabilmente a base di urushiol. Questo studio dimostra quanto siano potenti questi metodi analitici, specialmente quando si ha a che fare con manufatti organici gravemente deteriorati. È una base solida per future esplorazioni dell’artigianato storico e, importantissimo, per sviluppare strategie di conservazione più efficaci per questi tesori fragili.
Non è incredibile come le molecole possano raccontarci storie così dettagliate, attraversando i secoli? La prossima volta che vedrete un reperto antico in un museo, pensate a tutto il lavoro scientifico che potrebbe celarsi dietro la sua esposizione!
Fonte: Springer