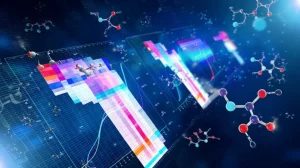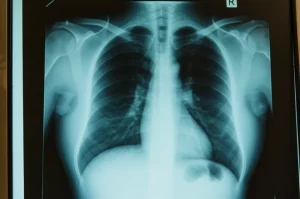Svelare le Catene Invisibili: Come Aiutiamo le Donne Rifugiate a Riconoscere il Controllo Coercitivo
Amiche e amici, parliamoci chiaro. Quando pensiamo alla violenza di coppia, spesso l’immagine che ci viene in mente è quella di un livido, di un’aggressione fisica. Ma c’è una forma di violenza più subdola, strisciante, che non lascia segni visibili sul corpo ma devasta l’anima: il controllo coercitivo. È un nemico invisibile che si insinua nelle relazioni, soffocando la libertà e l’autonomia, soprattutto di chi è già vulnerabile. E oggi voglio raccontarvi di come, nel nostro lavoro, cerchiamo di far luce su questo fenomeno, in particolare con le donne rifugiate che arrivano in un nuovo paese cercando sicurezza e un nuovo inizio.
Cos’è esattamente il controllo coercitivo? Una prigione senza sbarre
Forse vi state chiedendo cosa si intenda precisamente con “controllo coercitivo”. Non è un singolo atto, ma un modello di comportamento. Immaginate una ragnatela tessuta con cura, giorno dopo giorno, fatta di intimidazioni, isolamento, umiliazioni, controllo delle finanze, degli spostamenti, delle amicizie. L’obiettivo? Semplice e terribile: micro-gestire la vita della partner, annullare la sua volontà, renderla dipendente. Pensate che per molto tempo, l’attenzione si è concentrata quasi esclusivamente sulla violenza fisica e sessuale, quasi dimenticando che il controllo è spesso la radice di tutte le forme di abuso. Fortunatamente, grazie al lavoro di pioniere come Evan Stark, oggi si riconosce il controllo coercitivo come una forma di abuso a sé stante, che può esistere anche senza violenza fisica manifesta.
Certo, definirlo e misurarlo non è semplice. Una revisione della letteratura ha identificato ben 22 definizioni diverse! Ma tre caratteristiche sembrano emergere con costanza: l’intenzionalità dell’abusante, la percezione negativa del comportamento da parte della vittima e la capacità dell’abusante di ottenere il controllo attraverso una minaccia credibile. È come se l’abusante dicesse: “Fai come dico io, o ne pagherai le conseguenze”. E queste conseguenze non sono sempre pugni o schiaffi; possono essere la minaccia di togliere i figli, di essere cacciate di casa, di essere private del sostegno economico.
Donne rifugiate: una vulnerabilità amplificata
Ora, immaginate di essere una donna rifugiata. Siete arrivate in un paese nuovo, spesso dopo aver vissuto traumi indescrivibili. Non conoscete bene la lingua, le leggi, i servizi. Forse il vostro visto dipende dal partner. Le reti sociali sono limitate o inesistenti. Siete finanziariamente dipendenti. In questo contesto, capite bene come il rischio di subire controllo coercitivo aumenti esponenzialmente. Le minacce di deportazione o di ritiro della sponsorizzazione per il visto diventano armi potentissime nelle mani di un partner abusante. Uno studio australiano ha rivelato che le donne che non parlavano inglese a casa erano significativamente più esposte a comportamenti di controllo rispetto al campione generale. Parliamo di stalking online o di persona, insulti costanti per umiliare, danneggiamento di proprietà… un vero e proprio schema di sottomissione.
A volte, norme culturali patriarcali possono rinforzare questi comportamenti, presentando il controllo maschile come una forma di “cura” o “responsabilità”, mascherando la sua natura oppressiva. È un terreno scivoloso, dove distinguere tra protezione e prevaricazione può diventare difficile, soprattutto per chi è immersa in quella realtà da sempre.

Il nostro studio SAHAR: accendere una luce nel buio
Proprio per affrontare queste complessità, abbiamo avviato lo studio SAHAR (Safety and Health After Arrival). L’obiettivo? Migliorare l’identificazione e la risposta alla violenza di coppia subita dalle donne rifugiate che si stabiliscono in Australia, accedendo ai servizi di insediamento. Volevamo capire se fosse fattibile, in questi contesti, chiedere specificamente del controllo coercitivo, oltre che delle altre forme di violenza.
Abbiamo lavorato a stretto contatto con un gruppo di donne con esperienza diretta come rifugiate e con vissuti di violenza, e con le operatrici dei servizi. La loro guida è stata fondamentale. Inizialmente pensavamo di usare uno strumento di screening chiamato HITS, che si concentra su percosse, insulti, minacce e urla. Ma le consultazioni hanno rivelato una cosa importante: per alcune donne, minacce e insulti erano talmente normalizzati da non essere percepiti come violenza. “Solo la violenza fisica è vista come violenza domestica”, ci ha detto una partecipante. “Insultare o sminuire non è visto come una cosa grave”, ha aggiunto un’altra.
Così, abbiamo optato per lo strumento ACTS, che include domande su: essere resi Afraid (spaventati), essere Controlled (controllati), essere Threatened (minacciati) o essere Slapped/physically hurt (schiaffeggiati/feriti fisicamente). La domanda sul controllo era specifica: “Quanto spesso il suo partner/marito controlla le sue attività quotidiane (ad esempio, chi vede/dove va)?”. Lo strumento è stato tradotto nelle cinque lingue più parlate nei centri (arabo, farsi, urdu, cinese e vietnamita) e somministrato da operatrici biculturali, donne che condividevano la lingua e spesso il background culturale delle utenti.
Tradurre “controllo”: una sfida linguistica e culturale
Tradurre il concetto di “controllo” non è stato banale. Prendiamo l’arabo, parlato da quasi la metà delle utenti. Alcuni suggerivano termini come yuraqib (مراقبة), che significa “osservarti” o “guardarti costantemente”, ma sembrava troppo passivo. Altri proponevano la versione negativa di maswuwl (مسؤول), che implica “essere responsabile in modo positivo”, ma non coglieva l’aspetto coercitivo. Alla fine, dopo molte discussioni, si è optato per yatahakkam (التحكُّم), un termine che originariamente derivava da “saggezza” ma che ora è inteso negativamente, usato anche per dittatori che impongono le loro regole. Questo termine, raccomandato anche dall’agenzia di traduzione professionale, sembrava cogliere meglio la sfumatura di un controllo che limita e opprime.
Le consultazioni ci hanno anche portato a specificare meglio la domanda sulla violenza fisica, includendo “altre forme di danno fisico” per catturare comportamenti come spingere, strattonare, sputare o soffocare, spesso non riconosciuti come abuso. E la parola “paura” (afraid) è stata ritenuta più chiara e universalmente compresa di “insicurezza” (unsafe).
Cosa abbiamo scoperto? I numeri e le storie
E i risultati? Su 312 donne a cui sono state poste le domande ACTS in quattro servizi di insediamento, ben 90 (il 29%) hanno dato risposte indicative di violenza di coppia. E indovinate qual è stata la forma di abuso più frequentemente riportata? Proprio il controllo, segnalato da 78 donne su 90 (l’88% di quelle che hanno riportato abusi). Spesso, il controllo non era isolato: il 64% delle donne che hanno riportato abusi ne ha identificato due forme, e il 38% (l’11% di tutte le donne intervistate) ha risposto positivamente a tutte e quattro le domande, indicando esperienze di paura, controllo, minacce e abusi fisici. Questo sottogruppo, chiaramente, viveva una situazione di controllo coercitivo nel senso più ampio del termine.
Le operatrici ci hanno raccontato che, sebbene la domanda sul controllo fosse la meno immediata delle quattro, grazie a esempi pratici (“le impedisce di vedere la sua famiglia?”, “insiste per sapere chi vede o dove va?”) riuscivano a far emergere situazioni di controllo dannoso. Una donna ha raccontato: “Non ricevo soldi… Ho un bambino, ne ho un altro. Lui prende tutti i soldi… Non posso dire niente. Dice: ‘Ti ho portata qui. Questi sono i miei figli. Questi sono i miei soldi. Se sei molto infelice puoi tornare indietro'”. Altre hanno parlato di restrizioni ai movimenti, all’apprendimento dell’inglese, minacce di portare via i figli o di essere rimandate nel paese d’origine.

È emerso anche come, a volte, il controllo fosse mascherato da cura: “Si sentono curate quando sono controllate. O se lui gestisce i loro soldi, si sentono felici che lui faccia tutto per loro”, ha osservato un’operatrice. Ma la conversazione stessa, stimolata dalle domande, spesso portava a una presa di coscienza. “Rispondono alla domanda e poi dicono: ‘Oh, significa che vivo sotto violenza domestica da molto tempo, ma non me ne ero resa conto'”, ci ha confidato un’altra. Per molte, la violenza domestica era solo quella fisica; lo screening ha aperto gli occhi su altre realtà.
L’impatto sulle operatrici e la consapevolezza crescente
Un aspetto affascinante è stato l’impatto sulle stesse operatrici. Essendo ex rifugiate o migranti, molte provenienti dagli stessi paesi delle loro clienti, condividevano background culturali simili. “La nostra prospettiva culturale è quella di una famiglia patriarcale, giusto? Siamo cresciute così”, ha ammesso una di loro. Inizialmente, c’era una certa apprensione nel toccare un tema così delicato, e il rischio di normalizzare alcune forme di controllo era presente. “Voglio dire, il controllo, anche io penso di essere controllata da mio marito… siamo così abituate a questo tipo di controllo che forse questo è stato un ostacolo”, ha riflettuto una manager.
Tuttavia, l’intervento SAHAR ha aumentato la loro stessa consapevolezza sulle diverse forme di violenza. “Mi ha aiutato quando stavo facendo lo screening… ho letto e ho fatto delle ricerche per me stessa perché, ovviamente, non ero molto consapevole della violenza domestica. Così, ho scoperto che non c’è solo quella fisica o emotiva, ma ho imparato che c’è quella finanziaria, e ci sono così tante sottoclassi”. Questa crescita personale e professionale è cruciale.
Perché tutto questo è importante?
I nostri risultati sono coerenti con altre ricerche che indicano il comportamento di controllo come la forma più frequente di violenza di coppia per le donne rifugiate e migranti. Questo contrasta con studi su altre popolazioni, dove ad esempio la paura era l’elemento più riportato. La vulnerabilità specifica delle donne rifugiate, legata all’insicurezza del visto e alle barriere linguistiche, si aggiunge ai fattori di rischio già noti.
È fondamentale non cadere nella trappola di attribuire tassi più alti di violenza alla “cultura”, un termine spesso usato in modo razzista e per “etichettare” le culture non bianche. Le norme di genere misogine e gli squilibri di potere esistono in tutte le culture e sono fondamentali per comprendere la violenza contro le donne, ovunque. La condizione di rifugiata amplifica queste dinamiche a causa della dipendenza finanziaria, delle barriere linguistiche, della scarsa conoscenza di leggi e servizi, delle aspettative comunitarie e culturali, e di una maggiore vulnerabilità al controllo facilitato dalla tecnologia, il tutto sovrapposto ai traumi delle crisi umanitarie.
Certo, il nostro studio ha dei limiti. Non è stato possibile condurre consultazioni approfondite per la traduzione in tutte le lingue. Ed è possibile che alcune donne non abbiano parlato del controllo subito, dato che la violenza di coppia è spesso sottostimata. Ma i risultati sono incoraggianti.
Abbiamo dimostrato che è fattibile chiedere e identificare esperienze di controllo con le donne rifugiate nei servizi di accoglienza. Lo strumento ACTS si è rivelato efficace, aprendo la strada a valutazioni del rischio più approfondite e a un supporto mirato. Le conversazioni stimolate dalle domande sono state preziose, aumentando la consapevolezza sia per le utenti che per le operatrici. Identificare il controllo e riconoscere le diverse interpretazioni di cosa esso costituisca è essenziale per permettere alle donne rifugiate di cercare aiuto e prevenire ulteriore violenza. I servizi di accoglienza hanno un ruolo cruciale da svolgere, ma necessitano di risorse adeguate, formazione continua per il personale e protocolli chiari per l’invio e il supporto.
La strada è ancora lunga, ma ogni catena invisibile che riusciamo a svelare è un passo verso una vita più libera e sicura per queste donne coraggiose.
Fonte: Springer