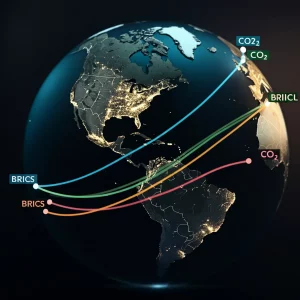Ghiacciai in Ritiro: Come lo Scioglimento Stravolge la Chimica dei Fiumi Alaskani
Avete presente quei giganti di ghiaccio maestosi, i ghiacciai? Sono meraviglie della natura, ma purtroppo, a causa dei cambiamenti climatici, si stanno ritirando a vista d’occhio, specialmente nelle regioni ad alta latitudine come l’Alaska. Questo non è solo un problema “estetico”, ma ha conseguenze profonde sugli ecosistemi che dipendono da loro. Mi sono sempre chiesto: cosa succede esattamente ai fiumi che nascono da questi ghiacciai quando il ghiaccio inizia a sciogliersi più velocemente? Come cambia la “ricetta” chimica dell’acqua che poi arriva fino al mare?
Beh, recentemente ho avuto modo di approfondire uno studio affascinante proprio su questo tema, concentrato sui bacini costieri dell’Alaska. Immaginatevi questi paesaggi mozzafiato, dove fiumi impetuosi si fanno strada tra montagne e foreste, alimentati direttamente dallo scioglimento dei ghiacciai. Capire cosa succede lì è fondamentale, perché questi fiumi non sono solo corridoi d’acqua, ma veri e propri sistemi viventi che supportano una biodiversità unica, inclusi pesci preziosi come il salmone.
L’Alaska sotto la lente: due regioni a confronto
Lo studio si è concentrato su due aree specifiche nel Golfo dell’Alaska, climaticamente diverse: il Lynn Canal (più umido) e la Kachemak Bay (più secca). Per diversi anni (da 3 a 5, per la precisione), i ricercatori hanno campionato l’acqua di 10 fiumi, scelti apposta per rappresentare un gradiente di copertura glaciale: da bacini quasi completamente privi di ghiaccio (0%) fino a quelli dove il ghiacciaio domina il paesaggio (copertura fino al 62%).
L’obiettivo? Misurare le concentrazioni di elementi chiave per la vita acquatica:
- Carbonio organico disciolto (DOC): una fonte di energia per i microrganismi.
- Azoto totale disciolto (TDN): essenziale per la crescita di alghe e piante.
- Fosforo totale disciolto (TDP): un altro nutriente cruciale, spesso limitante.
Ma non si sono limitati a misurare le quantità assolute. Hanno analizzato la stechiometria, cioè le proporzioni relative tra questi elementi (il rapporto C:N:P), e come queste quantità cambiano al variare della portata del fiume (la cosiddetta relazione concentrazione-portata, o C-Q). Perché è importante? Perché l’equilibrio tra questi nutrienti determina chi può prosperare nell’ecosistema fluviale e, di conseguenza, influenza tutta la catena alimentare.
Ghiaccio che si scioglie, chimica che cambia: cosa abbiamo scoperto?
I risultati sono stati illuminanti! È emerso chiaramente che la percentuale di copertura glaciale in un bacino idrografico ha un impatto enorme sulla chimica dell’acqua del fiume.
Una delle scoperte più interessanti riguarda il rapporto tra Carbonio e Fosforo (DOC:TDP). Man mano che la copertura glaciale diminuisce, la concentrazione di Carbonio organico disciolto (DOC) tende ad aumentare rispetto a quella del Fosforo totale disciolto (TDP). Questo conferma l’ipotesi che il ritiro dei ghiacciai modifichi l’equilibrio C:N:P nei fiumi. Perché succede? I ghiacciai, erodendo la roccia sottostante, liberano parecchio fosforo. Quando il ghiacciaio si ritira, questa fonte di P diminuisce, mentre il terreno scoperto viene colonizzato dalla vegetazione (foreste, torbiere) che diventa una nuova, importante fonte di carbonio organico per il fiume.

E la relazione concentrazione-portata (C-Q)? Anche qui, il ghiaccio gioca un ruolo da protagonista. Questa relazione ci dice se l’esportazione di un elemento è limitata dalla sua disponibilità (source-limited, la concentrazione diminuisce all’aumentare della portata) o dalla capacità del fiume di trasportarlo via (transport-limited, la concentrazione aumenta con la portata).
Abbiamo osservato che per il Carbonio organico (DOC) e l’Azoto organico (DON), nei bacini molto glacializzati l’esportazione è spesso source-limited. Man mano che il ghiacciaio si ritira e la vegetazione prende piede, si passa a una condizione transport-limited: durante gli eventi di piena, l’acqua “lava via” più carbonio e azoto organico dal terreno e dalla vegetazione. Sorprendentemente, per il Fosforo reattivo solubile (SRP, una forma biodisponibile di P), avviene il contrario: si passa da transport-limited (nei bacini molto glacializzati) a source-limited (in quelli meno glacializzati). È come se il “rubinetto” del fosforo glaciale si chiudesse pian piano.
La cosa notevole è che queste tendenze nelle relazioni C-Q per DOC, DON e SRP sono state osservate in entrambe le regioni studiate (Lynn Canal e Kachemak Bay), nonostante le loro differenze climatiche e geologiche. Questo suggerisce che l’influenza dello scioglimento glaciale su questi processi sia un fenomeno piuttosto generale, almeno per questi tipi di bacini.
Due regioni, due “ricette” nutritive diverse
Nonostante le similitudini nei meccanismi di trasporto, la stechiometria finale, cioè l’equilibrio C:N:P nell’acqua, mostrava differenze regionali interessanti. Usando dei grafici speciali chiamati “diagrammi ternari” (immaginate un triangolo dove ogni angolo rappresenta C, N o P), abbiamo visualizzato queste proporzioni.
Nel Lynn Canal (LC), molti campioni, specialmente nei fiumi con poca o nessuna influenza glaciale, mostravano una tendenza alla carenza simultanea di Azoto e Fosforo (co-deplezione N-P). Nei fiumi più influenzati dai ghiacciai, invece, era più comune una carenza di Azoto rispetto al Fosforo. In generale, all’aumentare della copertura glaciale, la tendenza alla carenza di Fosforo diminuiva.
Nella Kachemak Bay (KB), la situazione era diversa. Qui, la carenza di Azoto era rara. La maggior parte dei campioni indicava una forte carenza di Fosforo, e a volte una carenza simultanea di Carbonio e Fosforo, indipendentemente dalla copertura glaciale. Questo supporta l’idea che il Fosforo sia spesso il nutriente limitante nelle prime fasi della successione ecologica dopo il ritiro dei ghiacciai. Inoltre, la variabilità stechiometrica in KB sembrava maggiore rispetto a LC, forse a causa di differenze nella vegetazione, nella geologia locale a valle dei ghiacciai, o nel regime idrologico (LC ha portate più costantemente elevate).

Perché tutto questo ci interessa? L’impatto sulla vita acquatica
Queste variazioni nella “ricetta” chimica dei fiumi non sono solo curiosità scientifiche. Hanno implicazioni dirette per la vita acquatica. In ecosistemi fluviali “difficili” e poco produttivi come quelli glaciali, la crescita alla base della catena alimentare (alghe come il periphyton, batteri) è spesso controllata “dal basso” (bottom-up control), cioè dalla disponibilità di luce e nutrienti.
Se cambia l’equilibrio C:N:P, cambia cosa e quanto può crescere. Ad esempio, una carenza di N o P può limitare la crescita delle alghe. Il carbonio organico fornito dai ghiacciai, d’altra parte, sembra essere facilmente utilizzabile dai batteri. Quindi, lo scioglimento glaciale, alterando sia le quantità che le proporzioni di C, N e P, può rimodellare la base della rete alimentare fluviale.
Questo, a sua volta, si ripercuote sui livelli trofici superiori: insetti acquatici, e poi pesci come i preziosi salmoni del Pacifico, che sono fondamentali sia ecologicamente che economicamente per le comunità costiere dell’Alaska. Le differenze osservate tra Lynn Canal (tendenzialmente N-limitato) e Kachemak Bay (tendenzialmente P-limitato) potrebbero creare un mosaico di condizioni diverse per la produttività di questi ecosistemi fluviali.
E non finisce qui. Questi fiumi sfociano nell’oceano, in particolare negli intricati sistemi di fiordi tipici dell’Alaska costiera, della Norvegia, della Nuova Zelanda. L’enorme quantità di acqua dolce rilasciata dai ghiacciai influenza pesantemente la salinità, la struttura fisica e la biogeochimica di queste acque costiere. I nutrienti e il carbonio di origine glaciale possono essere trattenuti e utilizzati rapidamente nelle reti alimentari marine dei fiordi. Quindi, i cambiamenti indotti dallo scioglimento dei ghiacciai nei fiumi potrebbero avere effetti a cascata anche sulla produttività marina costiera.

Uno sguardo al futuro: cosa ci aspetta?
Questo studio ci dà un’immagine più chiara di come il ritiro dei ghiacciai stia già rimodellando la chimica dei fiumi alaskani. Le tendenze osservate nelle relazioni C-Q (passaggio da source a transport-limited per C e N organici, e l’opposto per P inorganico) potrebbero essere generalizzabili ad altre regioni montane del mondo che stanno subendo una deglaciazione.
Tuttavia, dobbiamo anche considerare la fase dello scioglimento. Alcune regioni, come le Alpi Europee, potrebbero aver già superato il “picco” di portata d’acqua dovuta allo scioglimento (peak water), e ora vedono una diminuzione del contributo glaciale. L’Alaska, invece, si prevede raggiunga questo picco più avanti nel secolo. Questo significa che le implicazioni a breve termine per gli ecosistemi fluviali potrebbero variare regionalmente.
La ricerca futura dovrà approfondire le conseguenze di questi cambiamenti sulle reti alimentari interconnesse, dalla base microbica fino ai grandi predatori, per capire meglio come preservare la stabilità ecologica di questi ambienti unici e preziosi in un mondo che cambia. È una sfida complessa, ma fondamentale per gestire le risorse idriche e biologiche delle regioni montane e costiere dipendenti dai ghiacciai.
Fonte: Springer