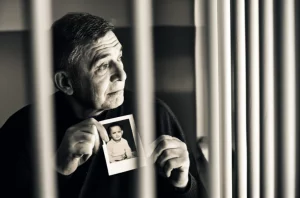Reti Ottiche Avanzate: Come Vediamo Più Segnali Deboli con un Solo Occhio (Quantistico!)
Ciao a tutti! Oggi voglio parlarvi di qualcosa che mi appassiona tantissimo e che, credetemi, sta aprendo porte incredibili nel mondo delle comunicazioni e non solo. Parliamo di fotoni, quelle particelle di luce quasi magiche, e di come possiamo usarle per trasmettere e processare informazioni.
Sapete, i fotoni sono fantastici per questo scopo: viaggiano veloci, non si fanno disturbare troppo dal rumore esterno (la cosiddetta decoerenza è trascurabile) e possiamo codificare informazioni su di loro in tanti modi diversi. Sono diventati i protagonisti in campi come l’imaging quantistico, la crittografia, il calcolo e, ovviamente, la comunicazione, specialmente su lunghe distanze come nello spazio profondo.
La Sfida: Vedere Tanti Segnali Debolissimi Insieme
Il punto cruciale è: come facciamo a “vedere” questi fotoni e a estrarre le informazioni che trasportano? Soprattutto quando i segnali sono incredibilmente deboli, a livello di singolo fotone, e magari ne arrivano tanti contemporaneamente da direzioni diverse? Pensate a una rete di comunicazione tra satelliti nello spazio, una specie di ragnatela (topologia mesh) dove ogni satellite deve poter parlare con molti altri nello stesso momento.
Qui casca l’asino, o meglio, cascava fino ad ora. I sistemi attuali, anche quelli super avanzati come i rilevatori a singolo fotone a nanofili superconduttori (SNSPD) o i diodi a valanga a singolo fotone (SPAD), fanno fatica. Hanno un numero limitato di “pixel” (le aree sensibili alla luce). Anche se recentemente si è arrivati a decine di migliaia di pixel, spesso l’efficienza di rilevamento non è altissima, o la velocità con cui leggono i dati (frame rate) è troppo bassa per gestire flussi informativi veloci. Immaginate di avere tanti segnali debolissimi che arrivano sullo stesso rilevatore: è facilissimo che si confondano, creando quella che in gergo chiamiamo diafonia (crosstalk). È come cercare di ascoltare tante conversazioni sussurrate contemporaneamente in una stanza affollata: un gran caos!
Un altro problema enorme con segnali così deboli è la sincronizzazione. Gli orologi di chi trasmette e di chi riceve non sono mai perfettamente allineati e tendono a “scivolare” (clock drift). Se non si riesce a sincronizzarli perfettamente, si rischia di leggere i dati nel momento sbagliato, introducendo errori. E sincronizzarsi quando ricevi pochissimi fotoni per ogni “bit” di informazione è una vera impresa.
La Nostra Soluzione: Lo Schema MIND (Multi-node Information Network Detection)
Ed è qui che entriamo in gioco noi, con un’idea che abbiamo chiamato MIND (Multi-node Information Network Detection). L’abbiamo proposta e testata sperimentalmente, dimostrando che funziona alla grande proprio per queste reti complesse, come quelle per le comunicazioni nello spazio profondo.
L’idea di base è trattare i fotoni non solo come portatori di informazione (i bit 0 e 1), ma anche come portatori di informazione sulla loro posizione spaziale e sul loro tempo di arrivo. Abbiamo sviluppato un sistema di rilevamento super sensibile (a livello di singolo fotone) e velocissimo, con una “retina” da 256×256 pixel. Ogni pixel è indipendente e registra con precisione nanometrica (1.56 miliardesimi di secondo!) quando un fotone lo colpisce e quale pixel è stato colpito.
Come funziona il nostro schema MIND? Possiamo dividerlo in tre fasi fondamentali:

Fase 1: Separazione dei Segnali (Addio Crosstalk!)
La prima cosa che facciamo è usare l’informazione spaziale. Guardando dove i fotoni colpiscono l’array di pixel, possiamo identificare le “zone” corrispondenti a ciascun segnale in arrivo. Immaginate tanti faretti puntati sullo stesso muro: anche se le luci si sovrappongono un po’, possiamo distinguere da dove arriva ogni fascio. In questo modo, separiamo virtualmente i flussi di fotoni provenienti da nodi diversi, eliminando quasi del tutto la diafonia. Nel nostro esperimento, abbiamo mostrato tre segnali distinti (vedi Fig. 1b nel paper originale).
Fase 2: Sincronizzazione Temporale (Mettere in Ordine il Tempo)
Una volta separati i segnali, dobbiamo affrontare il problema del clock drift per ciascuno di essi. Qui entra in gioco l’analisi della correlazione temporale. Anche se i fotoni arrivano in modo molto sparso, analizzando i loro tempi di arrivo su un certo intervallo, riusciamo a ricostruire l’andamento dell’orologio del trasmettitore rispetto al nostro.
Come facciamo? Dividiamo il flusso di fotoni in piccoli intervalli di tempo (ad esempio, 2 millisecondi). Per ogni fotone, calcoliamo il suo ritardo rispetto all’inizio dell’impulso a cui appartiene. Anche se in un singolo intervallo ci sono pochi fotoni per vedere chiaramente la forma dell’impulso originale, usiamo una tecnica chiamata “conteggio delle coincidenze”. In pratica, cerchiamo piccoli gruppi di fotoni che arrivano a distanze temporali specifiche. Questo ci permette di trovare un “ritardo di coincidenza” che cambia lentamente nel tempo, rivelando proprio il clock drift.
Analizzando come questo ritardo cambia nel tempo (usando anche trasformate di Fourier, per i più tecnici), possiamo calcolare sia la deriva lineare (la differenza costante di frequenza tra gli orologi) sia la deriva casuale (dovuta a fattori ambientali come temperatura, ecc.). Corretti questi scostamenti, possiamo “riallineare” virtualmente tutti i fotoni al tempo corretto del trasmettitore, ottenendo una forma d’onda pulita (vedi Fig. 2f nel paper). E tutto questo senza bisogno di impulsi di sincronizzazione aggiuntivi!
Fase 3: Recupero dei Bit (Leggere il Messaggio)
Ora che i segnali sono separati e sincronizzati, dobbiamo capire quali sono i bit 0 e quali gli 1. Ogni trasmettitore invia una sequenza di bit ciclicamente. Noi contiamo quanti fotoni arrivano in corrispondenza di ogni posizione di bit nel ciclo. All’inizio, i conteggi sono bassi e confusi. Ma accumulando dati nel tempo, i bit “1” (che corrispondono a un impulso di luce inviato) accumuleranno più fotoni dei bit “0” (nessun impulso inviato), dove troveremo solo fotoni di rumore casuale.
Le distribuzioni statistiche dei conteggi per gli 0 e gli 1 diventano sempre più separate (vedi Fig. 2g). Troviamo il punto ottimale per mettere una soglia: se il conteggio di fotoni per un bit è sopra la soglia, lo interpretiamo come 1, altrimenti come 0 (vedi Fig. 2h, 2i). Calcoliamo anche il tasso di errore sui bit (BER) teorico ed sperimentale. Quando il BER scende sotto una certa soglia (ad esempio, quella usata dai sistemi di correzione d’errore FEC), possiamo ricostruire il messaggio originale senza errori!

Risultati Sorprendenti: Robustezza e Scalabilità
Nel nostro esperimento, abbiamo stabilito con successo tre link di comunicazione simultanei e senza crosstalk. E la cosa incredibile è che ci siamo riusciti con segnali debolissimi: parliamo di circa (8.4 times 10^{-5}) fotoni rilevati per impulso (cioè, rileva un fotone utile solo una volta ogni quasi 12.000 impulsi inviati!). Non solo, ma il sistema funziona anche quando il rumore è 1.7 volte più forte del segnale (SNR di -2.3 dB)!
Abbiamo testato MIND in condizioni ancora più difficili:
- Perdite di canale elevate: Simulando perdite fino a -114 dB (paragonabili alla distanza Terra-Marte!). Anche in questi casi, accumulando dati per un tempo sufficiente, riusciamo a portare il BER sotto la soglia FEC.
- Segnali in movimento: Abbiamo dimostrato che MIND funziona perfettamente anche se i trasmettitori si muovono (in modo casuale o a velocità costante), senza aumentare il tempo necessario per la comunicazione. Questo è fondamentale per applicazioni reali come i satelliti.
- Segnali sovrapposti: Addirittura, siamo riusciti a separare e decodificare tre segnali che si sovrapponevano spazialmente sulla nostra “retina”! Come? Sfruttando le leggerissime differenze nelle caratteristiche dei loro orologi (clock drift), che ci hanno permesso di distinguerli analizzando le correlazioni temporali.
- Interruzioni di canale: Abbiamo verificato che lo schema è robusto anche a disconnessioni frequenti e lunghe del canale.
Questi risultati dimostrano la potenza e la flessibilità del nostro approccio. La combinazione della risoluzione spaziale (grazie ai tanti pixel) e dell’analisi temporale finissima ci permette di fare cose impensabili prima.

Verso Reti Quantistiche su Larga Scala
E il futuro? Il bello di MIND è la sua scalabilità. Con il nostro attuale sistema da 256×256 pixel, stimiamo di poter gestire teoricamente fino a 650 link di comunicazione simultanei e senza crosstalk! Questo numero dipende da quanti pixel occupa ogni segnale e dalla capacità massima di elaborazione dati del rilevatore.
Certo, MIND non elimina la necessità di accumulare fotoni per un certo tempo quando i segnali sono debolissimi o le distanze enormi, ma fornisce un modo per realizzare comunicazioni che sarebbero impossibili con altri sistemi in queste condizioni estreme, proprio grazie alla sincronizzazione precisa che riusciamo a ottenere.
Le applicazioni vanno ben oltre le comunicazioni ottiche multi-utente. Pensiamo all’aumento del numero di qubit che potremmo controllare e misurare in un sistema quantistico, o a progressi nell’imaging 3D e nel tracciamento di segnali.
Insomma, il nostro lavoro con MIND fornisce un approccio scalabile, generale e pratico per rilevare ed estrarre informazioni da segnali multipli e concorrenti a livello di singolo fotone. Stiamo aprendo la strada verso reti quantistiche e di comunicazione su larga scala, con tutte le fantastiche applicazioni che ne deriveranno. È un momento davvero entusiasmante per chi lavora in questo campo!
Fonte: Springer