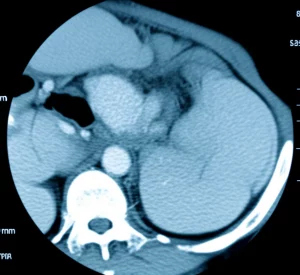Cancro e Fertilità: Il Sangue Può Svelare Segreti sulla Riserva Ovarica?
Ciao a tutti! Oggi voglio parlarvi di un argomento che mi sta molto a cuore e che tocca la vita di tante giovani donne: la preservazione della fertilità dopo una diagnosi di cancro. Sapete, quando si affronta una battaglia così grande, il futuro può sembrare incerto, e la possibilità di avere figli un domani diventa una preoccupazione fondamentale. Fortunatamente, la medicina ha fatto passi da gigante, e una delle opzioni più promettenti è la crioconservazione del tessuto ovarico (OTC).
Perché la Crioconservazione Ovarica è Importante?
Immaginate: una giovane donna, magari nel fiore degli anni, riceve una diagnosi di cancro. Le terapie necessarie per sconfiggerlo, come la chemioterapia o la radioterapia pelvica, possono essere molto efficaci contro la malattia, ma purtroppo anche dannose per le ovaie. Il rischio è quello di andare incontro a un’insufficienza ovarica prematura (POI), che non solo compromette la fertilità, ma può avere ripercussioni sulla salute delle ossa, sul sistema cardiovascolare e, in generale, sulla qualità della vita.
Ecco perché l’OTC è così preziosa. È una tecnica che permette di prelevare una parte del tessuto ovarico *prima* di iniziare le terapie oncologiche, congelarlo e conservarlo. Una volta superata la malattia, questo tessuto può essere reimpiantato, ridando potenzialmente alla donna la possibilità di concepire naturalmente o tramite fecondazione assistita, e ripristinando anche la funzione endocrina delle ovaie. È l’unica opzione per le bambine e le adolescenti che non hanno ancora raggiunto la pubertà e un’alternativa valida per chi non può rimandare l’inizio delle cure.
La Sfida: Prevedere il Successo dell’OTC
Il successo dell’OTC dipende da molti fattori, ma uno cruciale è la densità follicolare (FD) del tessuto prelevato. In parole semplici, quanti follicoli primordiali (le “uova” immature) ci sono in quel pezzetto di ovaio? Più ce ne sono, maggiori sono le probabilità che il reimpianto funzioni.
Attualmente, per valutare la riserva ovarica prima dell’OTC, usiamo principalmente l’età della paziente, il dosaggio dell’ormone anti-Mülleriano (AMH) nel sangue e la conta dei follicoli antrali (AFC) tramite ecografia. L’AMH è comodo perché si può misurare in qualsiasi giorno del ciclo, ma i suoi livelli possono essere influenzati da tanti fattori (uso recente di contraccettivi, fumo, obesità, bassi livelli di vitamina D) e non esiste ancora uno standard internazionale unico, il che rende l’interpretazione a volte complicata.
Ci siamo quindi chiesti: esistono altri parametri, magari facilmente accessibili, che potrebbero aiutarci a prevedere la densità follicolare e quindi le chance di successo dell’OTC?

L’Infiammazione: Un Legame Inaspettato?
Qui entra in gioco un attore che forse non vi aspettereste: l’infiammazione. Sappiamo bene che l’infiammazione è una caratteristica chiave del cancro; spesso correla con la presenza e lo stadio della malattia. Ma ricerche recenti suggeriscono che l’infiammazione potrebbe giocare un ruolo anche in diverse disfunzioni ovariche, come la POI, la sindrome dell’ovaio policistico (PCOS) e persino l’invecchiamento ovarico, contribuendo forse a un declino precoce della riserva ovarica.
Allora, la domanda sorge spontanea: visto che le pazienti oncologiche fanno di routine un emocromo completo (CBC) prima dell’OTC, potremmo usare i parametri infiammatori che derivano da questo semplice esame del sangue per avere qualche indizio sulla loro densità follicolare? Sarebbe fantastico avere marcatori facilmente reperibili per personalizzare ancora di più il percorso di preservazione della fertilità!
Cosa Abbiamo Cercato (e Trovato) nel Nostro Studio
Per rispondere a questa domanda, abbiamo condotto uno studio retrospettivo osservazionale qui all’IRCCS Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma. Abbiamo analizzato i dati di 101 pazienti oncologiche che si sono sottoposte a OTC tra il 2017 e il 2023. Avevamo a disposizione i loro emocromi pre-procedura e la conta della densità follicolare effettuata sul tessuto fresco.
Ci siamo concentrati su specifici parametri legati all’infiammazione, calcolabili dall’emocromo:
- Conta dei globuli bianchi (WBC)
- Conta assoluta dei neutrofili
- Conta assoluta dei linfociti
- Rapporto Neutrofili/Linfociti (NLR)
- Volume Piastrinico Medio (MPV)
- Conta Piastrinica (PC)
- Rapporto MPV/PC
- Rapporto Piastrine/Linfociti (PLR)
Abbiamo cercato correlazioni tra questi valori e la densità follicolare, tenendo conto anche di altri fattori come l’età, il tipo di cancro, l’indice di massa corporea (BMI), l’abitudine al fumo e, per le pazienti con cancro al seno, la presenza di mutazioni germinali nei geni BRCA.
I risultati sono stati davvero interessanti! Non abbiamo trovato correlazioni significative in tutta la popolazione o nelle pazienti più giovani (fino a 27 anni) o in quelle sopra i 31 anni. Ma nel gruppo di età intermedio, quello tra i 28 e i 31 anni, sono emerse delle associazioni statisticamente significative:
- Un NLR più alto era associato a una minore densità follicolare (correlazione inversa). L’NLR è un noto indicatore di infiammazione sistemica; un valore elevato suggerisce uno stato infiammatorio attivo.
- Un PLR più alto era anch’esso associato a una minore densità follicolare (correlazione inversa). Anche il PLR è legato a condizioni infiammatorie e croniche.
- Una conta dei linfociti più alta era associata a una maggiore densità follicolare (correlazione diretta).
- Un rapporto MPV/PC più alto era associato a una maggiore densità follicolare (correlazione diretta).

Altre Osservazioni e Considerazioni
Come ci aspettavamo, la densità follicolare diminuiva significativamente con l’aumentare dell’età. Curiosamente, però, in questo specifico gruppo di pazienti, non abbiamo trovato una diminuzione significativa dei livelli di AMH con l’età, a conferma di come questo marcatore possa essere variabile.
Abbiamo anche notato che le pazienti con diagnosi di sarcoma avevano una densità follicolare mediamente più alta rispetto a quelle con cancro al seno o altri tipi di tumore, ma questo risultato è probabilmente legato al fatto che le pazienti con sarcoma nel nostro campione erano tendenzialmente più giovani.
Per quanto riguarda BMI, fumo e mutazioni BRCA, nel nostro studio non abbiamo trovato differenze significative nella densità follicolare tra i vari gruppi. È importante sottolineare, però, che i dati sul fumo erano incompleti per alcune pazienti e il numero di portatrici di mutazioni BRCA era relativamente piccolo, quindi questi risultati vanno presi con cautela e necessitano di ulteriori approfondimenti. La relazione tra questi fattori e la riserva ovarica è ancora dibattuta nella letteratura scientifica, con risultati a volte contrastanti.
Cosa Significa Tutto Questo? Limiti e Prospettive Future
Allora, possiamo dire che basta un emocromo per predire il successo dell’OTC? Non ancora. Il nostro studio è il primo, a nostra conoscenza, a esplorare questo legame specifico tra marcatori infiammatori del sangue e densità follicolare tissutale in pazienti oncologiche candidate all’OTC. I risultati suggeriscono che parametri come NLR, conta linfocitaria, MPV/PC e PLR *potrebbero* essere utili, ma solo in un sottogruppo specifico di pazienti (quelle tra 28 e 31 anni nel nostro campione).
Ci sono dei limiti, ovviamente. È uno studio retrospettivo, la popolazione era eterogenea per età e tipo di cancro (anche se abbiamo cercato di tenerne conto), e non abbiamo ancora i dati più importanti: i tassi di gravidanza e nascita dopo il reimpianto, dato che nessuna delle nostre pazienti lo ha ancora effettuato.
Tuttavia, questi risultati aprono una strada affascinante. L’idea che un semplice, economico e routinario esame del sangue possa fornire informazioni aggiuntive sulla riserva ovarica di una paziente oncologica è estremamente promettente. Potrebbe aiutarci a personalizzare ulteriormente il counseling oncofertologico e a valutare meglio le potenzialità dell’OTC per ogni singola donna.
Serviranno studi più ampi e prospettici per confermare questi risultati e per capire meglio i meccanismi biologici sottostanti. Magari in futuro potremmo anche analizzare tipi specifici di linfociti circolanti o altri marcatori infiammatori. La ricerca non si ferma, e la speranza è quella di offrire strumenti sempre più precisi per proteggere il futuro riproduttivo delle giovani donne che affrontano il cancro.
Fonte: Springer