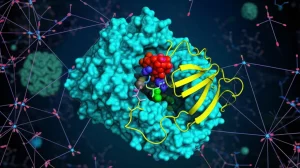L’Orologio Segreto del Midollo Osseo: Come Ritmo Circadiano e Tossine Ambientali Danzano con la Leucemia
Ciao a tutti! Oggi voglio portarvi con me in un viaggio affascinante all’interno del nostro corpo, precisamente nel midollo osseo. Non è solo la fabbrica delle nostre cellule del sangue, ma un vero e proprio micro-universo pieno di segreti. E uno di questi segreti, che stiamo iniziando a svelare, riguarda un dialogo nascosto che potrebbe avere un ruolo cruciale nello sviluppo della leucemia. Parlo dell’interazione tra il nostro ritmo circadiano – sì, il nostro orologio biologico interno – e un recettore chiamato Aryl Hydrocarbon Receptor (AhR), il tutto ambientato in un tipo particolare di tessuto adiposo che si trova proprio lì, nel midollo: il tessuto adiposo del midollo osseo (BMAT).
Un Microambiente Complesso: Il Midollo Osseo e il Suo Grasso
Immaginate il midollo osseo non come una semplice spugna, ma come un ecosistema brulicante di vita. Qui, le cellule staminali ematopoietiche (le mamme di tutte le cellule del sangue) convivono e interagiscono con una miriade di altri tipi cellulari, tra cui le cellule staminali/stromali mesenchimali (MSC). Queste MSC sono incredibilmente versatili: possono trasformarsi in cellule ossee, cartilaginee e, appunto, in adipociti, le cellule del grasso. E qui entra in gioco il BMAT.
Ora, non pensate al BMAT come al grasso che cerchiamo di smaltire con la dieta. È diverso, ha caratteristiche uniche e un metabolismo più basato sul colesterolo che sulla lipolisi (la scissione dei grassi). Per anni è stato un po’ trascurato, ma recenti scoperte, inclusa la nostra, lo stanno mettendo sotto i riflettori, specialmente nel contesto della leucemia. Sembra infatti che le cellule leucemiche siano delle vere manipolatrici: riescono a “corrompere” il microambiente del midollo osseo, incluso il BMAT, per favorire la propria sopravvivenza e crescita. Pensate che la lipolisi nel BMAT, ovvero la rottura dei grassi per produrre energia, è emersa come un fattore critico che sostiene le cellule leucemiche. Un po’ come se queste cellule maligne si nutrissero delle riserve energetiche del loro “vicino di casa” adiposo.
L’Anemia di Fanconi: Una Finestra sulla Leucemia
Per capire meglio questi meccanismi, ci siamo concentrati su un modello particolare: l’Anemia di Fanconi (FA). Si tratta di una malattia genetica rara che, tra le altre cose, predispone fortemente allo sviluppo della leucemia mieloide acuta (LMA). I pazienti con FA sono anche ipersensibili alle tossine ambientali. Questo la rende un modello “di transizione” ideale per studiare come un midollo osseo, inizialmente non leucemico ma vulnerabile, possa trasformarsi.
Abbiamo quindi prelevato cellule MSC dal BMAT di donatori sani (HD), pazienti con LMA e pazienti con FA (che al momento del prelievo non mostravano segni di leucemia). Su queste cellule abbiamo scatenato la potenza delle analisi “multi-omiche”: transcriptomica (per studiare i geni attivi), metabolomica (per i metaboliti) e lipidomica (per i lipidi). Un vero e proprio screening a 360 gradi per capire cosa cambia a livello molecolare.
Il Recettore AhR e le Tossine: Un Attore Inaspettato?
Un protagonista chiave della nostra indagine è stato l’Aryl Hydrocarbon Receptor (AhR). Questo recettore è famoso per essere il principale sensore delle diossine e di altri composti xenobiotici (sostanze estranee all’organismo, spesso tossiche, derivanti da processi industriali). Quando AhR si attiva, scatena una serie di risposte cellulari. La cosa interessante è che AhR e le vie del ritmo circadiano sono strettamente interconnesse e si regolano a vicenda. È come se ci fosse un dialogo continuo tra la nostra capacità di rispondere alle tossine ambientali e il nostro orologio biologico interno.
Il ritmo circadiano, quel meccanismo evolutivamente conservato che regola sonno-veglia, rilascio di ormoni, metabolismo e tanto altro, funziona grazie a un complesso balletto di geni “orologio” come BMAL1, CLOCK, PER e CRY. Sorprendentemente, AhR e il suo partner ARNT mostrano somiglianze strutturali con CLOCK e BMAL1. Questo suggerisce una profonda integrazione tra i due sistemi.

Abbiamo voluto vedere cosa succedeva inibendo la segnalazione di AhR. Per farlo, abbiamo usato una molecola chiamata StemRegenin1 (SR1), un noto antagonista di AhR. L’idea era: se blocchiamo AhR, come reagisce il sistema, specialmente in relazione al ritmo circadiano e al metabolismo lipidico nelle MSC del BMAT di pazienti sani, con FA e con LMA?
Risultati Sorprendenti: EMT, Ritmi Sballati e Metabolismo Impazzito
I risultati sono stati illuminanti! Innanzitutto, abbiamo osservato che nelle MSC del BMAT dei pazienti con FA e LMA c’era un aumento dell’espressione di geni legati alla transizione epitelio-mesenchimale (EMT). L’EMT è un processo per cui le cellule “normali” acquisiscono caratteristiche più mobili e invasive, simili a quelle delle cellule tumorali aggressive. Questo suggerisce che, nel microambiente alterato del midollo, queste cellule stromali potrebbero trasformarsi in qualcosa di simile ai “fibroblasti associati al cancro”, figure note per sostenere la crescita tumorale. E l’esposizione a SR1 sembrava accentuare questo fenotipo, specialmente nelle cellule LMA.
Poi, il ritmo circadiano. Abbiamo identificato potenziali biomarcatori del ritmo circadiano (geni come NPAS2, PER2, BHLHE40, PER3, CIART) nelle MSC del BMAT. È emerso un legame tra questi geni e quelli del metabolismo lipidico (ad esempio, PTGS1, PIK3R1) in risposta al trattamento con SR1, implicandoli nei processi di lipolisi. Nelle MSC del BMAT dei pazienti con LMA, abbiamo notato una disregolazione dei geni legati al ritmo circadiano (CIART, BHLHE40, NPAS2), insieme a cambiamenti nei metaboliti lipidici circolanti, come il palmitato. Questo ci dice che l’orologio biologico di queste cellule è “sballato” e che questo potrebbe contribuire a modellare un microambiente favorevole alla leucemia.
Un’altra scoperta intrigante riguarda due proteine: FABP5 e CD36. L’aumento dell’espressione di FABP5 (un gene ritmico) e di CD36 suggerisce un nuovo meccanismo molecolare. FABP5 potrebbe essere coinvolto nella regolazione circadiana mediata da AhR, e CD36 potrebbe essere un suo partner chiave nelle MSC del BMAT. Entrambi sono noti per essere coinvolti nel trasporto degli acidi grassi e sono stati associati a una prognosi infausta e a resistenza alla chemioterapia in alcuni tumori, spesso legati a processi di EMT.
Cosa Significa Tutto Questo? Implicazioni e Prospettive Future
Mettendo insieme tutti i pezzi, il nostro studio svela una complessa interazione tra la segnalazione di AhR, il ritmo circadiano e il microambiente leucemico nelle MSC del BMAT. Sembra che l’inibizione di AhR con SR1, anziché avere un effetto protettivo sullo stroma, possa innescare o esacerbare alcuni meccanismi pro-leucemogenici, come l’EMT e l’alterazione del metabolismo lipidico, attraverso una modulazione del ritmo circadiano.
È particolarmente interessante notare che l’Anemia di Fanconi si conferma un modello prezioso. Le alterazioni che abbiamo visto nelle cellule FA, che sono in uno stato pre-leucemico, suggeriscono che il microambiente del midollo osseo, e in particolare il BMAT, potrebbe non essere solo una vittima passiva della leucemia, ma giocare un ruolo attivo, quasi da “complice”, nello sviluppo della malattia. Dato che i pazienti FA sono molto sensibili alle tossine ambientali a causa dei loro difetti nella riparazione del DNA, è plausibile che il BMAT possa agire come un “serbatoio” per queste sostanze. L’esposizione cronica, unita alla disregolazione di AhR e del ritmo circadiano, potrebbe nel tempo creare un ambiente midollare “tossico” che favorisce la trasformazione maligna.

Per esempio, abbiamo visto che dopo il trattamento con SR1, nelle cellule LMA, si verificava una significativa sottoregolazione dei geni repressori circadiani CIART e BHLHE40, e una sovraregolazione del gene NPAS2 (associato alla crescita delle cellule LMA). Allo stesso tempo, l’acido palmitico, un lipide, era sottoregolato. Ricerche precedenti hanno mostrato che il palmitato può influenzare l’espressione dei geni orologio. Quindi, è possibile che i lipidi circolanti agiscano come segnali che influenzano il comportamento dell’orologio all’interno del BMAT.
Un altro aspetto cruciale è l’EMT. Il fatto che le MSC del BMAT, specialmente nei pazienti LMA e dopo esposizione a SR1, mostrino un arricchimento in geni EMT, suggerisce una loro “educazione” da parte delle cellule leucemiche, trasformandole in una sorta di fibroblasti attivati che sostengono il cancro. Questo potrebbe accadere persino prima dello sviluppo della leucemia conclamata nei pazienti FA.
Abbiamo anche osservato che l’esposizione a SR1 alterava il ritmo circadiano nelle MSC del BMAT, portando a una disregolazione dell’omeostasi attraverso la modulazione dei geni orologio mediata da AhR. Ad esempio, l’espressione di PER2 e PER3 diminuiva significativamente nei gruppi LMA trattati con SR1. La perdita di PER3 è stata associata a disfunzioni circadiane e, nella LMA, a una disregolazione del ciclo cellulare che potrebbe promuovere la proliferazione delle cellule blastiche.
Infine, l’analisi integrata dei dati ha evidenziato percorsi sovrapposti legati alla senescenza cellulare e alla resistenza all’insulina dopo il trattamento con SR1. Ad esempio, il gene PTEN, un soppressore tumorale, mostrava pattern di espressione opposti nei confronti FA vs. HD rispetto a LMA vs. HD dopo trattamento con SR1, coerentemente con il suo ruolo nell’Anemia di Fanconi e nella senescenza cellulare. L’acido eritronico, un metabolita, è emerso come significativamente alterato, suggerendo una disfunzione del metabolismo mitocondriale, spesso legata alla senescenza.
Certo, il nostro è uno studio in vitro, e la sincronizzazione cellulare con desametasone che abbiamo usato per mimare i segnali temporali naturali è un’approssimazione. Tuttavia, questi risultati aprono nuove strade. Comprendere a fondo questo “triangolo” – AhR, ritmo circadiano, BMAT – potrebbe portare all’identificazione di nuovi biomarcatori o bersagli terapeutici per contrastare la leucemia, magari agendo proprio sul microambiente che la nutre. È una sfida complessa, ma ogni nuova scoperta ci avvicina un po’ di più a capire, e un giorno forse a sconfiggere, questa terribile malattia.
Fonte: Springer