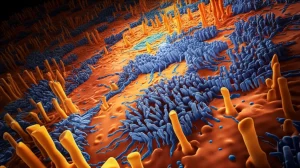Degenerazione Maculare: Il Regime “Osserva e Pianifica” Funziona Davvero a Lungo Termine? Parliamone!
Amici lettori, oggi voglio parlarvi di un argomento che tocca da vicino molti di noi, direttamente o indirettamente: la degenerazione maculare neovascolare legata all’età (nAMD). Suona complicato, vero? In parole povere, è una delle principali cause di perdita grave della vista dopo i 50 anni. Un vero spauracchio, perché quando la vista se ne va, la qualità della vita ne risente parecchio. Ma non temete, la scienza non sta a guardare!
Da anni, ormai, abbiamo un’arma potente contro questa patologia: le iniezioni intravitreali di farmaci anti-VEGF (anti-fattore di crescita vascolare endoteliale). Lo so, “iniezioni nell’occhio” non suona benissimo, ma credetemi, hanno rivoluzionato la prognosi della nAMD, trasformando una condizione che portava quasi inesorabilmente alla cecità in una malattia gestibile. Farmaci come il ranibizumab e l’aflibercept sono diventati i nostri migliori alleati.
Il punto, però, è: come usarli al meglio? Con che frequenza? E come impattare il meno possibile sulla vita dei pazienti, che già devono convivere con la malattia? Ecco, è qui che entra in gioco il cosiddetto regime “observe-and-plan” (OAP), o “osserva e pianifica” se vogliamo italianizzarlo. Recentemente, uno studio retrospettivo ha analizzato i risultati a lungo termine, ben 7 anni, di questo approccio nella vita reale. E io sono qui per raccontarvi com’è andata, con un linguaggio semplice e diretto, come se stessimo chiacchierando davanti a un caffè.
Cos’è esattamente questo regime “Osserva e Pianifica”?
Immaginate di dover annaffiare una pianta delicata. Non la innaffiate tutti i giorni alla stessa ora, vero? Osservate il terreno, capite quando ha bisogno d’acqua e agite di conseguenza. L’OAP funziona un po’ così, ma in modo più strutturato. L’idea è di personalizzare la frequenza del trattamento con anti-VEGF, cercando al contempo di ridurre il peso delle visite di controllo. Dopo una fase iniziale di “carico” (solitamente tre iniezioni), si osserva attentamente il paziente per determinare l’intervallo ottimale tra una ricaduta e l’altra. Una volta capito questo intervallo, lo si accorcia un pochino per sicurezza (di solito di 2 settimane) e si pianificano una serie di iniezioni future (fino a tre, per un periodo che può arrivare a 6 mesi) senza visite di controllo intermedie. Geniale, no? Meno corse in ospedale, meno stress, ma trattamento continuo e personalizzato. Ovviamente, questo piano viene periodicamente rivalutato e aggiustato in base alla risposta dell’occhio.
I risultati dello studio: cosa ci dicono 7 anni di OAP?
Lo studio che ho analizzato ha coinvolto 195 occhi di 181 pazienti, con un’età media di circa 79 anni e mezzo – insomma, parliamo della fascia d’età tipicamente colpita. Questi pazienti sono stati seguiti in media per 66 mesi (quasi 5 anni e mezzo, ma con dati fino a 7 anni) presso l’Ospedale Oftalmico Universitario Jules Gonin di Losanna, in Svizzera. Un centro d’eccellenza, quindi.
Ebbene, i risultati sono davvero incoraggianti! Partiamo dall’acuità visiva (VA), misurata con le famose lettere ETDRS (un po’ come le vecchie tavole ottotipiche, ma più precise). Al basale, la VA media era di 63 lettere (equivalente a circa 20/63 Snellen, per capirci). Dopo un anno di trattamento con OAP, la vista era migliorata significativamente, arrivando a 73 lettere! E la cosa straordinaria è che questo guadagno si è mantenuto piuttosto bene nel tempo: a 7 anni, la VA media era ancora di 70 lettere (equivalente a un ottimo 20/40 Snellen). C’è stato un leggerissimo calo dopo il secondo anno, ma parliamo di risultati eccellenti a lungo termine.
Pensate che la percentuale di occhi con una vista considerata “buona” (70 lettere o più, cioè 20/40 o meglio) è passata dal 41% all’inizio, al 66% dopo un anno, e si è mantenuta al 65% a 7 anni. Anche lo spessore della macula centrale (un altro indicatore importante) è diminuito significativamente e si è stabilizzato.

Ma la vera magia dell’OAP, secondo me, sta nel come si ottengono questi risultati. Il numero medio di iniezioni è diminuito nel tempo: da 8,7 il primo anno (fase più intensiva) a 6,7 il secondo, fino a circa 5,5 iniezioni all’anno al settimo anno. E le visite? Qui sta il bello: il numero medio di visite di controllo è rimasto costante e relativamente basso, circa 4 visite all’anno per tutto il periodo dello studio. Questo significa che, in media, i pazienti facevano più iniezioni che visite, riducendo notevolmente il “fardello” clinico sia per loro che per il sistema sanitario. Un bel vantaggio rispetto ad altri regimi, come il “treat-and-extend”, dove quasi ogni iniezione è preceduta da una visita.
Meno visite, stessi risultati? Sembra di sì!
Qualcuno potrebbe obiettare: “Ma con meno controlli, non c’è il rischio di non accorgersi di una ricaduta e perdere vista?”. È una preoccupazione legittima. Tuttavia, i risultati a lungo termine di questo studio sono rassicuranti. Non sembra che questo regime porti a un sottotrattamento o a risultati peggiori. Anzi, un miglioramento di 7 lettere ETDRS mantenuto a 7 anni è considerato un grande successo, soprattutto se confrontato con strategie più vecchie (come il Pro-Re-Nata, o PRN, dove si tratta solo alla ricaduta) che spesso vedevano la vista peggiorare sotto i livelli iniziali dopo 3-5 anni.
Certo, non è tutto rose e fiori. In una piccola percentuale di casi (circa l’8,7% nello studio), la vista è comunque scesa sotto livelli molto bassi, principalmente a causa di fibrosi e atrofia, che purtroppo sono evoluzioni naturali della malattia in alcuni pazienti. E ci sono stati alcuni eventi avversi, come endoftalmiti (infezioni), ma in numero limitato.
È interessante notare anche l’analisi dei “dropout”, cioè dei pazienti che hanno interrotto il follow-up. Circa il 45% non ha completato i 7 anni, ma le ragioni sono varie: alcuni si sono trasferiti presso centri più vicini a casa, altri purtroppo sono deceduti (data l’età media), altri ancora hanno smesso perché la malattia era stabile e non necessitava più di trattamento attivo in un centro di terzo livello, o, più raramente, per scarsi risultati visivi. L’analisi suggerisce che questi abbandoni non abbiano “gonfiato” i risultati positivi.
Cosa ci portiamo a casa da questo studio?
Beh, direi parecchie cose positive! Il regime “observe-and-plan” sembra essere una strategia molto efficiente per trattare la nAMD nel mondo reale. Permette di ottenere ottimi risultati visivi a lungo termine, simili o addirittura superiori ad altri approcci, ma con un grande vantaggio: riduce il numero di visite di controllo. Questo si traduce in meno stress per i pazienti, meno costi per il sistema sanitario e una migliore organizzazione per le cliniche oculistiche, che sono spesso sovraccariche.

Il fatto che il numero di iniezioni rimanga relativamente alto (circa 5-6 all’anno anche dopo molti anni) potrebbe dipendere dalla strategia “zero fluidi” (cioè si tratta finché c’è anche una minima traccia di liquido nella retina) e dall’uso di OCT molto sensibili. Inoltre, i pazienti che rimanevano in cura presso il centro universitario erano spesso quelli con malattia più attiva e quindi bisognosi di trattamento continuo.
Certo, lo studio ha i suoi limiti: è retrospettivo (cioè guarda dati raccolti in passato), il che è inevitabile per studi “real-life” ma può portare a irregolarità nel follow-up. Inoltre, non ha distinto tra i due farmaci anti-VEGF usati (ranibizumab e aflibercept) perché spesso i pazienti passavano da uno all’altro. Infine, il numero di occhi non è enorme, essendo uno studio monocentrico.
Uno sguardo al futuro
Cosa ci aspetta? L’arrivo di farmaci anti-VEGF a più lunga durata d’azione potrebbe ridurre ulteriormente il numero di iniezioni necessarie. Immaginate: stessi risultati, ma con ancora meno interventi! Ovviamente, anche questo dovrà essere dimostrato da studi “real-life” a lungo termine.
In conclusione, amici, il regime “osserva e pianifica” si conferma una strategia vincente per gestire la degenerazione maculare neovascolare. È un esempio di come la ricerca clinica possa portare a soluzioni intelligenti che bilanciano l’efficacia del trattamento con la qualità della vita dei pazienti e la sostenibilità del sistema. E questa, per me, è una notizia che merita di essere condivisa!
Fonte: Springer