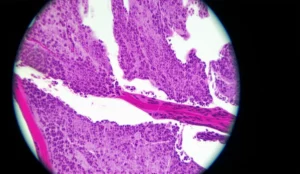Parkinson: Il Tuo Sangue Potrebbe Prevedere la Malattia Anni Prima dei Sintomi Motori?
Amici, parliamoci chiaro: il Parkinson è una di quelle malattie che fa paura, un po’ perché colpisce il cervello, un po’ perché quando te ne accorgi, spesso è già tardi per intervenire in modo davvero incisivo. Immaginatevi un ladro silenzioso che per anni si muove indisturbato prima di fare il colpo grosso. Ecco, il Parkinson spesso agisce così, danneggiando i neuroni dopaminergici, quelli che producono la dopamina, un messaggero chimico fondamentale per il controllo dei movimenti, molto prima che compaiano i tremori, la rigidità e la lentezza che tutti associamo a questa condizione.
Questa lunga fase “silenziosa” è un bel rompicapo per noi scienziati e per i medici. Come facciamo a scovare il nemico quando ancora si nasconde? Trovare dei biomarcatori, cioè degli indicatori biologici affidabili, per una diagnosi precoce e per capire come evolve la malattia in ogni singolo paziente è una delle sfide più grandi. Ed è qui che entra in gioco una ricerca che mi ha letteralmente elettrizzato, pubblicata su Communications Biology, che suggerisce un approccio innovativo e, secondo me, geniale.
Il Parkinson: un nemico silenzioso e la sfida della diagnosi precoce
Prima di addentrarci nella scoperta, facciamo un passo indietro. La fase motoria del Parkinson, quella con i sintomi classici, può essere preceduta per anni, a volte decenni, da una fase chiamata prodromica. In questa fase i sintomi sono più subdoli, non motori: disturbi del sonno REM (come il disturbo comportamentale del sonno REM o RBD, in cui si “vivono” fisicamente i sogni), perdita dell’olfatto (iposmia), stitichezza. Pensate che circa l’80% delle persone con RBD svilupperà una malattia neurodegenerativa entro una decina d’anni, e per molti di questi sarà proprio il Parkinson. Capire cosa succede in questa fase è cruciale.
Da tempo sospettiamo che il sistema immunitario giochi un ruolo importante nella storia del Parkinson. Abbiamo visto, ad esempio, un aumento di alcune molecole infiammatorie, le citochine, nel sangue dei pazienti. Però, misurare semplicemente i livelli di queste citochine “a riposo” nel sangue è un po’ come guardare il meteo di ieri: può darci un’idea, ma è influenzato da mille fattori (dieta, stress, ora del giorno) e i risultati sono spesso contraddittori, soprattutto nella fase prodromica.
L’idea geniale: “svegliare” le cellule immunitarie per capirci di più
Ed ecco la svolta che mi ha appassionato. Invece di limitarsi a misurare i livelli basali di infiammazione, i ricercatori hanno pensato: “E se provassimo a stimolare le cellule immunitarie periferiche (quelle che circolano nel sangue) e vedessimo come reagiscono?”. È un po’ come fare un test da sforzo al cuore invece di un semplice elettrocardiogramma a riposo. L’idea è che questa “provocazione” possa svelare delle differenze nel modo in cui le cellule immunitarie dei pazienti con Parkinson, anche in fase prodromica, rispondono rispetto a quelle di persone sane. Si cercano dei “tratti” immunitari, delle risposte caratteristiche, piuttosto che degli “stati” momentanei.
Hanno quindi preso campioni di sangue da quattro gruppi di persone:
- Individui neurologicamente sani (controlli).
- Pazienti con Parkinson prodromico (con RBD e altri sintomi come iposmia e stitichezza).
- Pazienti con Parkinson in fase iniziale (diagnosticati da meno di 2 anni).
- Pazienti con Parkinson in fase moderata (diagnosticati da 2 a 10 anni).
Da questi campioni hanno isolato due tipi principali di guerrieri del nostro sistema immunitario: i monociti (parte della risposta immunitaria innata, la prima linea di difesa) e i linfociti T (parte della risposta immunitaria adattativa, più specializzata).
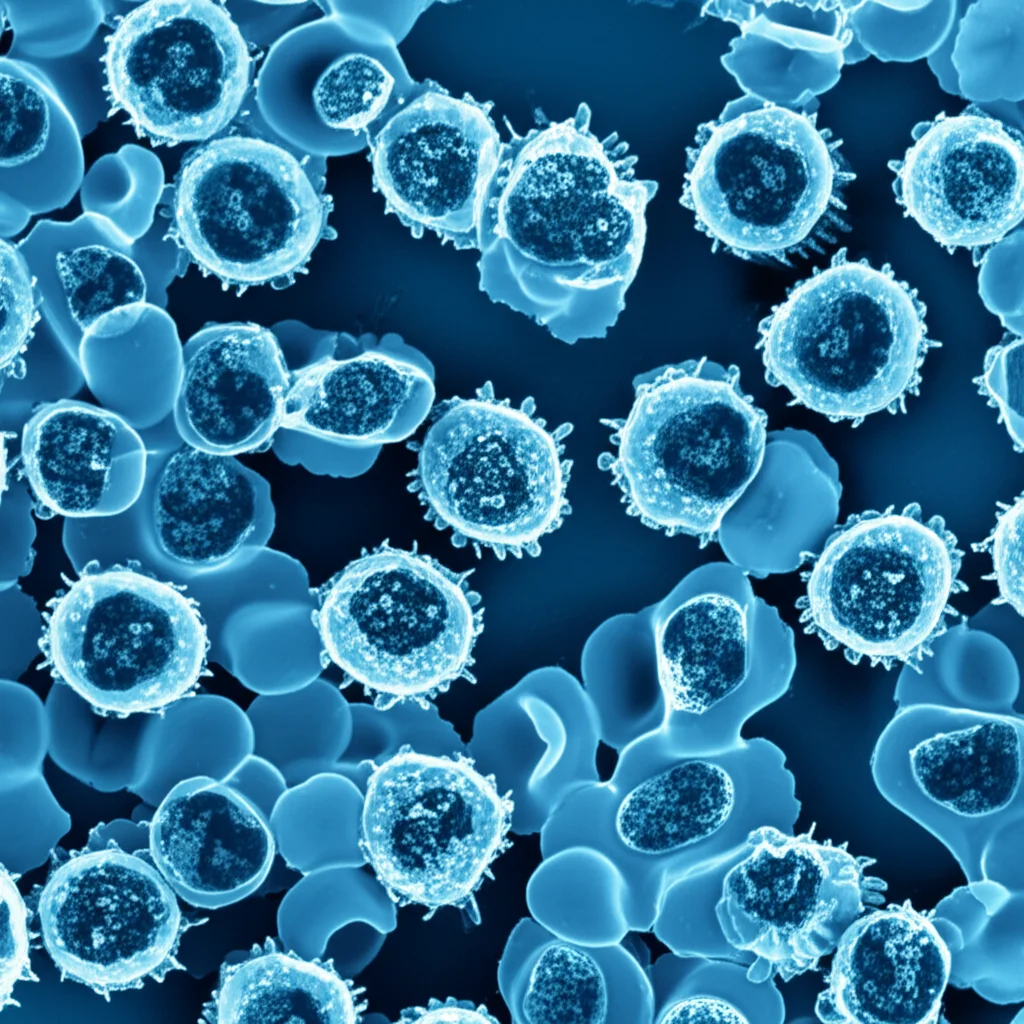
Queste cellule sono state poi “svegliate” in laboratorio: i monociti con interferone gamma (IFNγ), una potente citochina, e i linfociti T con delle sferette speciali (CD3/CD28 Dynabeads) che mimano un segnale di attivazione. Dopodiché, hanno misurato quali e quante citochine (messaggeri infiammatori e anti-infiammatori) venivano prodotte.
Cosa hanno scoperto i ricercatori? Un’analisi cellula per cellula
Tenetevi forte, perché i risultati sono davvero interessanti e aprono scenari promettenti!
Monociti “iperattivi” nella fase prodromica
Partiamo dai monociti. Quando stimolati, i monociti dei pazienti in fase prodromica hanno mostrato una secrezione significativamente aumentata di citochine pro-infiammatorie come il TNF (fattore di necrosi tumorale), l’IL-1β (interleuchina 1 beta) e l’IL-8 rispetto ai pazienti con Parkinson in fase moderata e ai controlli. È come se, in questa fase precocissima, i monociti fossero particolarmente “suscettibili” e pronti a scatenare una risposta infiammatoria più vigorosa. Questo è un dato importantissimo, perché suggerisce che un’eccessiva infiammazione periferica potrebbe contribuire alla progressione della malattia fin dalle sue primissime battute.
La cosa ancora più sbalorditiva è che la capacità predittiva di distinguere i soggetti prodromici dai controlli sani, basandosi sulla secrezione di TNF e IL-1β da parte dei monociti stimolati, era molto alta! Le curve ROC (uno strumento statistico per valutare l’accuratezza di un test diagnostico) hanno dato risultati eccellenti.
Linfociti T: una storia diversa ma altrettanto importante
Passando ai linfociti T, la situazione si è rivelata un po’ diversa, ma altrettanto informativa. Nei pazienti con Parkinson in fase iniziale-moderata, la secrezione di alcune citochine pro-infiammatorie dopo stimolazione era diminuita rispetto alla fase prodromica. Ad esempio, la secrezione di TNF dai linfociti T stimolati era più alta nei prodromici rispetto ai pazienti con malattia conclamata. Inoltre, la secrezione di IL-2 (importante per la maturazione dei linfociti T) e di IL-10 (una citochina generalmente anti-infiammatoria) era ridotta nei pazienti in fase moderata rispetto ai prodromici.
Questo quadro suggerisce che mentre nella fase prodromica il sistema immunitario sembra essere “iper-reattivo”, con l’avanzare della malattia potrebbe subentrare una sorta di “esaurimento” o disfunzione immunitaria, almeno per quanto riguarda i linfociti T. Anche qui, alcune citochine prodotte dai linfociti T stimolati si sono dimostrate utili per distinguere i vari stadi della malattia dai controlli sani.
Non solo citochine: uno sguardo alla salute mitocondriale e lisosomiale
Ma non è finita qui! I ricercatori hanno voluto scavare ancora più a fondo, andando a vedere la salute di due organelli cellulari cruciali: i mitocondri (le nostre centrali energetiche) e i lisosomi (i centri di riciclaggio della cellula). Sappiamo che disfunzioni mitocondriali e lisosomiali sono implicate nel Parkinson a livello neuronale, ma cosa succede nelle cellule immunitarie?
Ebbene, è emerso che i linfociti T CD8+ (un tipo di linfociti T citotossici) dei pazienti con Parkinson in fase moderata mostravano una salute mitocondriale peggiore dopo la stimolazione rispetto ai controlli. In pratica, i loro mitocondri sembravano meno capaci di far fronte all’aumentata richiesta energetica dovuta all’attivazione immunitaria. E, cosa affascinante, nei pazienti prodromici, una migliore salute mitocondriale nei linfociti T CD8+ era correlata positivamente con la secrezione di alcune citochine (IL-1β, IL-8, IL-10). Questo suggerisce un legame stretto tra energia cellulare e capacità di risposta immunitaria, che sembra alterarsi con il progredire della malattia.

Per quanto riguarda i lisosomi, è stato osservato un aumento dell’attività della catepsina (un enzima lisosomiale) nei monociti dei pazienti prodromici già a riposo, rispetto ai controlli. Questo potrebbe indicare un’aumentata richiesta di degradazione e riciclo cellulare in questa fase precoce.
L’attività della chinasi LRRK2: un altro pezzo del puzzle
Infine, un’occhiata a LRRK2, una proteina la cui mutazione è una causa genetica comune di Parkinson. Anche nelle forme idiopatiche (non genetiche) di Parkinson, LRRK2 sembra giocare un ruolo. Lo studio ha rivelato un aumento significativo dell’attività chinasica di LRRK2 (cioè della sua capacità di “accendere” altre proteine) nei monociti stimolati dei pazienti con Parkinson in fase iniziale e moderata rispetto ai controlli. Questo è un altro tassello che collega le forme genetiche e idiopatiche della malattia e suggerisce che modulare l’attività di LRRK2 potrebbe essere una strategia terapeutica.
Cosa significa tutto questo per noi? Biomarcatori e nuove speranze
Secondo me, questa ricerca è una vera miniera d’oro. Ci dice che analizzare la risposta delle cellule immunitarie a uno stimolo, piuttosto che limitarsi a misurazioni statiche, può fornirci informazioni molto più ricche e dinamiche sullo stato della malattia. Questi “profili di risposta immunitaria” potrebbero diventare dei biomarcatori potentissimi per:
- Identificare i soggetti a rischio o in fase prodromica, quando ancora non ci sono sintomi motori evidenti.
- Stratificare i pazienti in base al loro “endofenotipo” immunitario, permettendo di personalizzare le terapie e di arruolare pazienti più omogenei negli studi clinici (aumentando le chance di successo!).
- Monitorare la progressione della malattia e l’efficacia di nuovi trattamenti immunomodulatori.
Pensate alla possibilità di intervenire precocemente per “calmare” un sistema immunitario iperattivo nella fase prodromica, o per sostenere la funzione mitocondriale nelle fasi più avanzate. Si aprono scenari terapeutici davvero nuovi.
Limiti e prospettive future: la scienza non si ferma mai
Certo, come ogni studio, anche questo ha i suoi limiti. I gruppi di pazienti non erano enormi, e lo studio è trasversale (cioè fotografa la situazione in un dato momento, senza seguire gli stessi pazienti nel tempo per vedere chi effettivamente sviluppa il Parkinson motorio). Saranno necessari studi longitudinali su coorti più ampie per confermare questi risultati e vedere se questi marcatori immunitari predicono davvero la conversione a Parkinson conclamato. Inoltre, il disturbo RBD non è specifico al 100% per il Parkinson prodromico, potendo precedere anche altre sinucleinopatie.
Tuttavia, la strada tracciata è incredibilmente promettente. Approfondire il legame tra funzione immunitaria, bioenergetica cellulare (mitocondri) e degradazione (lisosomi) nel contesto del Parkinson potrebbe svelarci i meccanismi intimi della malattia e offrirci nuovi bersagli per combatterla.

Un messaggio di speranza
Quello che mi porto a casa da questa lettura è un forte senso di ottimismo. La possibilità di “interrogare” il nostro sistema immunitario per ottenere risposte così dettagliate sullo stato di salute del nostro cervello, anni prima che la malattia si manifesti pienamente, è qualcosa che fino a poco tempo fa sembrava fantascienza. Oggi, grazie a studi come questo, è un po’ più vicina alla realtà. E questo, amici miei, è il bello della ricerca scientifica: trasformare l’ignoto in conoscenza, e la conoscenza in speranza.
Fonte: Springer