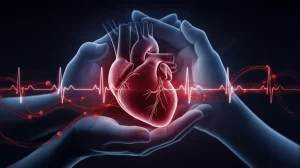Revisione tra Pari in Cina: Un Viaggio Affascinante tra Storia, Politica e ‘Renqing’
Ciao a tutti! Oggi voglio portarvi con me in un viaggio affascinante e un po’ inaspettato nel mondo della scienza, ma visto da una prospettiva diversa: quella cinese. Parleremo di peer review, quel processo che sta al cuore della ricerca scientifica moderna, ma ci concentreremo su come si è evoluto e quali sfide affronta nelle riviste nazionali cinesi. Siete pronti? Allacciate le cinture, perché la storia è più complessa e interessante di quanto si possa pensare!
Quando pensiamo alla peer review, o revisione tra pari, di solito ci vengono in mente le grandi riviste internazionali, quelle in inglese che dettano legge nel mondo accademico. Ma che dire delle riviste nazionali, quelle scritte in altre lingue, come il cinese? Sono importanti, eccome! Pubblicano ricerche rilevanti per contesti locali, sono lette da ricercatori e stakeholder nazionali e spesso affrontano problemi specifici di un paese. Eppure, se ne parla pochissimo.
Ecco perché ho trovato super interessante uno studio recente che ha usato la lente dell’istituzionalismo storico per ricostruire la storia della peer review in Cina. Questo approccio ci aiuta a capire come le istituzioni (in questo caso, il sistema di peer review) nascono, si mantengono e cambiano nel tempo, influenzate dal contesto storico, sociale e politico.
Le Radici Lontane: Prime Scintille nel XVIII Secolo
Pensate un po’, le prime forme di revisione tra pari in Cina sembrano risalire addirittura al XVIII secolo! Già allora, gli intellettuali cinesi, influenzati dal confucianesimo, credevano fermamente in due cose:
- La ricerca seria per nuova conoscenza è una virtù.
- La conoscenza si acquisisce meglio condividendo e discutendo con altri (“studiare da soli, senza amici, porta a una conoscenza superficiale”).
Queste convinzioni portarono alla nascita di pratiche simili alla peer review in alcune delle primissime riviste accademiche/scientifiche cinesi, come il Wuyi Huijiang (una raccolta di articoli medici del 1792). Il curatore, Dalie Tang, discuteva attentamente i manoscritti ricevuti con alcuni colleghi prima di decidere se pubblicarli. Sorprendente, vero? Soprattutto considerando che i contatti con l’Europa scientifica erano limitati. Purtroppo, questa tradizione iniziale non durò a lungo. Le sconfitte militari contro le potenze occidentali e il Giappone nel XIX secolo spinsero la Cina ad adottare sempre più i modelli scientifici europei e nordamericani.
L’Influenza Occidentale e i Primi Passi Formali (Inizio XX Secolo)
All’inizio del XX secolo, con l’arrivo delle missioni cristiane e la fondazione della Repubblica di Cina (1912), il panorama cambiò. Le università, sia quelle fondate dai missionari sia quelle cinesi, iniziarono a pubblicare riviste. All’inizio, erano spesso gestite da studenti, con poca attenzione alla revisione scientifica.
Tuttavia, alcuni studiosi cinesi, specialmente quelli che avevano studiato all’estero, iniziarono a spingere per un approccio più rigoroso, ispirato alle pratiche occidentali. Nacquero riviste importanti come il National Medical Journal of China (NMJC) e Science (fondata nel 1915 da studenti cinesi negli USA!). Queste riviste iniziarono a:
- Avere comitati editoriali composti da accademici esperti (a volte anche stranieri o esperti esterni all’accademia).
- Implementare processi di revisione per valutare la qualità scientifica dei manoscritti.
- Avere una portata nazionale, non solo universitaria.
- Concentrarsi molto sui campi STEMM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Matematica, Medicina), visti come chiave per il progresso.
In questo periodo, si iniziò a delineare una divisione: le discipline STEMM guardavano sempre più agli standard internazionali, mentre le scienze sociali tendevano a mantenere un focus più “indigeno”. Insomma, la peer review “moderna” iniziava a farsi strada, ma solo in alcuni settori e in modo non uniforme.

Tra Politica e Scienza: Il Dopoguerra e la Rivoluzione Culturale (1949-1990s)
Dopo la fondazione della Repubblica Popolare Cinese nel 1949, tutto cambiò di nuovo. Il governo prese il controllo dell’editoria. Sebbene ci fosse un iniziale sviluppo delle riviste scientifiche (sotto lo slogan “Marcia verso la scienza”), la Rivoluzione Culturale (1966-1976) portò scompiglio e molte riviste chiusero.
La caratteristica dominante di questo lungo periodo fu l’implementazione del cosiddetto “sistema di revisione a 3 livelli” (3-level review system), influenzato dal modello sovietico. Cosa significava?
- I manoscritti venivano revisionati internamente dall’editore, poi dal direttore editoriale e infine dal caporedattore/capo ufficio editoriale.
- La revisione era basata su una logica amministrativa e gerarchica, non su una valutazione scientifica da parte di esperti esterni del settore.
- L’aspetto politico aveva la priorità assoluta sulla qualità scientifica. Le normative sottolineavano la necessità di verificare l’aderenza alla linea del Partito, alle politiche statali e alle norme sulla segretezza.
In pratica, la peer review come la intendiamo noi (valutazione scientifica da parte di pari) fu quasi completamente abbandonata in favore di un controllo politico e amministrativo. C’era una totale disconnessione dalle pratiche internazionali. Solo verso la fine di questo periodo, con la riapertura della Cina, si iniziò lentamente a ricostruire il sistema delle pubblicazioni scientifiche, ma il retaggio del controllo politico rimase forte.
Verso la Globalizzazione (e Ritorno?): Il Peer Review Oggi (Dal 2000)
Con l’ingresso nel XXI secolo, la Cina è diventata una superpotenza scientifica globale. La produzione di ricerca è esplosa e la pubblicazione su riviste internazionali peer-reviewed è diventata un obiettivo primario. Questo ha avuto un impatto enorme anche sulle riviste nazionali.
Il governo ha lanciato iniziative per migliorare la qualità e l’internazionalizzazione delle riviste cinesi (come la serie Frontiers Journals o piani specifici). Si è iniziato a parlare seriamente di adottare standard di peer review globali. Già nei tardi anni ’90, alcune riviste di scienze sociali avevano introdotto la revisione anonima. Nel 2002, il Ministero dell’Educazione ha formalmente richiesto alle riviste di scienze umane e sociali di implementare la revisione doppio cieco (double anonymous review) per garantire scientificità e correttezza.
Oggi, la stragrande maggioranza delle riviste scientifiche cinesi (oltre il 97% secondo uno studio del 2018) dichiara di usare la peer review anonima. Un passo avanti enorme! Tuttavia, c’è un “ma”:
- Molte (oltre il 53%) usano ancora la revisione singolo cieco (single-blind), dove il revisore conosce l’identità dell’autore. Questo sistema è più vulnerabile a bias.
- La qualità e l’efficienza della revisione sono spesso criticate.
Le riviste cinesi stanno cercando di allinearsi agli standard globali, e i miglioramenti sono evidenti (aumento delle citazioni, impact factor, presenza in database internazionali come Scopus e Web of Science). Ma il percorso non è ancora completo e presenta delle peculiarità uniche.

Sfide Attuali: Tra Standard Globali e “Renqing”
Ed eccoci al nodo cruciale. Nonostante l’adozione formale della peer review, il sistema cinese attuale sembra essere un ibrido, un mix tra principi globali e una logica molto radicata nella cultura cinese: il renqing (人情).
Cos’è il renqing? È un concetto complesso che riguarda i favori, la reciprocità a lungo termine, le relazioni sociali e personali. Nel contesto della peer review, significa che editori e revisori potrebbero sentirsi “in dovere” di trattare con favore gli articoli di studiosi importanti o con cui hanno legami personali, indipendentemente dalla qualità scientifica intrinseca del lavoro.
Perché succede? Ci sono diverse ragioni interconnesse:
- Pressione “Publish or Perish”: Gli accademici cinesi sono sotto un’enorme pressione per pubblicare su riviste di alto livello (spesso definite da classifiche nazionali come CSSCI, AMI, RCCSE) per ottenere promozioni e valutazioni positive.
- Competizione tra Riviste: Anche le riviste competono ferocemente per entrare in queste classifiche “core”. Pubblicare autori famosi aiuta a migliorare il ranking della rivista.
- Logica di Reciprocità: Si crea un circolo vizioso: le riviste cercano autori di fama, gli autori cercano di pubblicare su riviste “core”. Il renqing diventa un lubrificante sociale che facilita questo scambio, spesso a scapito del merito scientifico.
- Dipendenza Istituzionale: Molte riviste dipendono da università o istituti di ricerca per finanziamenti e gestione. Questo crea una gerarchia dove i “vertici” dell’istituzione possono influenzare le decisioni editoriali, magari “raccomandando” la pubblicazione di certi articoli.
Alcuni critici parlano addirittura di “science charade“, una sorta di messinscena in cui il processo di peer review è solo una formalità, mentre le decisioni sono già prese sulla base di potere e relazioni. L’uso diffuso del single-blind review potrebbe anche facilitare queste dinamiche, rendendo più facile per i revisori riconoscere (e potenzialmente favorire) certi autori.

Un Percorso Unico: Cosa Ci Dice l’Istituzionalismo Storico
Tirando le somme, la storia della peer review in Cina non è stata una linea retta. Non è un’istituzione che, una volta nata, è cresciuta stabilmente come forse è successo in Occidente. È stata piuttosto una storia di rotture, pause, ripartenze e adattamenti interpretativi.
L’istituzionalismo storico ci mostra che:
- La peer review in Cina è stata costantemente influenzata da eventi politici (cambi di regime, Rivoluzione Culturale), priorità governative (spinta all’industrializzazione, poi alla globalizzazione), e fattori culturali (il renqing).
- Non c’è stata una vera “dipendenza dal percorso” (path dependence) stabile. Ogni periodo ha quasi riscritto le regole.
- Il sistema attuale è un ibrido: adotta pratiche globali (come la revisione anonima) ma le interpreta e le adatta al contesto cinese, mantenendo elementi culturali e rispondendo a pressioni locali (competizione accademica, classifiche). Potremmo chiamarla una “peer review con caratteristiche cinesi“.
- Il potere statale gioca ancora un ruolo importante nel regolare le riviste accademiche, un elemento che distingue il sistema cinese da quello di molti altri paesi dove prevale una logica di mercato (editori privati) o puramente scientifica.
Insomma, capire la peer review nelle riviste nazionali cinesi ci offre uno spaccato affascinante non solo dell’editoria accademica, ma anche della scienza cinese nel suo complesso, del suo rapporto con la tradizione, la politica e la globalizzazione. È un sistema in evoluzione, pieno di contraddizioni ma anche di grande dinamismo.
Spero che questo viaggio vi sia piaciuto e vi abbia offerto qualche spunto di riflessione! È fondamentale guardare oltre i soliti schemi per comprendere davvero come funziona la scienza nei diversi angoli del mondo.
Fonte: Springer