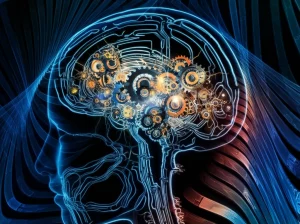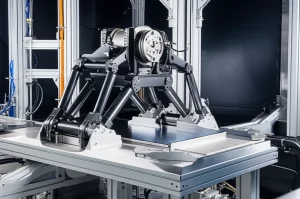Responsabilità Penale: Quando un Gesto Involontario Diventa Colpa Mia?
Ciao a tutti! Oggi voglio portarvi con me in un viaggio affascinante e un po’ intricato nel cuore del diritto penale. Parliamo di qualcosa che tocca le fondamenta stesse della giustizia: quando possiamo dire che qualcuno è davvero responsabile per un’azione, specialmente quando si tratta di reati?
Partiamo da un presupposto che sembra quasi ovvio: nel diritto penale, per essere considerati colpevoli, dobbiamo essere, come minimo, moralmente responsabili per quello che abbiamo fatto. Sembra logico, no? Non possiamo essere puniti per qualcosa che sfugge completamente al nostro controllo, come uno spasmo muscolare improvviso, un riflesso involontario, una crisi epilettica o le azioni compiute durante un episodio di sonnambulismo. Su questo punto, un pensatore che ho studiato di recente, Simester, nel suo libro Fundamentals of Criminal Law: Responsibility, Culpability, and Wrongdoing, è d’accordo. È un principio base.
Ma ecco dove le cose si fanno interessanti. Simester, pur accettando questa base, lancia una sfida a come intendiamo comunemente la responsabilità morale stessa. In particolare, mette in discussione il legame che di solito diamo per scontato tra responsabilità morale, volontarietà e agency (la capacità di agire). L’idea comune è che per essere responsabili, dobbiamo aver agito volontariamente, cioè intenzionalmente (almeno sotto una qualche descrizione). Simester non è convinto, e porta argomenti che, devo dire, mi hanno fatto riflettere parecchio.
In questo articolo, voglio esplorare insieme a voi le idee di Simester, vedendo dove secondo me coglie nel segno e dove, forse, la sua analisi potrebbe essere messa in discussione. Ci tufferemo un po’ anche nella filosofia dell’azione e della responsabilità morale, perché, credetemi, questi campi hanno molto da dirci! D’ora in poi, quando dirò “responsabilità”, intenderò quella morale, ok?
La Sfida di Simester: Responsabilità Senza Azione Volontaria?
Secondo Simester, la visione standard – quella che dice “responsabilità richiede agency volontaria” (cioè un comportamento intenzionale) – non regge per due motivi principali.
Primo: possiamo essere responsabili anche per comportamenti che non sono vere e proprie azioni.
Secondo: possiamo essere responsabili anche per azioni che non sono intenzionali sotto nessuna descrizione (lui le chiama “azioni non-volitive”).
Per sostenere queste tesi, Simester usa esempi concreti. Vediamone alcuni:
- Keith: Keith respira normalmente. (Un comportamento non-azionale)
- ABC: Alan prende la mano di Bob e con essa colpisce Charles. Bob potrebbe resistere ad Alan ma sceglie di non farlo. (Un altro comportamento non-azionale, o meglio, un’omissione)
- Jill: Jill si gratta il naso distrattamente mentre è sovrappensiero. (Un’azione “non-volitiva”)
- Georgina: Georgina sta cucinando. Parlando animatamente, la sua mano si avvicina pericolosamente al fornello. Un’amica se ne accorge e sta per intervenire, ma un attimo prima Georgina sposta la mano, senza rendersene conto. Se non l’avesse fatto, l’amica (più forte e attenta) l’avrebbe spostata forzatamente. Georgina non è consapevole del movimento. (Un’altra azione “non-volitiva”)
Responsabilità per Non-Azioni: Una Questione di Scelte Precedenti?
Riguardo al primo tipo di casi (Keith e ABC), sono abbastanza d’accordo con Simester: non sono azioni in senso stretto, ma possiamo esserne responsabili. Tuttavia, penso che la visione standard possa facilmente gestire questi casi. Come? Considerandoli esempi di responsabilità derivata o non-basica.
Mi spiego meglio. Siamo responsabili in modo derivato per qualcosa quando la nostra responsabilità dipende da altre cose per cui siamo responsabili, come azioni o decisioni precedenti. Pensate alla guida in stato di ebbrezza: un guidatore ubriaco può essere responsabile per il suo comportamento pericoloso al volante, anche se al momento non ha pieno controllo (e quindi non agisce intenzionalmente in ogni suo gesto), perché la sua responsabilità deriva dalla scelta precedente di bere e mettersi alla guida.
La visione standard, probabilmente, si riferisce alla responsabilità basica quando richiede l’intenzionalità. Quindi, il caso del guidatore ubriaco non la smentisce. Allo stesso modo, Keith potrebbe essere responsabile per aver respirato in un certo momento se ha scelto di non trattenere il respiro quando poteva (e magari doveva) farlo. E Bob è responsabile per il danno a Charles perché ha scelto di non resistere ad Alan. In entrambi i casi, la responsabilità per il comportamento non-azionale deriva da una scelta precedente.

Un altro punto interessante: Simester nota che in questi casi gli agenti hanno un “controllo regolativo”, cioè potevano prevenire l’esito (Keith poteva trattenere il respiro, Bob poteva resistere). Lui pensa che questo controllo sia una base per la responsabilità. Io la vedo un po’ diversamente: il fatto che potessero intervenire mostra che il loro comportamento (respirare, la mano che colpisce) è una genuina conseguenza della loro scelta precedente (non trattenere il respiro, non resistere). Se Bob non avesse potuto resistere, il movimento della sua mano non sarebbe una conseguenza della sua scelta di non intervenire. Torneremo su questo concetto di controllo regolativo.
Azioni “Non-Volitive”: Davvero Non Intenzionali?
Passiamo ora al secondo tipo di casi, le azioni “non-volitive” come quelle di Jill e Georgina. Questi, secondo me, pongono una sfida più interessante alla visione standard. Simester dice: Jill e Georgina agiscono, ma non intenzionalmente. Eppure, possono essere responsabili. Quindi, conclude, la responsabilità non richiede agency volontaria o intenzionale, nemmeno per la responsabilità basica (perché qui non sembra esserci una scelta precedente da cui derivare la responsabilità).
Qui, però, non sono d’accordo con la diagnosi di Simester. Certo, Georgina può essere responsabile anche se non aveva controllo regolativo (per via dell’amica pronta a intervenire), ma io penso che Georgina agisca intenzionalmente quando sposta la mano dal fornello.
Il caso di Georgina (e anche quello di Jill) mi sembra rientrare in una categoria più ampia di comportamenti – azioni spontanee, automatiche, abituali – che i filosofi dell’azione hanno discusso molto. Molti (specialmente i “causalisti”) le considerano azioni intenzionali. Cosa le distingue dalle azioni deliberate? Non l’assenza di un’intenzione che le causa, ma il modo in cui quell’intenzione si forma: spontaneamente, senza un processo di ragionamento pratico o una decisione esplicita. Jill non *decide* di grattarsi il naso, semplicemente lo fa, spinta da un’intenzione sorta spontaneamente.
Pensateci: gran parte della nostra vita quotidiana è fatta di azioni così! Alzarsi dal letto, andare in bagno, guidare verso il lavoro premendo acceleratore e freno, svoltando agli incroci familiari… Molte di queste azioni intenzionali avvengono “sotto il nostro radar”, senza richiedere deliberazione o consapevolezza cosciente. Anzi, questa automaticità ci aiuta a funzionare! Negare l’intenzionalità a queste azioni comuni mi sembra sottovalutare enormemente la nostra capacità di agire (la nostra agency).

Concedere che siano intenzionali non richiede molto: basta postulare intenzioni acquisite in modo non riflessivo e spontaneo. Non serve nemmeno che queste intenzioni siano super specifiche (“muovere il piede esattamente così”). Un’intenzione generale (come “fare una passeggiata”) può rendere intenzionali tutte le azioni specifiche che la compongono (camminare, muovere i piedi in un certo modo). E non dobbiamo nemmeno pensare, come faceva Davidson, che ogni azione intenzionale sia fatta *per* una ragione (nel senso di avere credenze e desideri come cause). Basta che l’azione sia causata da un’intenzione con il contenuto appropriato. Possiamo non essere consapevoli dell’intenzione o del perché agiamo, ma l’azione resta intenzionale.
La Vera Lezione: Sensibilità alle Ragioni (Anche Quelle Assenti)
Anche se critico la diagnosi di Simester sulle azioni “non-volitive”, sono d’accordo con lui su un punto importante: questi casi sono speciali e istruttivi. Ci aiutano a capire meglio la natura dell’agency responsabile.
La domanda che sorge è: come possiamo essere responsabili per azioni eseguite inconsciamente, quasi automaticamente, magari senza nemmeno rispondere a ragioni specifiche? Può sembrare un puzzle. Ma credo ci sia una risposta soddisfacente. In breve: anche in questi casi, mostriamo una certa sensibilità alle ragioni, anche se non nel modo tradizionale “Davidsoniano”.
Seguendo e ampliando un’idea di Arpaly e Schroeder, ho sostenuto (in lavori precedenti) che anche quando non agiamo *per* ragioni specifiche (come quando svoltiamo automaticamente a un incrocio familiare), le nostre azioni sono comunque modellate dalle ragioni in modo significativo. Siamo sensibili alle caratteristiche rilevanti dell’ambiente (come ci appaiono): notiamo (magari inconsciamente) l’assenza di ostacoli o minacce evidenti (camion dei pompieri, lavori in corso, altre auto che passano col rosso…).
Questa sensibilità riguarda spesso caratteristiche negative: siamo sensibili al fatto che le circostanze non sono tali da giustificare il non fare ciò che stiamo facendo. Siamo sensibili all’assenza di ragioni (sufficienti) per astenerci. Questa assenza di ragioni per non agire è parte della spiegazione del nostro comportamento tanto quanto le ragioni positive che potremmo avere.
Questo vale quasi sempre, anche quando agiamo deliberatamente. Quando vado verso il frigo per prendere il latte, rispondo alla ragione “voglio il latte”, ma sono anche sensibile all’assenza di ragioni per non fare quel passo (non credo che attiverò una bomba, pesterò un gattino, cadrò in un buco…). Tutto questo avviene per lo più inconsciamente, ma è ciò che distingue noi agenti razionali da robot programmati o da esseri che agiscono solo d’impulso (come alcuni animali o bambini molto piccoli).
Secondo me, questa sensibilità alle ragioni (incluse le assenze di ragioni contrarie) è una parte essenziale di ciò che ci rende responsabili per le nostre azioni, anche quelle non riflesse. Ci dà il tipo di controllo necessario. Simester, invece, sembra pensare che basti il fatto che siano atti (cose che facciamo, non che ci accadono) a renderci responsabili. Sono d’accordo che sia parte della spiegazione, ma non può essere tutto. Anche i cleptomani “agiscono”, ma non li riteniamo pienamente responsabili. L’ingrediente mancante, suggerisco, è proprio questa sensibilità alle ragioni.
Quindi, le azioni non riflesse ci insegnano che, forse contrariamente a Simester, l’agire intenzionale è necessario per la responsabilità (i suoi esempi non dimostrano il contrario). Ma l’agire intenzionale è compatibile con una sensibilità alle ragioni che spesso opera sotto il livello della coscienza. È questa sensibilità che fonda la nostra responsabilità.
Controllo Regolativo, Omissioni e Causalità: Un’Altra Prospettiva
C’è un altro punto di disaccordo con Simester che voglio discutere. Riguarda il ruolo del controllo regolativo (la capacità di intervenire e cambiare il corso degli eventi) nella sua visione. Simester si rifà al concetto di “guida” di Frankfurt. Frankfurt sostiene che un comportamento è un’azione se avviene sotto la guida dell’agente, e che questa guida non richiede necessariamente una causalità attuale. Basta che l’agente sia pronto a intervenire se necessario. L’esempio classico è quello dell’autista la cui auto scende da una collina per gravità (Coasting): se l’autista è soddisfatto della velocità e direzione e non interviene, l’auto è comunque sotto la sua guida perché era pronto a farlo. Frankfurt (e Simester sembra concordare) ne conclude che la causalità attuale non è necessaria per l’agency.

Qui, di nuovo, dissento. Almeno, se accettiamo (come fa Simester) che le omissioni o le assenze possano essere cause. Se le omissioni possono causare effetti, allora il caso “Coasting” è un chiaro esempio di causalità omissiva: l’auto si muove in quel modo (anche) perché l’autista omette di intervenire. Il suo non-intervento è causalmente rilevante. Quindi, un causalista (chi crede che le azioni siano definite dalla loro storia causale) può spiegare benissimo perché quello dell’autista è un agire.
L’esempio, secondo me, non mostra che il causalismo è falso o incompleto (come sembra pensare Simester), ma che è una teoria più ricca di quanto si creda. Il causalismo dice che ciò che rende un comportamento un’azione è un certo tipo di storia causale. Questo è compatibile col fatto che quella storia causale sia a sua volta fondata su qualcos’altro, come il controllo regolativo! Il controllo regolativo a cui puntano Frankfurt e Simester non è un rivale della causalità, ma può essere visto come ciò che fonda o supporta le spiegazioni causali rilevanti in questi casi. L’auto è sotto la guida dell’autista (azione) perché ha una certa storia causale (causata anche dall’omissione di intervento), e ha quella storia causale perché l’autista aveva controllo regolativo.
Poteri, Capacità e il Problema della Causalità Deviante
Infine, Simester suggerisce che per spiegare perché Jill e Georgina agiscono (anche se non intenzionalmente, secondo lui) dobbiamo guardare ai poteri o capacità che esercitano. Sembra pensare che siano gli stessi poteri esercitati nell’azione intenzionale, ma qui usati inconsciamente. E accenna che questo potrebbe aiutare a risolvere il famoso problema della “causalità deviante” per il causalismo (come distinguere le catene causali “giuste”, che producono un’azione, da quelle “sbagliate”, che producono solo un movimento?). L’idea sarebbe che le catene causali giuste sono quelle in cui l’agente esercita le capacità rilevanti.
Se questa è la proposta, sono d’accordo! Anch’io ho sostenuto, insieme ad altri causalisti, che un appello ai poteri può essere utile qui. Ma, ancora una volta, non vedo questo come un semplice complemento al causalismo, o come l’ingrediente mancante. Piuttosto, lo vedo come un modo per sviluppare la teoria causalista in maggior dettaglio, spiegando la natura di ciò che fonda le storie causali corrette.
Il problema della causalità deviante sorge ovunque ci siano spiegazioni causali, non solo per le azioni. Pensate alle disposizioni, come la fragilità di un vaso. Un vaso è fragile perché si romperebbe *se* colpito, *a causa* dell’essere colpito. Ma immaginate un mago che rompe gli oggetti subito dopo che vengono colpiti, indipendentemente dalla loro composizione. Se il nostro vaso fragile viene colpito e il mago lo rompe, il vaso si rompe *a causa* dell’essere colpito, ma non manifesta la sua fragilità. La catena causale è deviante.
Se questo vale per i vasi, non dovrebbe sorprenderci che valga anche per gli agenti e il loro potere di agire quando intendono farlo. Posso muovermi *a causa* della mia intenzione di muovermi, ma non essere una vera azione se la catena causale è deviante. Quando è del tipo giusto? Forse non c’è una risposta super informativa, ma se distinguiamo tra modi giusti e sbagliati per un vaso di rompersi (manifestando o meno la fragilità), è naturale aspettarsi che ci siano modi giusti e sbagliati per un agente di comportarsi quando intende farlo (manifestando o meno i poteri agenziali).
Un vantaggio di questa visione è che l’agency potrebbe sembrare molto meno misteriosa, vista la sua somiglianza con le disposizioni ordinarie.
Insomma, il dibattito su agency, responsabilità e intenzionalità è tutt’altro che chiuso. Le riflessioni di Simester sono preziose perché ci costringono a esaminare le nostre assunzioni più profonde. Anche se non concordo su tutto, esplorare queste idee ci aiuta a capire meglio cosa significa essere agenti responsabili nel complesso mondo del diritto e della morale.
Fonte: Springer