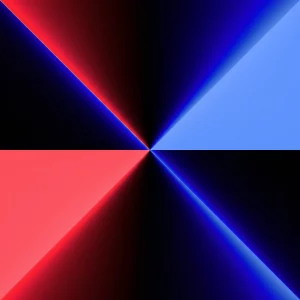Regimi Ibridi: Davvero Più Violenti? Facciamo Chiarezza!
Amici, oggi voglio parlarvi di una questione che mi sta particolarmente a cuore e che, diciamocelo chiaramente, tocca le vite di milioni di persone: la repressione statale violenta. Sapete, quella brutta storia di torture e omicidi politici perpetrati da chi dovrebbe proteggerci. Una delle domande che ci si pone spesso in scienze politiche è: il tipo di regime politico di un paese influenza questa violenza? E soprattutto, cosa succede in quei regimi un po’ strani, né carne né pesce, che chiamiamo ibridi? Quelli, insomma, che mescolano elementi democratici con tratti autoritari.
Le vecchie teorie: regimi ibridi sul banco degli imputati?
Per un po’ di tempo, nel nostro campo, sono circolate due idee principali.
- La prima, che potremmo definire della “curva a U rovesciata”, sosteneva che i regimi ibridi fossero i più cattivi di tutti. Più violenti delle democrazie conclamate (e fin qui, ci sta) ma, udite udite, anche più delle autocrazie pure e dure! La logica? Le autocrazie totali, si diceva, sono così brave a controllare tutto e tutti, magari con l’indottrinamento o la paura preventiva, che non hanno bisogno di sporcarsi troppo le mani. I regimi ibridi, invece, concedendo qualche libertà, darebbero all’opposizione quel tanto che basta per organizzarsi e diventare una minaccia. E a quel punto, zac! Repressione violenta per mantenere il potere.
- La seconda teoria, invece, parlava di un “effetto soglia”. In pratica, solo le democrazie di alta qualità, quelle con tutto il pacchetto di diritti e libertà ben funzionante, riuscirebbero davvero a ridurre la repressione. Regimi ibridi e autocrazie? Tutti sullo stesso piano, un disastro per i diritti umani.
Insomma, secondo queste prospettive, i regimi ibridi o erano i peggiori o comunque non facevano meglio delle dittature conclamate.
Perché mettere in discussione il “già detto”?
Ora, io sono uno che di natura tende a non accontentarsi delle risposte facili. E queste teorie, per quanto affascinanti, mi lasciavano qualche dubbio.
Primo, non è così scontato che le autocrazie pure siano meno violente. Anzi, potrebbero generare più malcontento e avere meno freni nell’usare la forza. Se così fosse, più un regime si avvicina alla democrazia, meno violenza dovremmo vedere, anche se quella democrazia è un po’ zoppicante.
Secondo, gli studi precedenti spesso si basavano su periodi di tempo limitati, magari dagli anni ’70 in poi. Ma la storia è lunga, e molta “azione” potrebbe essersi persa. Pensate alle autocrazie: magari sono più violente all’inizio, prima di consolidare il controllo.
Terzo, molti studi usavano dati (come quelli di Polity) che, per come sono costruiti, tendono ad associare i valori intermedi (i nostri regimi ibridi) a situazioni di conflitto e violenza. Un po’ come dire che l’acqua è bagnata, no? E poi, questi dati non sempre colgono bene le differenze qualitative tra i regimi.

La mia indagine: nuovi dati, nuove prospettive
Così, mi sono rimboccato le maniche e ho deciso di vederci più chiaro. La mia domanda di ricerca era semplice: i livelli di repressione statale sono generalmente più alti nei regimi ibridi rispetto ad altri tipi di regime più autocratici o democratici?
Per rispondere, ho messo insieme un’analisi empirica nuova di zecca, usando dataset che coprono la maggior parte dei paesi per oltre due secoli! Una marea di dati, amici.
Per misurare la repressione violenta, ho usato il Physical Violence Index del V-Dem Institute, che traccia torture e omicidi politici dal 1789. Per i tipi di regime, ho usato sia misure continue di democrazia (come l’Electoral Democracy Index, EDI, sempre di V-Dem) sia distinzioni categoriche basate su due fantastici dataset: il Political Regimes of the World Dataset (PRWD) e il Lexical Index of Electoral Democracy (LIED). Questi mi hanno permesso di distinguere tra democrazie elettorali, vari tipi di regimi ibridi (come regimi autoritari multipartitici e democrazie ristrette) e autocrazie chiuse (personaliste, militari, monarchiche, a partito unico).
L’idea era di avere una visione molto più ampia e dettagliata rispetto al passato.
I risultati: una sorpresa (forse non per tutti)
Ebbene, cosa è emerso da questa faticaccia? Tenetevi forte: i risultati non supportano nessuna delle due teorie dominanti!
Né la curva a U rovesciata, né l’effetto soglia che mette sullo stesso piano ibridi e autocrazie.
Quando ho usato le misure continue di democrazia (l’EDI), ho trovato una relazione interessante. Invece di una U rovesciata, la relazione è concava. Che significa? Che all’aumentare del livello di democrazia, la repressione violenta diminuisce, ma l’effetto di riduzione è maggiore quando si passa da livelli bassi a medi di democrazia, e poi si attenua man mano che ci si avvicina a democrazie di alta qualità. Ma la tendenza è chiara: più democrazia, meno violenza. Il punto di svolta, dove la repressione è massima, non è nei regimi ibridi, ma nelle autocrazie più estreme.
E con le categorie di regime? Stessa musica!
I regimi ibridi, sia usando le distinzioni del PRWD che quelle del LIED, mostrano livelli di repressione intermedi. Sono significativamente più violenti delle democrazie piene, ma meno violenti delle autocrazie conclamate.
Anzi, analizzando più a fondo i diversi tipi di regimi ibridi, sembra che quelli con caratteristiche più democratiche tendano ad essere associati a livelli significativamente più bassi di violenza fisica statale.
Quindi, c’è una sorta di scala: le autocrazie chiuse sono le peggiori, poi vengono i regimi ibridi, e infine le democrazie (specialmente quelle di alta qualità, le poliarchie) con i livelli di repressione più bassi.

Cosa ci dice tutto questo? Implicazioni per le democrazie in pericolo
Questi risultati, secondo me, sono piuttosto importanti, specialmente oggi che vediamo tante democrazie “in pericolo” e un aumento di regimi ibridi e autocratici.
Da un lato, è chiaro che qualsiasi alternativa a una democrazia di alta qualità tende a mostrare un record peggiore in termini di diritti umani e repressione fisica. Questo dovrebbe farci riflettere molto sull’importanza di difendere e promuovere istituzioni democratiche solide.
Dall’altro lato, però, i regimi ibridi, con il loro mix di caratteristiche, non sembrano essere associati a livelli di repressione violenta superiori a quelli delle autocrazie pure. Anzi, generalmente mostrano livelli più bassi. Questo smonta un po’ quelle giustificazioni che a volte si sentono, secondo cui un regime autoritario “forte” sarebbe necessario per garantire ordine e stabilità, implicando meno violenza. I dati dicono altro.
Certo, come in ogni ricerca, un pizzico di cautela è d’obbligo. La qualità dei dati, per quanto migliorata, presenta sempre delle sfide, e i modelli statistici hanno i loro limiti. Ma i risultati sono robusti attraverso diverse specificazioni e modelli, il che mi dà una certa fiducia.
Un invito a non dare nulla per scontato
In conclusione, questa mia analisi suggerisce che i regimi ibridi si collocano davvero “nel mezzo” anche per quanto riguarda la repressione violenta. Non sono i “mostri” che alcuni dipingevano, né sono indistinguibili dalle autocrazie più feroci. Semplicemente, più un regime si allontana dai principi democratici, più tende a diventare violento.
Credo che questo studio dimostri quanto sia importante continuare a mettere in discussione le “verità acquisite”, affinare i nostri strumenti concettuali e metodologici, e rivisitare le grandi domande quando abbiamo nuove idee o dati migliori. Solo così possiamo sperare di capire un po’ meglio il mondo complesso in cui viviamo. E magari, chissà, contribuire a renderlo un posto un po’ meno violento.
Fonte: Springer