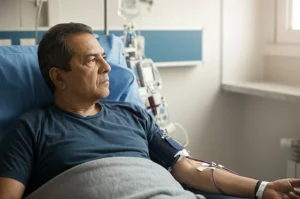Ictus e Riabilitazione: L’Intelligenza Artificiale ci Dice (Quasi) Come Andrà a Finire?
Amici, parliamoci chiaro: quando un ictus colpisce, la vita di una persona e dei suoi cari viene stravolta. Dopo la fase acuta, inizia un percorso cruciale: la riabilitazione. E qui sorge la domanda da un milione di dollari: “Come andrà? Quanto recupererò?”. Dare una risposta precisa è sempre stato un terno al lotto, o quasi. Ma se vi dicessi che oggi, grazie all’intelligenza artificiale (IA), o come la chiamano i più “nerd” machine learning (ML), stiamo facendo passi da gigante per rendere queste previsioni molto più accurate? Beh, mettetevi comodi, perché è proprio di questo che voglio parlarvi oggi.
Immaginate la scena: un paziente arriva in un centro di riabilitazione intensiva. Medici, fisioterapisti, infermieri, tutti pronti a dare il massimo. Ma come definire gli obiettivi giusti? Come preparare al meglio il paziente e la sua famiglia a ciò che li aspetta? Avere una prognosi funzionale affidabile è, diciamocelo, fondamentale. E qui entra in gioco la nostra ricerca, un viaggio affascinante nel mondo dei dati e degli algoritmi.
La Sfida: Prevedere il Futuro della Riabilitazione
L’obiettivo universalmente riconosciuto nella cura dell’ictus è quello di arrivare a un approccio di Medicina Predittiva, Preventiva e Personalizzata. Sembra fantascienza, vero? Eppure, è la direzione verso cui stiamo andando. Per farlo, però, servono montagne di dati, spesso sottoutilizzati con i metodi tradizionali. Il machine learning, invece, ci permette di processare queste enormi quantità di informazioni, scovando relazioni complesse, sia lineari che non, che a occhio nudo (o con le statistiche classiche) ci sfuggirebbero.
Certo, l’implementazione clinica di questi metodi non è una passeggiata, soprattutto per la disomogeneità e l’incompletezza con cui spesso vengono raccolti i dati. Ma pensate alla diagnostica per immagini: lì il machine learning è già realtà quotidiana, con software che aiutano a refertare e a prendere decisioni cruciali, come l’eleggibilità alla trombectomia. Perché non fare lo stesso per la riabilitazione?
Studi recenti hanno mostrato che i modelli predittivi per la riabilitazione post-ictus spesso mancano di robustezza o di una validazione esterna solida. Molti si fermano a un’analisi biostatistica, con pochi studi prospettici. E poi c’è la questione dei predittori: quali variabili considerare? Spesso ci si concentra su dimensione e localizzazione della lesione, dati della fase acuta e demografici, trascurando il profilo funzionale multidimensionale del paziente che inizia la riabilitazione. Eppure, l’esito della riabilitazione è influenzato da una miriade di fattori: condizioni di salute, comorbilità, funzioni corporee, attività, partecipazione e fattori contestuali. Insomma, un bel groviglio!
La Nostra Ricerca: Un Faro nella Complessità
Con il mio gruppo di ricerca, ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo condotto due studi prospettici consecutivi, coinvolgendo pazienti post-ictus acuto in diverse Unità di Riabilitazione Intensiva (URI) in Italia. Tutti questi centri condividevano un percorso riabilitativo basato sull’evidenza scientifica. Il primo studio, chiamato RIPS (Intensive Rehabilitation Post Stroke), ha incluso una valutazione multidimensionale molto ampia, con dati clinici, funzionali, neurofisiologici e neurogenetici. Il secondo, STRATEGY (Stroke Rehabilitation Registry), si è concentrato su predittori demografici e clinici, inclusi quelli del Protocollo Minimo di Valutazione italiano per i pazienti con ictus.
L’obiettivo? Sviluppare, testare internamente, validare incrociatamente e, soprattutto, validare esternamente un modello prognostico basato sul machine learning. Volevamo usare dati facilmente raccoglibili nella pratica clinica di routine per predire l’esito funzionale globale (misurato con il modified Barthel Index – mBI) alla dimissione dalla riabilitazione intensiva. E, cosa non da poco, volevamo che la soluzione fosse interpretabile, grazie a tecniche come gli Shapley values, per capire davvero cosa “pensa” l’algoritmo.
Abbiamo arruolato prospetticamente pazienti entro 30 giorni dall’ictus, che iniziavano per la prima volta un percorso di riabilitazione intensiva. Abbiamo raccolto dati demografici, sulla descrizione dell’evento, clinico-funzionali e psico-sociali. Alla fine, avevamo 385 pazienti: 220 per il set di addestramento (dallo studio RIPS) e 165 per il set di test esterno (dallo studio STRATEGY). Una buona fetta erano donne (circa il 50-55%) e la maggioranza aveva avuto un ictus ischemico (circa l’80%). L’età media si aggirava sugli 80 anni.

Il percorso riabilitativo era tosto: almeno 3 ore di riabilitazione al giorno, osservazione clinica, gestione infermieristica e fisioterapia. A seconda dei bisogni, si aggiungevano logopedia, terapia occupazionale, supporto psicologico e training per l’uso di ausili. Il piano riabilitativo individuale veniva definito entro 48 ore e rivisto settimanalmente. La dimissione avveniva al raggiungimento degli obiettivi o quando i miglioramenti si stabilizzavano.
Entra in Scena il Machine Learning: Come Funziona?
Abbiamo messo al lavoro ben otto diversi algoritmi di machine learning, dal classico LASSO ai più complessi Support Vector Regression (SVR) e Random Forest. Dopo un’attenta ottimizzazione e validazione interna, l’algoritmo Support Vector Machine (SVR) è emerso come il campione, quello con le migliori performance.
Pensate, questo modello è riuscito a stimare l’mBI alla dimissione con un errore mediano assoluto di circa 11.5 punti nel test interno e, ancora meglio, di 9.2 punti nel test esterno. Non male, vero? Soprattutto se consideriamo che l’mBI va da 0 a 100. La correlazione tra i valori predetti e quelli reali è stata forte, a testimonianza della bontà del modello.
La cosa davvero interessante è che abbiamo usato un approccio che combina la competenza clinica con la potenza dell’analisi automatica. La selezione prospettica dei potenziali predittori, basata su variabili cliniche standardizzate e facilmente raccoglibili, e la definizione di un percorso riabilitativo basato sull’evidenza, pongono le premesse per la generalizzabilità e l’interpretabilità dei nostri risultati. L’uso di tecnologie avanzate ci ha poi permesso di estrarre il massimo delle informazioni dai dati, gestendo i valori mancanti, selezionando solo le informazioni rilevanti e scoprendo pattern nascosti.
Cosa Abbiamo Scoperto? I Segreti Svelati dall’IA
E quali sono state le variabili che, secondo il nostro modello SVR, pesano di più sulla bilancia della prognosi? Eccole qui:
- Il punteggio mBI al momento dell’ammissione: chi parte meglio, tende ad arrivare meglio. Logico, no?
- Il punteggio motorio dell’arto superiore (valutato con scale come Fugl-Meyer o Motricity Index): la funzionalità del braccio è un indicatore chiave.
- L’età del paziente: purtroppo, l’età gioca il suo ruolo.
- Il punteggio allo screening cognitivo (MoCA o MMSE): le capacità cognitive sono strettamente legate al recupero funzionale.
Questi risultati sono in linea con la letteratura precedente, ma il nostro studio aggiunge tasselli importanti. Ad esempio, abbiamo confermato che anche informazioni meno frequentemente raccolte negli studi riabilitativi, come le comorbilità, i marcatori di complessità clinico/riabilitativa (come la presenza di un catetere venoso) e la performance dell’arto inferiore, forniscono un contributo al modello predittivo.
L’analisi dell’interpretabilità, usando le tecniche SHAP, ci ha permesso di “aprire la scatola nera” dell’algoritmo e capire come ogni variabile contribuisce alla predizione per il singolo paziente. Questo è cruciale, perché un medico deve potersi fidare e capire il razionale dietro a una previsione fornita da un software.

Perché è Importante? Oltre i Numeri, la Persona
Qualcuno potrebbe obiettare che predire l’esito alla dimissione ha dei limiti, perché la dimissione stessa può essere influenzata da vincoli di risorse. Tuttavia, predire l’esito a un tempo fisso post-ictus può essere fuorviante, perché influenzato da fattori non legati alla riabilitazione. Noi, invece, volevamo indagare gli effetti di un percorso riabilitativo specifico in un contesto reale.
Rispetto ad altri studi, il nostro modello ha mostrato performance simili o leggermente migliori. Ma il vero valore aggiunto, secondo me, risiede in diversi aspetti:
- Prospetticità: i dati sono stati raccolti appositamente per lo studio, non presi retrospettivamente da cartelle cliniche.
- Validazione Esterna: abbiamo testato il modello su un gruppo di pazienti completamente nuovo e indipendente, proveniente da un altro studio. Questa è la prova del nove per la generalizzabilità.
- Percorso Riabilitativo Standardizzato: tutti i pazienti hanno seguito un percorso basato sull’evidenza, riducendo la variabilità dovuta ai processi di cura.
- Completezza dei Predittori: abbiamo incluso un set ampio di variabili, coprendo diverse dimensioni del funzionamento secondo la classificazione ICF dell’OMS.
- Interpretabilità: abbiamo fatto uno sforzo per rendere il modello comprensibile.
Pensate alle implicazioni: una stima accurata del livello funzionale che un paziente raggiungerà al termine della riabilitazione fornisce informazioni cruciali per pianificare l’assistenza post-dimissione, ottimizzare l’allocazione delle risorse e facilitare la continuità assistenziale. Nonostante l’età avanzata e un certo grado di disabilità residua, la stragrande maggioranza dei nostri pazienti (310) è tornata a casa, e questo è un dato che conforta.
Limiti e Prospettive Future: La Scienza è un Viaggio Continuo
Certo, come ogni studio, anche il nostro ha dei limiti. Ad esempio, la procedura di conversione di alcune scale tra i due dataset (RIPS e STRATEGY) potrebbe aver introdotto piccole imprecisioni, anche se abbiamo cercato di minimizzarle basandoci su dati normativi o sulla somiglianza dei costrutti misurati. Inoltre, parte del periodo di osservazione è coinciso con la pandemia di COVID-19, ma abbiamo verificato che le caratteristiche dei pazienti non sono cambiate significativamente.
In futuro, potremmo migliorare ulteriormente l’accuratezza includendo dati su eventi avversi intercorrenti, altri predittori clinici emergenti dalla letteratura, o magari dati di neuroimaging, a patto che siano facilmente raccoglibili nella maggior parte dei contesti riabilitativi. La validazione su altre coorti indipendenti sarà un altro passo importante.
Un Passo Avanti per una Riabilitazione Su Misura
Nonostante tutto, i nostri risultati aggiungono informazioni rilevanti allo stato dell’arte. Abbiamo ottenuto il primo modello prognostico basato su ML, raccolto prospetticamente, validato esternamente e interpretabile, per stimare accuratamente lo stato funzionale globale dei pazienti post-ictus acuto alla dimissione da una riabilitazione intensiva erogata secondo un percorso basato sull’evidenza.
Questa soluzione può davvero supportare la formulazione di una prognosi funzionale al momento dell’ammissione, favorendo un’identificazione tempestiva delle caratteristiche che potrebbero predire un esito sfavorevole e, quindi, permettendo di personalizzare ancora di più il percorso riabilitativo. La strada verso una medicina davvero personalizzata nell’ambito della riabilitazione post-ictus è ancora lunga, ma credo che abbiamo fatto un bel passo avanti. E la cosa più bella è che i predittori chiave sono variabili cliniche raccomandate e raccolte in tutto il mondo, il che pone solide premesse per un’applicabilità del nostro modello su scala internazionale.
Insomma, l’intelligenza artificiale non sostituirà medici e terapisti, ma può diventare uno strumento potentissimo nelle loro mani per prendere decisioni più informate e, in ultima analisi, per migliorare la vita dei pazienti. E questo, per chi fa il mio mestiere, è ciò che conta di più.
Fonte: Springer