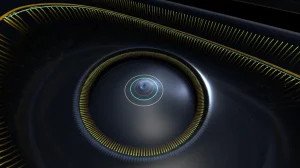Anche la Matematica ha i suoi Pregiudizi Nascosti: Scopriamoli Insieme
Ciao a tutti! Oggi voglio parlarvi di qualcosa che potrebbe sorprendervi. Pensiamo spesso alla matematica come al regno della logica pura, dell’oggettività cristallina, un mondo dove 2+2 fa sempre 4 e non c’è spazio per opinioni o… pregiudizi. Vero? Beh, forse non del tutto. E se vi dicessi che anche in questo tempio della razionalità si insinuano sottili influenze sociali, stereotipi e bias che possono condizionare chi fa matematica e come la fa?
Sembra strano, lo so. Ma negli ultimi anni, diversi studi hanno iniziato a mettere in discussione l’idea di una matematica totalmente “libera da valori”. Per capire come sia possibile, oggi ci faremo aiutare da un concetto filosofico affascinante: l’epistemologia dei cardini (in inglese, hinge epistemology), ispirata dal filosofo Ludwig Wittgenstein. Pronti a scardinare qualche certezza?
Cosa sono questi “Cardini”?
Immaginate una porta. Per poterla aprire e chiudere, i suoi cardini devono rimanere fissi, stabili. Non mettiamo in dubbio i cardini ogni volta che usiamo la porta, giusto? Ecco, Wittgenstein suggerisce che anche la nostra conoscenza e le nostre pratiche epistemiche (cioè i modi in cui giustifichiamo, dubitiamo, scopriamo) funzionano grazie a dei “cardini”: presupposti fondamentali che diamo per scontati, che non mettiamo in dubbio, perché farlo bloccherebbe tutto.
Facciamo un esempio semplice. Se vi chiedo se c’è uno schermo di computer davanti a voi mentre leggete, probabilmente userete la vostra vista per rispondere. Per farlo, implicitamente accettate un “cardine”: che i vostri sensi (in questo caso, la vista) siano generalmente affidabili per darvi informazioni sul mondo. Mettere in dubbio questo cardine continuamente sarebbe paralizzante! Non potremmo fidarci di quasi nulla.
Questi cardini, quindi, sono:
- Presupposti fondamentali per un certo ambito di indagine o pratica.
- Generalmente esenti da dubbio nel contesto in cui operano.
- Rendono possibili le nostre operazioni epistemiche (giudicare, giustificare, ecc.).
I Cardini nel Mondo della Matematica
E in matematica? Anche qui ci sono dei cardini. Pensate agli assiomi, come quelli della geometria euclidea (tipo “il tutto è maggiore della parte”). Sono punti di partenza accettati senza dimostrazione, che permettono di costruire interi sistemi matematici. Ma non solo gli assiomi! Anche regole più basilari, come quelle dell’aritmetica, possono funzionare da cardini.
Wittgenstein parla di un processo chiamato “pietrificazione“. Immaginate di mettere insieme due mele e altre due mele più volte. L’osservazione ripetuta che il risultato è sempre quattro mele fa sì che l’affermazione empirica “2+2 fa 4” si “pietrifichi”, diventi una regola matematica normativa. Se contando trovassimo 3 mele, non diremmo che 2+2 fa 3, ma che abbiamo perso una mela! La regola matematica ora regola la nostra esperienza, non viceversa.
Interessante, vero? Ma c’è di più. Lo status di una proposizione matematica (se è un cardine o meno) non è fisso, ma dipende dal contesto. L’assioma delle rette parallele è un cardine nella geometria euclidea, ma non in quella non-euclidea. Questo significa che la matematica non è un blocco monolitico, ma un’attività dinamica e contestuale.

Un esempio storico affascinante è la congettura di Eulero sui poliedri (vertici – spigoli + facce = 2). All’inizio era una regolarità osservata contando. Poi si è “pietrificata”. Quando Lakatos presentò dei “controesempi”, invece di abbandonare la congettura, la comunità matematica ridefinì cosa contasse come “poliedro” per salvarla! In parte, questo accadde anche grazie all’enorme credibilità e reputazione di Eulero. Vedete? Già qui entra in gioco un fattore “sociale”: la credibilità del matematico.
Quando la Società Entra nell’Equazione
Ed eccoci al punto cruciale. Se la credibilità di un matematico può influenzare come viene accolta una sua idea, cosa succede quando questa credibilità (o la sua mancanza) è influenzata da fattori sociali come genere, etnia, classe sociale, anzianità accademica o affiliazione istituzionale?
Recenti ricerche (citate nel testo originale) evidenziano come questi aspetti giochino un ruolo non solo nell’accesso alla carriera matematica, ma anche nella produzione stessa della conoscenza. Chi decide quali argomenti sono “interessanti” o degni di essere pubblicati? Il lavoro di chi viene preso più sul serio? Qui entrano in gioco i bias impliciti, spesso inconsci.
Per analizzare questo fenomeno, torniamo ai nostri cardini, ma applicandoli a un contesto specifico: la testimonianza e la credibilità.
Cardini Pregiudiziali: L’Ingiustizia Epistemica
Avete mai avuto la sensazione di non essere creduti non per quello che dicevate, ma per chi eravate? Questa è la base dell’ingiustizia testimoniale, un concetto introdotto da Miranda Fricker. Si verifica quando a una persona viene attribuita ingiustamente poca credibilità a causa di pregiudizi legati alla sua identità sociale (razza, genere, ecc.).
La filosofa Andrea Boncompagni ha proposto di interpretare questi pregiudizi come dei “cardini pregiudiziali“. Funzionano proprio come i cardini di Wittgenstein:
- Sono presupposti di fondo (spesso ingiustificati) su certi gruppi sociali.
- Sono resistenti alle prove contrarie (è la natura del pregiudizio!).
- Regolano i nostri giudizi e comportamenti, in questo caso, stabilendo (ingiustamente) chi è degno di fiducia e chi no.
Questi cardini pregiudiziali non agiscono come un dubbio che sorge *dopo* aver ascoltato qualcuno. No, agiscono *prima*, come un cancello chiuso. Precludono la possibilità stessa di considerare quella persona come una fonte affidabile di informazione, screditandola alla fonte (source discrediting). Bloccano sul nascere la giustificazione che potremmo ottenere dalla sua testimonianza.
Non Solo Pregiudizi: I Cardini Stereotipati (Positivi?)
Ma attenzione, non ci sono solo i pregiudizi negativi. Esistono anche gli stereotipi positivi, associazioni diffuse tra un gruppo sociale e attributi considerati positivi (es. “gli asiatici sono bravi in matematica”). Anche questi possono funzionare come cardini, influenzando la nostra valutazione della credibilità.
Possiamo chiamarli “Cardini Stereotipati Testimoniali” (ST-Hinge). Anch’essi agiscono per preclusione, ma in senso opposto: accreditano la fonte (source crediting) basandosi sull’appartenenza a un gruppo. “Mi fido di te *perché* appartieni al gruppo Y”.
Ora, la cosa si fa interessante. Questi ST-Hinge possono essere:
- Affidabili (Reliable-ST-hinge): Basati su generalizzazioni empiriche solide e usati giustamente. Esempio: fidarsi di un fisico quantistico per un calcolo matematico complesso è ragionevole, data la formazione tipica in quel campo.
- Inaffidabili (Unreliable-ST-hinge): Basati su stereotipi inaccurati o usati ingiustamente, portando a un eccesso di credibilità. Esempio: lo stereotipo che gli uomini bianchi siano intrinsecamente più affidabili come informatori. Questo può portare a dare loro credito anche quando non lo meritano, commettendo un’ingiustizia epistemica al contrario. Spesso, questi stereotipi “positivi” nascondono un lato negativo (es. donne “calde” ma “meno competenti”).

Il “Dirottamento della Certificazione” in Matematica
Ok, abbiamo cardini matematici (pietrificazione) e cardini sociali (pregiudizi e stereotipi sulla credibilità). Come si incontrano nel mondo reale della matematica?
Qui entra in gioco il concetto di “certificazione“. La conoscenza matematica, specialmente le dimostrazioni, non nasce perfetta. Viene proposta, discussa, criticata, raffinata dalla comunità. Questo processo dialogico (descritto da modelli come “Proponente-Critico” o “Prover-Skeptic”) porta a una sorta di “bollino di fiducia” o certificazione. Più una dimostrazione resiste alle critiche e ai controlli, più viene considerata affidabile e meno messa in dubbio.
Questo processo è influenzato da fattori legittimi. Ad esempio, il lavoro di matematici senior o con una solida reputazione (basata su successi passati, una regolarità di buone performance) tende ad attrarre più attenzione, più “collaborazione avversaria” (critiche costruttive) e quindi raggiunge un grado di certificazione più alto. Questo è basato su una sorta di “ST-Hinge affidabile”: ci fidiamo di più perché c’è una storia di affidabilità.
Ma ecco il problema: questo processo di certificazione può essere “dirottato” (hijacked) dai cardini sociali illegittimi.
- Un cardine pregiudiziale contro il proponente (basato su genere, etnia, ecc.) può portare a una sottocertificazione: il suo lavoro viene ignorato, scrutato con eccessivo sospetto, o gli viene data meno credibilità di quanta ne meriti, senza basi reali.
- Un ST-Hinge inaffidabile a favore del proponente può portare a una sovracertificazione: il suo lavoro viene accettato troppo acriticamente, magari sorvolando su errori o debolezze, solo per via di uno stereotipo positivo non giustificato.
Questi meccanismi operano all’interno di quella che l’articolo originale chiama una “economia della credibilità“, dove fattori interni alla matematica (la forza logica, la “pietrificazione” di certi risultati) e fattori esterni (reputazione, bias, stereotipi) si mescolano e interagiscono nel determinare lo status (e il destino) di un’idea matematica.
Perché è Difficile Accorgersene?
Questa influenza dei bias è spesso subdola e difficile da smascherare in matematica, per vari motivi:
- Forza dei cardini matematici: Risultati molto “pietrificati” (come 2+2=4) sono così solidi che l’influenza dei bias sulla loro accettazione è minima. L’effetto dei bias è più probabile in aree di ricerca nuove, complesse o più “aperte”.
- Opacità e indeterminatezza: Le pratiche matematiche hanno margini di “apertura” (scelta di definizioni, valutazione dell’eleganza o rilevanza). È difficile stabilire uno standard puramente “interno” per giudicare se una valutazione sia stata influenzata da bias esterni o sia una legittima scelta matematica.
- Percezione di neutralità: La matematica gode di un’aura di oggettività che rende difficile accettare (e quindi vedere) l’influenza di fattori sociali.
- Pratiche di peer review: Nel mondo della matematica, la revisione tra pari spesso non è anonima (specialmente con la pre-pubblicazione su piattaforme come arXiv), rendendo più facile l’attivazione (conscia o inconscia) di bias legati all’identità dell’autore. Inoltre, le prime valutazioni si basano spesso su “opinioni rapide” di esperti sull’interesse del lavoro, più che sulla correttezza dettagliata.

Cosa Possiamo Imparare?
Quindi, la matematica non è un’isola felice completamente isolata dalle dinamiche sociali. L’epistemologia dei cardini ci offre una lente potente per capire *come* i pregiudizi e gli stereotipi possano infiltrarsi e operare, non come semplici “errori” superficiali, ma come elementi che strutturano (o destrutturano) la credibilità e la certificazione della conoscenza matematica stessa.
Riconoscere questo meccanismo è il primo passo. Capire come fattori intra-matematici ed extra-matematici interagiscono in questa “economia della credibilità” può aiutarci a sviluppare strategie più efficaci per contrastare l’ingiustizia epistemica all’interno della comunità matematica e per ridurre i danni che questi bias possono causare alla disciplina stessa.
Non si tratta di sminuire la matematica, ma di comprenderla più a fondo, nella sua complessa realtà umana e sociale. Un compito non facile, ma necessario per una scienza più giusta ed equa.
Fonte: Springer