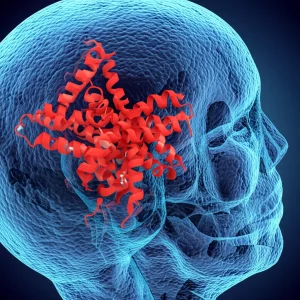Scoperta Scientifica: 4 Miti da Sfatare (con l’Alzheimer come Guida)
Ciao a tutti! Parliamoci chiaro, quando pensiamo a una scoperta scientifica, spesso ci vengono in mente immagini un po’ stereotipate: il lampo di genio improvviso, l’entità nuova di zecca perfettamente definita, la “verità” assoluta che emerge dal nulla. Ma siamo sicuri che le cose stiano davvero così? Io credo di no, e oggi voglio accompagnarvi in un viaggio per smontare quattro pregiudizi piuttosto radicati sulla scoperta scientifica, usando come bussola un caso che, purtroppo, molti conoscono da vicino: la malattia di Alzheimer.
Vedrete, la realtà della ricerca è molto più sfumata, complessa e, se vogliamo, affascinante di quanto si pensi. Pronti a mettere in discussione qualche certezza? Via!
Pregiudizio #1: La Scoperta è Irrazionale, Roba da Filosofi Annoiati?
Per un sacco di tempo, diciamocelo, la filosofia della scienza ha snobbato un po’ il momento della scoperta. L’idea dominante, influenzata da pensatori come Popper, era che la scoperta fosse un guizzo creativo, quasi un’illuminazione mistica, impossibile da analizzare logicamente. Tutta l’attenzione era sul “contesto della giustificazione”, cioè su come le teorie venivano testate e validate *dopo* essere state formulate. Il “come” si arrivasse a quella formulazione? Roba da psicologi, o al massimo da biografi curiosi, non certo materiale per un’analisi rigorosa.
Ma siamo sicuri che sia così netta la separazione? Già negli anni ’60, gente come Norwood R. Hanson ci ha mostrato, analizzando il lavoro di Keplero sulla traiettoria di Marte, che il processo di scoperta è intriso di ragionamento, di inferenze (spesso abduttive, cioè alla ricerca della spiegazione migliore), di tentativi ed errori guidati da una logica. Come ha sottolineato Hoyningen-Huene, chi scopre qualcosa acquisisce nuova conoscenza, e per farlo deve avere delle giustificazioni, deve costruire un percorso razionale.
Insomma, la distinzione tra “scoperta” e “giustificazione” non è un muro invalicabile. Sono due facce della stessa medaglia, un processo continuo in cui il pensiero creativo si intreccia con l’argomentazione e la validazione. Quindi, no, la scoperta non è affatto un terreno off-limits per l’analisi filosofica; anzi, è un campo ricchissimo di spunti!
Pregiudizio #2: Le Scoperte Rivelano Entità dai Contorni Perfetti
Altro mito duro a morire: quando si scopre qualcosa di nuovo (una particella, una malattia, una specie), questa “cosa” deve avere confini chiari, criteri di identificazione netti, necessari e sufficienti. Deve essere un pacchetto ben definito, distinguibile senza ambiguità da tutto il resto. Bello, eh? Peccato che la realtà, specialmente nelle scienze della vita e in medicina, sia spesso molto più “sfumata”.
Prendiamo proprio l’Alzheimer. Quando Alois Alzheimer, nel 1906, descrisse il caso di Auguste Deter, una donna di 51 anni con una grave e rapida demenza, notò nel suo cervello, post-mortem, placche proteiche e grovigli neurofibrillari. Sembrava l’identikit di una nuova malattia, no? Eppure, come hanno fatto notare critici come Lock, né le placche né i grovigli erano scoperte inedite (erano già associate alla demenza senile) e, soprattutto, non erano criteri infallibili.

Lo stesso Alzheimer riportò poi il caso di Johann Feigl, con sintomi simili ma solo placche, senza grovigli. E che dire del famoso “Nun’s study”, lo studio sulle suore, dove alcune religiose mostravano cervelli pieni di placche e grovigli pur non avendo sintomi clinici di demenza? Capite bene che i confini non erano (e per certi versi non sono ancora oggi) così netti.
Questo significa che Alzheimer non ha scoperto nulla? Assolutamente no! Quello che Alzheimer e i suoi colleghi (come Perusini) hanno fatto è stato mettere insieme i pezzi di un puzzle in modo nuovo. Hanno ipotizzato un processo patologico specifico, diverso dalla semplice senilità, che collegava certi sintomi clinici (soprattutto se a esordio precoce, “presenile”) a specifiche alterazioni cerebrali. Non era una categoria diagnostica chiusa e definita, ma piuttosto, come suggerisce Keuck, una “categoria esplorativa”: un punto di partenza per indagare ulteriormente, per capire meglio i confini tra diverse forme di demenza. Molte malattie, specialmente quelle psichiatriche o complesse, sono multifattoriali, influenzate da genetica, ambiente, stile di vita… aspettarsi confini taglienti come rasoi è semplicemente irrealistico. La scoperta, in questi casi, non è trovare una scatola sigillata, ma aprire una porta su un territorio ancora in parte inesplorato.
Pregiudizio #3: Parlare di Scoperta = Essere Realisti Convinti
Questo pregiudizio è strettamente legato al precedente. Se una cosa scoperta non ha confini netti, se la sua definizione cambia nel tempo, allora forse non è una “cosa” reale, indipendente da noi, ma più una nostra “invenzione”, una categoria comoda che abbiamo creato. L’idea è che il termine “scoperta” implichi necessariamente un impegno realista: si scopre qualcosa che esiste “là fuori”, oggettivamente. Se dubitiamo di questa esistenza oggettiva, allora dovremmo parlare di “invenzione” o “costruzione”.
Autori come Berrios, ad esempio, hanno usato proprio il caso dell’Alzheimer per sostenere una visione più “costruttivista” delle malattie: le definizioni cambiano, i confini sono negoziati dalla comunità scientifica, non esiste una descrizione “finale”. Ma attenzione, questo è un salto logico un po’ affrettato. Il fatto che i nostri concetti scientifici evolvano, che le definizioni si affinino (o cambino), che ci siano dibattiti e persino influenze sociali nel processo, non implica automaticamente che l’oggetto di studio non abbia una sua realtà indipendente.
Possiamo benissimo parlare della scoperta di Alzheimer nel senso che Alzheimer e altri hanno identificato una connessione significativa tra un certo quadro clinico e certe alterazioni neuropatologiche, avviando un programma di ricerca fecondo. Possiamo riconoscere che il concetto di “malattia di Alzheimer” si è dimostrato utile, potente dal punto di vista esplicativo e predittivo (virtù pragmatiche e cognitive), senza per forza doverci pronunciare sulla sua “essenza” ultima come entità metafisica perfettamente definita. Come suggerisce Arabatzis parlando dell’elettrone, la scoperta può essere vista come un’attività costruttiva i cui risultati *possono*, ma non *devono* necessariamente, essere interpretati in chiave realista forte. Un anti-realista potrebbe dire che abbiamo scoperto dei fatti oggettivi sull’utilità e l’adeguatezza del concetto di Alzheimer, senza impegnarsi sull’esistenza della “malattia” come entità a sé stante. La parola “scoperta” non ci obbliga a indossare gli occhiali del realismo a tutti i costi.
Pregiudizio #4: La Scoperta è un Attimo Fuggente
Eccoci all’ultimo mito, forse il più cinematografico: la scoperta come evento puntiforme, l’Eureka! urlato nella vasca da bagno. Thomas Kuhn aveva già messo in discussione questa idea per le scoperte che rompevano un paradigma scientifico esistente (come la scoperta dei quanti di Planck), sostenendo che il loro pieno significato emergesse solo gradualmente. Ma io credo che questa visione della scoperta come processo esteso nel tempo sia valida anche in casi, come quello dell’Alzheimer, dove non c’era un paradigma dominante preesistente da scardinare.

La storia dell’Alzheimer è emblematica. Dopo le prime osservazioni di Alzheimer e Perusini, la comprensione della malattia si è evoluta enormemente. Pensiamo alla distinzione sempre più sfumata tra forme presenili e senili, alla scoperta dei fattori genetici (come il gene APOE o le mutazioni nei geni APP e Presenilina, spesso legate all’esordio precoce), allo sviluppo di biomarcatori per la diagnosi… Ogni passo ha aggiunto conoscenza, ha modificato e arricchito il concetto iniziale. L’oggetto della scoperta non era un’entità fissa data una volta per tutte, ma un “bersaglio mobile” (“moving target”), la cui comprensione si è approfondita (e continua ad approfondirsi) nel tempo.
Ma allora, sorge spontanea la domanda: se la scoperta è un processo, chi è “lo scopritore”? Chi ha scoperto l’Alzheimer? La risposta, un po’ come per l’elettrone (scoperto da Thomson? O da Lorentz, Zeeman, Larmor?), non è quasi mai una sola persona. Alzheimer ha avuto il merito fondamentale di identificare una connessione chiave e di fornire un punto di partenza stabile, un “marchio” identificativo (il legame clinico-patologico) che è rimasto significativo nonostante tutte le evoluzioni successive. Ma la “scoperta”, nel senso pieno del processo di comprensione e consolidamento della conoscenza, è stata un’impresa collettiva e continua. Dobbiamo abbandonare l’idea romantica dello scopritore solitario e abbracciare una visione più corale e dinamica della ricerca scientifica.
Tirando le Somme: Un Nuovo Ritratto della Scoperta
Cosa ci portiamo a casa da questo viaggio con l’Alzheimer come guida? Che i quattro pregiudizi da cui siamo partiti ci danno un’immagine distorta e troppo semplificata di come funziona davvero la scienza.
- La scoperta non è irrazionale, ma un processo intriso di logica e argomentazione.
- Le entità scoperte non hanno sempre confini netti fin dall’inizio; spesso emergono come categorie esplorative.
- Parlare di scoperta non obbliga a un realismo ingenuo; si può scoprire l’utilità di un concetto o una connessione significativa.
- La scoperta non è quasi mai un evento istantaneo, ma un processo esteso nel tempo, un accumulo graduale di conoscenza su un bersaglio a volte mobile.
Certo, questo è solo un caso di studio, e non tutte le scoperte seguiranno esattamente questo schema. Ma l’esempio dell’Alzheimer ci aiuta a capire che la scienza è un’avventura molto più complessa, sfumata e affascinante di un semplice “Eureka!”. È un film in continua evoluzione, non una fotografia istantanea. E forse, capirlo meglio ci aiuta anche ad apprezzare di più lo sforzo, la pazienza e l’intelligenza collettiva che stanno dietro ogni passo avanti della conoscenza.
Fonte: Springer