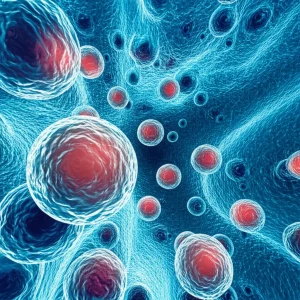Liquefazione del Suolo? Ora l’Intelligenza Artificiale ci Avvisa (con una Precisione Pazzesca!)
Ciao a tutti! Oggi voglio parlarvi di qualcosa che mi affascina da sempre e che, purtroppo, è un bel grattacapo in molte zone del mondo: la liquefazione del suolo. Immaginate il terreno sotto i vostri piedi che, durante un terremoto, perde improvvisamente la sua solidità e si comporta quasi come un liquido. Un incubo, vero? Questo fenomeno è responsabile di danni enormi a edifici, strade, ponti… insomma, a tutto ciò che ci sta sopra.
Prevedere dove e quando la liquefazione potrebbe colpire è una sfida enorme per noi ingegneri e geologi. Le interazioni tra il tipo di terreno, l’acqua presente, le sollecitazioni sismiche… sono incredibilmente complesse e non lineari. È un puzzle difficile da risolvere.
La Sfida della Previsione: Perché i Metodi Tradizionali Hanno dei Limiti
Per decenni ci siamo affidati a metodi, diciamo, “classici”. Avete presente la famosa prova penetrometrica standard (SPT)? Ecco, quella è una delle basi. Si misura la resistenza del terreno alla penetrazione di uno strumento e, insieme ad altri dati (come il livello della falda acquifera, le caratteristiche del terremoto atteso), si cerca di stimare il rischio. Questi metodi, sviluppati a partire dagli anni ’60 e ’70 dopo eventi disastrosi come i terremoti di Niigata (Giappone) e dell’Alaska, sono stati fondamentali.
Nel tempo sono stati affinati, integrando dati da altre prove come la CPT (Cone Penetration Test) o misure di velocità delle onde di taglio (Vs), e sono state introdotte anche analisi probabilistiche per gestire meglio le incertezze. Però, diciamocelo, questi approcci hanno dei limiti:
- Sono spesso semi-empirici, basati su osservazioni passate che potrebbero non valere ovunque.
- Sono molto legati alla regione specifica per cui sono stati sviluppati.
- La strumentazione e le procedure di prova possono variare, introducendo incertezze.
Insomma, serviva qualcosa di più potente, di più adattabile. E qui entra in gioco la mia passione: l’intelligenza artificiale (AI) e il machine learning (ML).
L’Intelligenza Artificiale Scende in Campo
L’idea di usare l’AI per prevedere la liquefazione non è nuovissima. Già negli anni ’90 si sperimentava con le reti neurali (NN). Poi sono arrivate le Support Vector Machines (SVM), gli alberi decisionali (DT), e modelli più recenti e performanti come XGBoost, Random Forest (RF) e Gradient Boosting (GB).
Questi algoritmi sono bravissimi a scovare pattern complessi nascosti nei dati, proprio quello che serve per un fenomeno non lineare come la liquefazione. Molti studi hanno dimostrato che l’ML può superare i metodi tradizionali, usando dati da SPT, CPT o Vs.
Però, anche qui, c’erano delle sfide. Spesso i dataset usati sono sbilanciati (molti più casi di non-liquefazione che di liquefazione, o viceversa), il che può portare i modelli a “imparare male” (overfitting). Inoltre, molti studi si concentravano su un singolo algoritmo ML o su ensemble specifici (come quelli basati su alberi decisionali), che magari funzionavano benissimo su quel particolare set di dati, ma non erano generalizzabili.

La Nostra Idea: L’Unione Fa la Forza con SVEC!
Ed è qui che entra in gioco il nostro lavoro. Ci siamo detti: perché affidarsi a un solo “esperto” (un singolo algoritmo ML) quando possiamo creare un “comitato di esperti” che lavora insieme? L’idea alla base è quella degli ensemble methods: combinare le previsioni di diversi modelli per ottenere un risultato finale più robusto e accurato.
Abbiamo sviluppato quello che abbiamo chiamato Soft Voting Ensemble Classifier (SVEC). Immaginate tre algoritmi molto bravi, ma con approcci leggermente diversi:
- CatBoost Classifier (CBC): Fortissimo nel gestire dati categorici e numerici insieme, e bravo a evitare l’overfitting.
- Random Forest Classifier (RFC): Un classico degli ensemble, crea tanti alberi decisionali e li fa “votare”. È robusto al rumore nei dati.
- Gradient Boost Classifiers (GBC): Costruisce modelli in sequenza, dove ogni nuovo modello cerca di correggere gli errori del precedente. Molto accurato.
Il nostro SVEC non fa una semplice “votazione a maggioranza” (hard voting), ma usa un approccio più sfumato, il “soft voting”. Ogni modello non dice solo “liquefazione sì” o “liquefazione no”, ma esprime una probabilità (ad esempio, “sono sicuro al 90% che ci sarà liquefazione”). Lo SVEC combina queste probabilità pesate e prende la decisione finale basata sulla probabilità aggregata più alta. Questo approccio permette di bilanciare i punti di forza di ciascun modello, riducendo il rischio di errori e migliorando la capacità di generalizzare, cioè di funzionare bene anche su dati mai visti prima.
Il Banco di Prova: Dati dal Terremoto di Chi-Chi e Oltre
Per addestrare e testare il nostro SVEC, avevamo bisogno di dati solidi. Abbiamo messo insieme un dataset di 540 casi basati su prove SPT. La maggior parte (488 casi) proviene dalle aree colpite dal devastante terremoto di Chi-Chi a Taiwan nel 1999, un evento che ha causato estesa liquefazione. Abbiamo aggiunto anche casi dal terremoto di Meinong del 2016 (sempre a Taiwan) e 31 casi dal Giappone, per avere una maggiore diversità.
Il bello di questo dataset è che era perfettamente bilanciato: 270 casi di liquefazione osservata e 270 casi di non-liquefazione. Per ogni caso, avevamo 8 parametri chiave (le nostre “features” di input):
- Profondità (Depth)
- Valore SPT-N60 (resistenza del terreno corretta)
- Contenuto di Fini (FC – la percentuale di sabbia fine e limo)
- Livello della Falda Acquifera (GWT)
- Tensioni Efficaci del Terreno di Copertura (ESO)
- Tensioni Totali del Terreno di Copertura (TSO)
- Magnitudo del Terremoto (Mw)
- Accelerazione di Picco al Suolo (PGA – l’intensità dello scuotimento)
Abbiamo preparato i dati con cura, gestendo eventuali valori mancanti e assicurandoci che fossero pronti per essere “digeriti” dai nostri modelli ML. Abbiamo diviso il dataset: 70% per l’addestramento (e qui abbiamo usato una tecnica chiamata SMOTE per essere sicuri che il bilanciamento tra classi fosse mantenuto anche nei sotto-campioni) e 30% per il test finale, per vedere come se la cavava il modello su dati completamente nuovi.

Risultati da Urlo: Precisione Quasi Perfetta!
E ora, il momento della verità! Abbiamo messo alla prova il nostro SVEC e lo abbiamo confrontato con i singoli modelli che lo compongono (CBC, RFC, GBC) e anche con un altro algoritmo potente, XGBoost (XGBC). I risultati sono stati davvero entusiasmanti.
Sul dataset di test, il nostro SVEC ha raggiunto un’accuratezza del 99.38%! Praticamente perfetto. Ha superato tutti i modelli individuali (che comunque si sono comportati molto bene, con accuratezze tra il 98.14% e il 98.76%). Questo dimostra che combinare i modelli nel modo giusto porta davvero a un miglioramento.
Ma l’accuratezza non è tutto, specialmente quando si parla di rischi. Bisogna essere sicuri di non “mancare” nessun caso di liquefazione reale (alta “recall” o sensibilità) e di non dare falsi allarmi (alta “precisione”). Anche qui, lo SVEC ha brillato:
- Recall: 100% sia per i casi di non-liquefazione che per quelli di liquefazione! Non ha mancato neanche un caso.
- Precisione: 99% per la non-liquefazione e 100% per la liquefazione. Pochissimi falsi allarmi.
L’F1-score, che è una media armonica di precisione e recall, è risultato pari a 0.99 per entrambe le classi, confermando un bilanciamento eccezionale. Abbiamo anche usato la validazione incrociata a 10 fold (un metodo rigoroso per testare la robustezza del modello dividendolo in 10 parti e testandolo a rotazione) e le curve Precisione-Recall (PR), che hanno confermato le prestazioni stellari dello SVEC, con un’area sotto la curva (AUC) pari a 1.00 (il massimo possibile!).
Capire il “Perché”: L’Importanza delle Variabili con SHAP
Ok, il modello è accuratissimo, ma *perché* funziona? Quali sono i fattori che “pesano” di più nelle sue decisioni? Qui entra in gioco un’altra tecnica fantastica chiamata SHAP (Shapley Additive Explanations). Derivata dalla teoria dei giochi, ci permette di capire il contributo di ogni singola variabile di input alla previsione finale per ogni singolo caso.
L’analisi SHAP ci ha confermato quello che, in fondo, l’ingegneria geotecnica ci dice da tempo, ma quantificandolo in modo preciso per il nostro modello:
- PGA (Accelerazione di Picco al Suolo): È il fattore più influente in assoluto. Più forte è lo scuotimento, maggiore è la probabilità di liquefazione. Logico, no?
- SPT-N60 (Resistenza del terreno): Il secondo fattore chiave. Terreni meno resistenti (N60 basso) sono molto più suscettibili.
- GWT (Falda Acquifera): Importantissima. Una falda superficiale aumenta drasticamente il rischio.
- FC (Contenuto di Fini): Anche questo ha un peso significativo, in linea con le conoscenze geotecniche (certi contenuti di fini rendono il terreno più liquefacibile).
Profondità (Depth) e Tensioni Efficaci (ESO) hanno un ruolo secondario ma comunque rilevante, mentre Magnitudo (Mw) e Tensioni Totali (TSO) sono risultati meno influenti *nel contesto decisionale del nostro modello specifico*, probabilmente perché i loro effetti sono già catturati indirettamente da PGA e N60/ESO.
Questa analisi SHAP non solo ci dà fiducia nel modello (le sue decisioni sono basate su principi fisicamente sensati), ma apre anche la porta a una migliore comprensione del fenomeno stesso e a future ricerche mirate.

Guardando Avanti: Potenzialità e Prossimi Passi
Il nostro studio dimostra che l’approccio ensemble SVEC è potentissimo per prevedere la liquefazione basandosi su dati SPT. L’accuratezza del 99.38% è un risultato notevole che potrebbe avere implicazioni pratiche importanti per la valutazione del rischio sismico e la pianificazione territoriale.
Certo, siamo consapevoli dei limiti. Il nostro modello è stato addestrato principalmente su dati di una specifica regione (Taiwan) e di specifici terremoti. La sua generalizzabilità ad altre aree con condizioni geotecniche molto diverse (ad esempio, terreni con altissimo contenuto di argilla) o diversa sismicità andrà verificata.
Per questo, i prossimi passi sono chiari:
- Testare lo SVEC su dataset indipendenti provenienti da altre regioni del mondo.
- Espandere il dataset includendo più variabili geotecniche e sismiche, se disponibili.
- Esplorare tecniche di “transfer learning” per adattare il modello a nuove regioni con meno dati specifici.
- Confrontare lo SVEC con approcci di deep learning (come reti neurali profonde) man mano che dataset più grandi diventano disponibili, valutando il trade-off tra accuratezza e interpretabilità.
Implementare questi modelli per previsioni in tempo reale durante un evento sismico presenta sfide aggiuntive (disponibilità dei dati, velocità di calcolo), ma è una direzione affascinante.
In conclusione, credo fermamente che l’unione tra conoscenza geotecnica e potenza del machine learning, specialmente con approcci ensemble interpretabili come il nostro SVEC, sia la strada giusta per affrontare sfide complesse come la previsione della liquefazione. Abbiamo fatto un passo avanti importante, fornendo uno strumento che non solo è incredibilmente accurato, ma ci aiuta anche a capire meglio i “perché” dietro a questo fenomeno così pericoloso. E questo, per me, è il vero cuore della scienza e dell’ingegneria: capire per proteggere.
Fonte: Springer