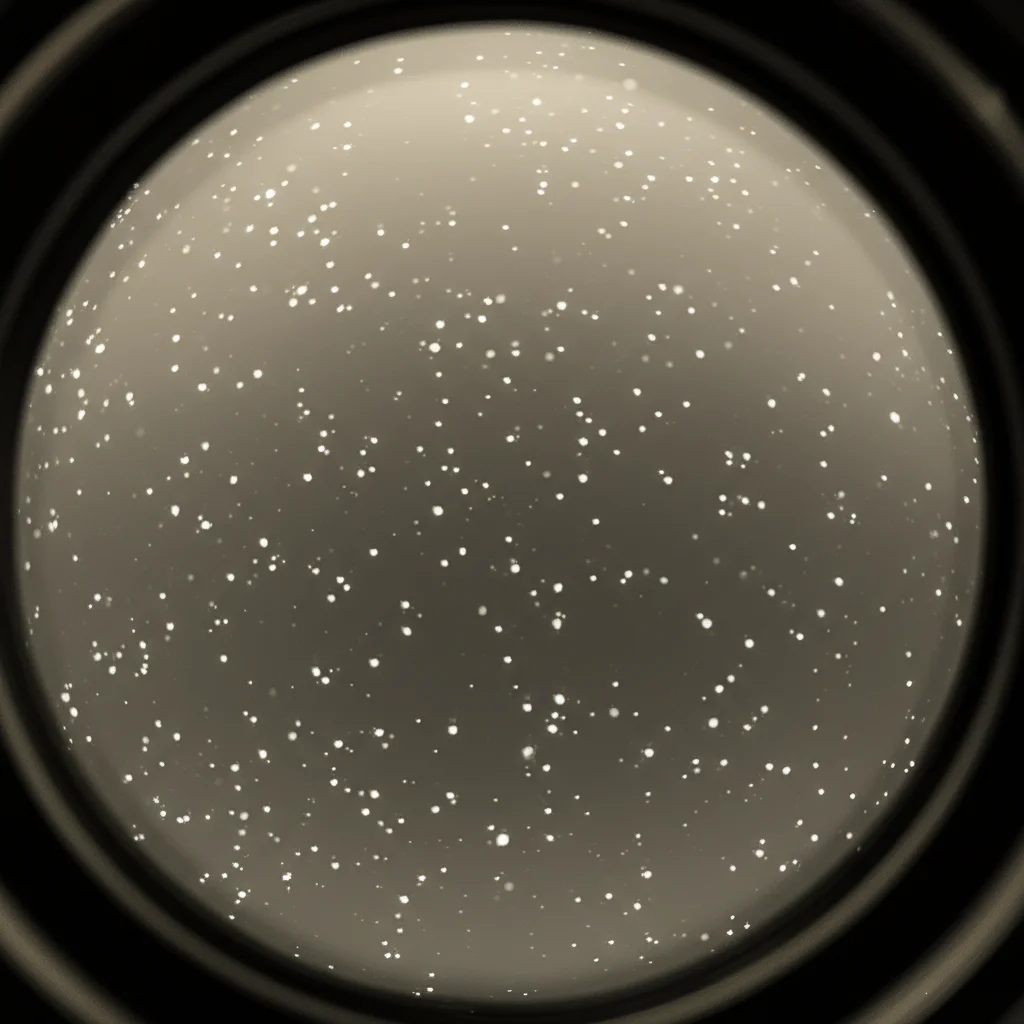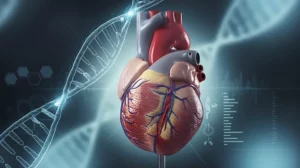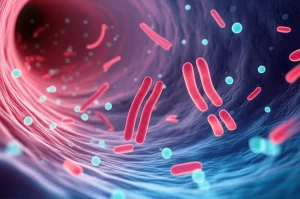Equilibrio da Campioni: Svelati i Segreti dei Calciatori Amputati d’Élite!
Ragazzi, parliamoci chiaro: quando pensiamo al calcio, l’equilibrio è una di quelle cose che diamo quasi per scontate, vero? Eppure, per alcuni atleti, mantenere la stabilità è una sfida quotidiana e una vera e propria arte. Sto parlando dei giocatori di calcio per amputati, eroi moderni che sfrecciano sul campo con una grinta e un’abilità che lasciano a bocca aperta. Ma vi siete mai chiesti come se la cavano con l’equilibrio, soprattutto quando sono dei veri e propri professionisti a livello europeo?
Beh, è esattamente quello che un gruppo di ricercatori (e, modestamente, mi ci metto in mezzo anch’io idealmente, perché l’argomento mi appassiona da matti!) ha voluto scoprire. Ci siamo immersi nel mondo del calcio per amputati d’élite per capire meglio questa fondamentale abilità motoria. E credetemi, i risultati sono stati a dir poco interessanti!
Ma cos’è esattamente il calcio per amputati?
Prima di addentrarci nei dettagli, facciamo un piccolo passo indietro. Il calcio per amputati è una disciplina sportiva regolamentata, pensata per atleti con amputazioni agli arti o altre disfunzioni simili. I portieri possono avere un’amputazione o una differenza a un arto superiore, mentre i giocatori di movimento usano la loro gamba “sana” per colpire il pallone e si muovono agilmente grazie a delle stampelle da avambraccio. Pensateci un attimo: le richieste sportive non sono poi così diverse da quelle del calcio tradizionale, ma questi atleti affrontano sfide funzionali uniche, dovendo gestire il movimento con le stampelle e appoggiandosi su una sola gamba. L’amputazione, specialmente a un arto inferiore, comporta una diminuzione del controllo dell’equilibrio, perché cambia la struttura e la funzione dell’arto, influenzando mobilità e stabilità.
La nostra indagine: cosa abbiamo voluto scoprire?
L’obiettivo principale del nostro studio era piuttosto ambizioso: volevamo valutare le capacità di equilibrio dei calciatori amputati di alto livello, mettendo in relazione questa abilità con diverse variabili. Nello specifico, ci interessava capire se ci fossero differenze in base a:
- Livello sportivo (la posizione in classifica della squadra nel campionato)
- Esperienza di allenamento (quanti anni di pratica alle spalle)
- Ruolo in campo (difensore, centrocampista, attaccante)
- Tipo di disabilità e momento in cui è stata acquisita (dalla nascita o nel corso della vita)
Insomma, un bel po’ di carne al fuoco! Perché, vedete, l’equilibrio è cruciale negli sport “open-skill” come il calcio, dove devi reagire continuamente a situazioni imprevedibili: fermate improvvise, salti, cambi di direzione, finte, contrasti con l’avversario. E nel calcio per amputati, la gamba d’appoggio è anche quella che calcia il pallone. Immaginate la preparazione motoria che ci vuole!
I partecipanti e il test: chi abbiamo messo alla prova e come
Per questa ricerca, abbiamo coinvolto 66 atleti maschi che hanno partecipato ai Campionati Europei di Calcio per Amputati. Un campione di tutto rispetto, con giocatori provenienti da diverse nazioni come Ucraina, Grecia, Polonia, Germania, Spagna e Italia, tra le altre. L’età media si aggirava intorno ai 31 anni, con esperienze di allenamento variegate: alcuni si allenavano da più di 8 anni, altri da meno.
E come abbiamo misurato l’equilibrio? Abbiamo usato una piattaforma stabilografica, uno strumento super preciso che registra le minime oscillazioni del corpo. I giocatori dovevano eseguire un test molto semplice ma rivelatore: stare in piedi su una gamba sola (a piedi nudi) per 10 secondi, prima con gli occhi aperti e poi con gli occhi chiusi. Questo ci ha permesso di valutare l’equilibrio statico e l’importanza del controllo visivo.
Abbiamo analizzato principalmente due parametri: la lunghezza del percorso del centro di pressione (CoP PL), che ci dice quanto “ondeggia” il giocatore, e l’area della superficie dello stabilogramma (SAS), che indica l’ampiezza di queste oscillazioni. Più bassi sono questi valori, migliore è l’equilibrio.

Un dato che mi ha colpito subito è che, in generale, tutti gli atleti mostravano un equilibrio significativamente migliore con gli occhi aperti rispetto a quando li tenevano chiusi. Questo è abbastanza intuitivo: la vista ci aiuta tantissimo a mantenerci stabili. Ma la cosa più interessante è che ben 11 giocatori (il 17% del totale!) non sono riusciti a completare i 10 secondi di test su una gamba con gli occhi chiusi. Questo fa riflettere, perché in partita i giocatori devono focalizzare l’attenzione sul gioco, non certo sui propri piedi per non cadere!
Risultati sorprendenti: cosa ci dicono i dati?
Livello della squadra: conta davvero per l’equilibrio?
Una delle prime cose che abbiamo guardato è stata la differenza tra i giocatori delle squadre meglio classificate (dal 1° al 7° posto) e quelle classificate più in basso (dall’8° al 14°). E qui, sorpresa: non abbiamo trovato differenze significative nel livello di equilibrio. Questo è un po’ strano, perché nel calcio per normodotati, di solito, i giocatori di livello più alto hanno un equilibrio migliore. Potrebbe significare che nel calcio per amputati l’allenamento specifico per l’equilibrio non è ancora così diffuso o prioritario come dovrebbe, anche ai massimi livelli.
Anni di allenamento: l’esperienza paga (a volte)
E l’esperienza di allenamento? Qui qualche differenza l’abbiamo vista. I giocatori che si allenavano da più di 8 anni hanno mostrato un equilibrio significativamente migliore nelle prove ad occhi chiusi rispetto a quelli con meno anni di pratica. Questo suggerisce che, con il tempo e l’allenamento costante, si sviluppa una maggiore capacità di fare affidamento su altri sistemi sensoriali (come quello propriocettivo e vestibolare) quando la vista viene a mancare. Tuttavia, con gli occhi aperti, le differenze non erano così marcate, e non c’era una correlazione diretta tra anni di allenamento e tutti i parametri di equilibrio.
Ruolo in campo e tipo di disabilità: meno impatto del previsto
Ci aspettavamo forse qualche differenza in base al ruolo in campo – magari i centrocampisti, che devono passare spesso la palla, avrebbero avuto un equilibrio superiore. Invece, nessuna differenza significativa è emersa tra difensori, centrocampisti e attaccanti. Allo stesso modo, anche analizzando il tipo di amputazione (sopra il ginocchio, sotto il ginocchio, dismelia), non abbiamo riscontrato variazioni importanti nei livelli di equilibrio. Sembra che l’adattamento a compiti che richiedono equilibrio statico sia notevole, indipendentemente da questi fattori, almeno per i test che abbiamo condotto.
Nati con la disabilità o acquisita? Una differenza c’è
Un aspetto interessante è emerso quando abbiamo confrontato i giocatori con disabilità congenita (presente dalla nascita) e quelli con disabilità acquisita nel corso della vita. Questi ultimi hanno mostrato livelli di equilibrio superiori in entrambe le condizioni (occhi aperti e chiusi), ma la differenza statisticamente significativa si è vista soprattutto nell’indicatore di ispezione visiva (VII). Questo indicatore ci dice quanto i giocatori riescono a compensare la mancanza di stimoli visivi. Sembra che gli atleti con disabilità acquisita facciano meno affidamento sulla vista per mantenere l’equilibrio. Forse l'”esperienza motoria” accumulata prima dell’amputazione gioca un ruolo importante nel controllo dell’equilibrio anche dopo.

Cosa ci portiamo a casa? Implicazioni e futuro
Allora, cosa ci dice tutto questo? Innanzitutto, che l’equilibrio, pur essendo fondamentale, sembra un’area ancora sottoutilizzata nell’allenamento del calcio per amputati. C’è un grande potenziale di miglioramento! L’allenamento dovrebbe essere sistematico e includere esercizi specifici per l’equilibrio, eseguiti sia su superfici stabili che instabili (pensate alle tavolette propriocettive!), con gli occhi aperti e chiusi. E, cosa importantissima, dovrebbe essere individualizzato in base al ruolo del giocatore in campo.
Abbiamo notato, ad esempio, che la squadra i cui giocatori (secondo un’intervista con l’allenatore) eseguivano regolarmente esercizi di equilibrio su superfici stabili e instabili si è classificata terza nel torneo. Un caso? Forse no!
Inoltre, i valori dell’indicatore di ispezione visiva suggeriscono che i giocatori tendono a dipendere molto dagli stimoli visivi. Sarebbe utile lavorare per spostare parte di questo controllo dal sistema visivo a quelli vestibolare e propriocettivo, rendendoli più “automatici” e meno dipendenti dalla vista, che deve essere libera di concentrarsi sul gioco.
Certo, il nostro studio ha delle limitazioni: abbiamo testato l’equilibrio solo in condizioni statiche e non abbiamo considerato se i giocatori usassero quotidianamente stampelle o protesi. Ma crediamo che sia un primo passo importante per capire meglio questa disciplina affascinante e per fornire indicazioni utili ad allenatori e atleti.
La morale della favola? L’equilibrio nel calcio per amputati è un universo ancora in parte da esplorare, ma con un allenamento mirato e scientificamente fondato, questi atleti straordinari possono raggiungere livelli di performance ancora più incredibili. E noi saremo lì a fare il tifo per loro e, perché no, a studiare ancora più a fondo i segreti della loro forza!
Fonte: Springer
]]F>
https://scienzachiara.it/wp-content/uploads/2025/05/188/184_primo-piano-di-un-calciatore-amputato-delite-che-esegue-un-tiro-potente-con-la-sua-gamba-sana.webp
Primo piano di un calciatore amputato d’élite che esegue un tiro potente con la sua gamba sana, l’altra gamba è amputata e si appoggia su stampelle. Teleobiettivo zoom 200mm, fast shutter speed per congelare l’azione, espressione di intensa concentrazione, campo da calcio illuminato da riflettori sullo sfondo.
Medicina Sportiva
Scopri lo studio sull’equilibrio nei calciatori amputati d’élite. Analisi, risultati e implicazioni per l’allenamento nel calcio per amputati di alto livello.
equilibrio, giocatori, amputati, calcio, allenamento, test, disabilità, sport, risultati, visivo
equilibrio-calciatori-amputati-elite-studio
Equilibrio Calciatori Amputati: Studio Rivela Dati Sorprendenti
equilibrio
<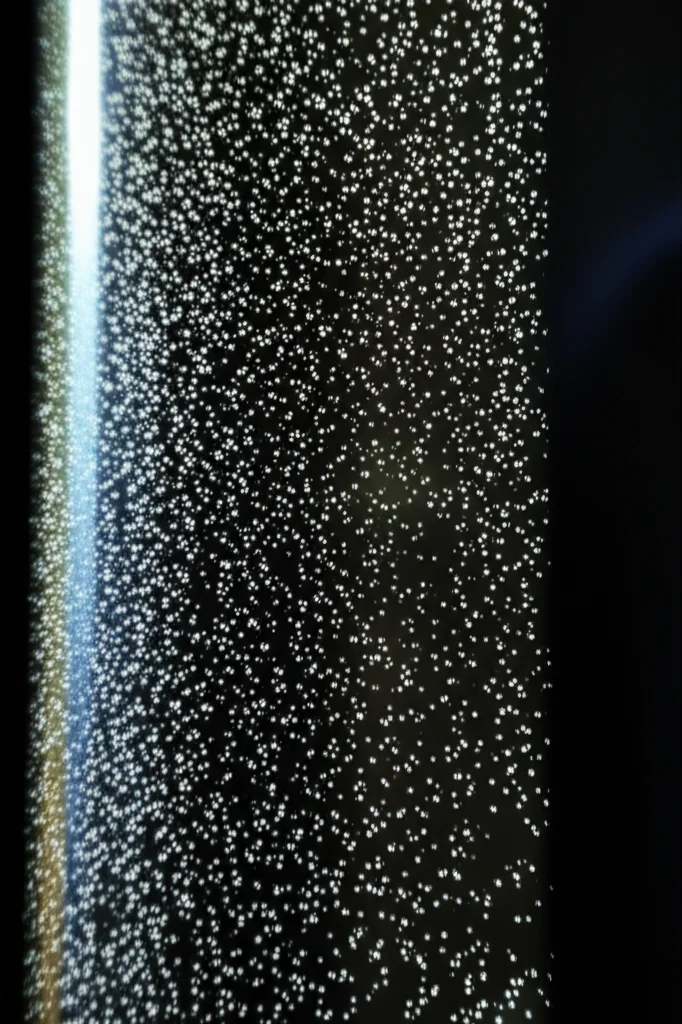
Curiosamente, la Lp(a) è risultata essere associata negativamente sia al rischio di Parkinson sia ai livelli di PM10. Questo potrebbe sembrare controintuitivo, ma una possibile spiegazione è che la Lp(a) potrebbe avere un effetto protettivo contro il diabete, che a sua volta è un fattore di rischio per il Parkinson. Insomma, un intreccio complesso che merita di essere sviscerato.
Un quadro complesso e la necessità di cautela
Certo, come ogni studio scientifico, anche questo ha i suoi punti di forza e qualche limite. Tra i punti di forza, c’è sicuramente l’approccio completo, che ha considerato tanti inquinanti e tantissimi altri fattori confondenti. Inoltre, è uno dei pochi studi ad aver cercato di spiegare il legame attraverso biomarcatori circolanti.
D’altro canto, i ricercatori stessi ammettono alcune limitazioni. Ad esempio, i dati sul PM2.5 (particelle ancora più piccole e potenzialmente più dannose) non erano disponibili per tutto il periodo di studio. Inoltre, la stima dell’esposizione all’inquinamento, per quanto accurata, si basa su misurazioni a terra e potrebbe non essere precisa al millimetro come mappe che integrano dati satellitari. E poi, c’è sempre la possibilità che altri fattori ambientali non misurati, come l’esposizione ai pesticidi, possano giocare un ruolo.
È importante anche dire che il mondo della ricerca sull’inquinamento e le malattie neurodegenerative è ancora in fermento. Altri studi hanno dato risultati contrastanti: alcuni hanno puntato il dito più sul PM2.5 o sul biossido di azoto (NO2), mentre altri non hanno trovato associazioni chiare con il PM10 per il Parkinson. Questo studio Moli-sani, però, si aggiunge a quelle ricerche che vedono nel PM10 un attore importante, come un grosso studio caso-controllo cinese che aveva identificato proprio il PM10 come l’unico inquinante, tra molti, ad influenzare il rischio di Parkinson.
Cosa ci portiamo a casa?
Quindi, cosa significa tutto questo per noi? Beh, prima di tutto, ci ricorda ancora una volta quanto sia cruciale la qualità dell’aria che respiriamo. Se un nemico invisibile come il PM10 può davvero aumentare il rischio di una malattia come il Parkinson, allora abbiamo un motivo in più per spingere verso politiche ambientali più severe e stili di vita più sostenibili.
Questo studio, con il suo focus sul PM10 e il potenziale coinvolgimento della Lipoproteina(a), apre nuove prospettive. Ci dice che forse, agendo sulla riduzione del PM10, potremmo avere un’arma in più per abbassare il rischio di Parkinson a livello di popolazione. E ci invita a scavare più a fondo nei meccanismi legati ai lipidi per capire meglio le cause scatenanti di questa malattia.
Non è ancora il momento di trarre conclusioni definitive, ma è sicuramente un campanello d’allarme che non possiamo ignorare. La ricerca continua, e speriamo che presto ci dia strumenti ancora più efficaci per proteggere il nostro bene più prezioso: la salute del nostro cervello.
Fonte: Springer Nature