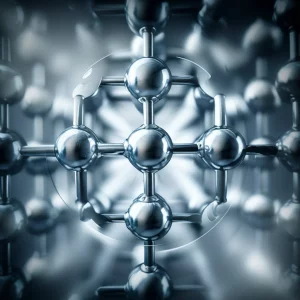Pena Proporzionata: Tra Teoria e Pratica, il Percorso di Michael Tonry
Ciao a tutti! Oggi voglio portarvi con me in un viaggio affascinante nel mondo del diritto penale, un campo dove le decisioni hanno un impatto profondo sulla vita delle persone. Parleremo di un concetto fondamentale: la proporzionalità della pena. E lo faremo seguendo le orme intellettuali di una figura di spicco, un vero “gigante” sulle cui spalle molti di noi studiosi si sono appoggiati: Michael Tonry.
Come Sir Isaac Newton disse una volta, “Se ho visto più lontano è perché stavo sulle spalle di giganti”. Ecco, per me, Michael Tonry è stato uno di quei giganti, insieme a Norval Morris. Gran parte del mio lavoro sulla commisurazione della pena è stato ispirato e sostenuto da lui. Quindi, è un onore poter esplorare come le sue idee sulla proporzionalità si siano evolute e abbiano influenzato il dibattito.
Questo non sarà solo un racconto storico, però. Voglio anche difendere una certa visione della proporzionalità, basandomi sugli argomenti sviluppati da Tonry e altri, me compreso, e mettere in luce alcune questioni ancora aperte che ci fanno grattare la testa. Pronti a partire?
Cos’è Davvero la “Proporzionalità” della Pena?
Sentiamo spesso parlare di “pena proporzionata”, ma cosa significa esattamente? La maggior parte delle volte, ci riferiamo alla proporzionalità retributiva: la severità della pena dovrebbe corrispondere alla colpevolezza morale del reo. I sostenitori più accaniti di questa visione, che Tonry chiama della proporzionalità “forte”, credono che chi commette un reato debba ricevere la pena che “merita”, né più né meno (o quasi). Inoltre, chi è più colpevole dovrebbe essere punito più severamente, e chi è ugualmente colpevole dovrebbe ricevere pene simili.
Sembra giusto, no? Eppure, Tonry ci fa notare un problema: questo approccio si scontra con un altro principio importante, quello della parsimonia (o necessità, o minor sacrificio possibile). Questo principio dice che la pena non dovrebbe essere più severa del necessario per raggiungere gli scopi prefissati (come la riabilitazione o l’impedire che il reo commetta altri crimini). Se seguiamo ciecamente la proporzionalità forte, la parsimonia va a farsi benedire. Infliggere una pena più severa solo per “dare ciò che si merita”, senza un reale beneficio in termini di controllo della criminalità e magari sprecando risorse pubbliche, è davvero una buona politica? A volte, una pena puramente retributiva può essere persino controproducente, rendendo il reo più incline a delinquere in futuro.
Inoltre, un modello retributivo puro rende difficile usare le cosiddette “sanzioni intermedie”, quelle pene che non sono il carcere ma sono più afflittive della semplice libertà vigilata (pensa ai lavori socialmente utili, a certi obblighi di trattamento, ecc.). Negli Stati Uniti, ad esempio, è difficile che queste sanzioni comunitarie vengano percepite come equivalenti, in termini di severità, alle lunghe pene detentive spesso comminate.
I Primi Passi di Tonry: Il Retributivismo Limitante di Morris
Di fronte a questo dilemma, la soluzione di Tonry è stata quella di “ammorbidire” i requisiti della proporzionalità. Nei suoi primi scritti, influenzato da Norval Morris, Tonry abbracciò una teoria ibrida chiamata Retributivismo Limitante (LR). L’idea di base, proposta da Morris, è che la nostra capacità di stabilire esattamente quanto una persona “meriti” una certa pena è intrinsecamente imprecisa. Non c’è un consenso netto su quale sia la pena *perfetta* per un dato reato o reo.
Quindi, secondo il modello LR originale, la proporzionalità non impone una pena specifica, ma definisce un intervallo di severità accettabile. Una pena è considerata “giusta” (o meglio, non ingiusta) se ricade all’interno di questo intervallo, delimitato da un limite superiore (una pena chiaramente troppo severa) e un limite inferiore (una pena chiaramente troppo blanda). All’interno di questo spazio, i giudici possono perseguire altri scopi (come il controllo della criminalità) e applicare il principio di parsimonia, scegliendo la pena meno severa possibile che sia comunque efficace e non “immeritatamente” lieve. Morris e Tonry fornirono esempi in cui l’estremo inferiore di questo intervallo poteva includere sanzioni comunitarie (multe sostanziose, trattamenti obbligatori, libertà vigilata intensiva), mentre l’estremo superiore poteva essere una detenzione di sei mesi, un anno o semplicemente “un periodo in carcere”.

L’Evoluzione: Verso un Retributivismo Limitante Asimmetrico
Col tempo, però, il pensiero di Tonry si è evoluto. Si è avvicinato a quello che io chiamo Retributivismo Limitante Asimmetrico (ALR). Cosa cambia? L’idea fondamentale è che i due limiti dell’intervallo non hanno lo stesso peso morale e pratico.
- Il limite superiore (la pena massima consentita basata sul merito) deve essere il più preciso e fermo possibile. Mai punire qualcuno più severamente di quanto meriti. Questo è un paletto fondamentale a tutela dell’individuo contro l’eccesso di potere statale.
- Il limite inferiore (la pena minima richiesta dal merito) è invece molto più flessibile. Spesso, secondo questo modello, non c’è un vero e proprio limite inferiore basato *solo* sul merito. È ammissibile, per varie ragioni pratiche o di politica criminale, punire qualcuno meno di quanto (forse) meriterebbe.
Già in uno scritto del 1994, Tonry iniziava a porre maggiore enfasi sull’importanza di non superare mai il limite massimo meritato, suggerendo che questo dovesse essere piuttosto stringente. Nelle sue proposte per le linee guida sulla commisurazione della pena, prevedeva limiti superiori forti e proporzionati, mentre i limiti inferiori dovevano essere “sufficientemente flessibili per onorare il principio di parsimonia”.
Perché preferire questo modello asimmetrico? Beh, innanzitutto offre una protezione più forte contro pene eccessivamente severe. Non si può più dire “vabbè, tanto il merito è impreciso, possiamo alzare un po’ la pena”. Inoltre, un limite superiore più definito serve meglio agli scopi espressivi della pena: comunica più chiaramente la gravità del comportamento criminale (es: “10 anni rappresentano la gravità di questo reato”, piuttosto che “la gravità sta tra 5 e 15 anni”). E, diciamocelo, aiuta di più chi deve scrivere le leggi o le linee guida a stabilire questi limiti.
Perché il Retributivismo Limitante (Soprattutto Asimmetrico) Funziona Meglio
Sia chiaro, entrambi i modelli LR (quello originale di Morris e quello asimmetrico) sono, a mio avviso, superiori a un modello retributivo “forte”. Perché?
- Flessibilità: Permettono di usare meglio le sanzioni intermedie e di applicare la parsimonia, evitando pene inutilmente severe che consumano risorse e possono peggiorare la situazione.
- Realismo: Sono molto più aderenti alla realtà della giustizia penale. Ammettiamolo, la maggior parte dei rei, specialmente negli USA, riceve sconti di pena “immeritati” attraverso patteggiamenti, sospensioni condizionali, liberazioni anticipate per buona condotta o decisioni delle commissioni di libertà vigilata. Queste mitigazioni sono spesso una necessità pratica per far funzionare il sistema entro budget limitati e per ottenere la cooperazione dei rei. Un modello che pretendesse di abolirle sarebbe semplicemente irrealistico.
- Valori Morali: Anche all’interno di una logica retributiva, si può sostenere che sia moralmente peggio punire più del dovuto che punire meno del dovuto. Pensate al principio della prova “oltre ogni ragionevole dubbio”: è considerato un’ingiustizia peggiore condannare un innocente che assolvere un colpevole. Questo principio opera anche come limite asimmetrico alla severità della pena quando si tratta di provare elementi che aggravano il reato.
Le Domande Ancora Aperte: Le Sfide del Retributivismo Limitante
Tutto bello, ma i modelli LR non sono privi di nodi da sciogliere. E, ironia della sorte, molte di queste domande mettono in difficoltà anche i sostenitori della proporzionalità forte, che spesso non vi hanno dato risposte adeguate. Vediamo alcune di queste sfide affascinanti.
Il Mistero della Pena Minima
Se il limite inferiore basato sul merito è flessibile o inesistente (nel modello ALR), quando e perché dovremmo comunque imporre una pena minima? Si potrebbe dire che una mitigazione eccessiva sia ingiusta verso altre persone (rei trattati più severamente, vittime, cittadini onesti). Ma se gli altri non sono puniti oltre il loro merito e ci sono buone ragioni pratiche per mitigare la pena di Tizio, perché dovremmo applicare la regola del “mal comune mezzo gaudio”? E non è forse “ingiusto” verso la collettività (contribuenti e potenziali vittime future) spendere risorse pubbliche per una pena più severa che non rende nessuno più sicuro, anzi?
Certo, ci sono ragioni non retributive per porre limiti alla mitigazione: indicatori affidabili di rischio (appartenenza a gang, rifiuto di trattamenti, violenza recente e ripetuta) possono richiedere misure contenitive. E per reati gravissimi come l’omicidio, una certa severità è necessaria per riaffermare norme sociali fondamentali e mantenere il rispetto per la legge.
Come la Mettiamo con i Precedenti Penali?
Questo è un osso duro. Quasi tutti i sistemi penali moderni considerano i precedenti condanne come un fattore che aggrava la pena per un nuovo reato. L’intuizione comune è che chi ripete un reato “meriti” di più. Ma trovare una giustificazione puramente retributiva per questo è difficilissimo. Non si può punire di nuovo per i crimini passati (sarebbe una violazione del principio ne bis in idem), e i precedenti non aumentano di per sé il danno o la colpevolezza (intesa come intenzione, ruolo nel reato, ecc.) del reato attuale.
Tonry, come me, ritiene che i tentativi di giustificare retributivamente gli enormi aumenti di pena per recidiva visti in alcuni sistemi (specie negli USA) siano falliti. La sfida è minore per i modelli LR, a patto che gli aumenti per recidiva rimangano entro i limiti (superiori) del merito. Ma per la proporzionalità forte, è un problema enorme.
Io ho proposto un modello ALR in cui si mitiga la pena per i primari (meritano credito per essere stati ligi alla legge prima; il reato attuale potrebbe essere più situazionale) e si può aumentare (modestamente!) la pena per i recidivi specifici, non perché il nuovo reato sia intrinsecamente più grave, ma perché, essendo stati formalmente avvisati col primo reato del loro rischio, hanno omesso di prendere misure per evitare di ricaderci. Ma questa giustificazione ha limiti precisi (reati simili, aumento modesto).

Definire i Limiti: Quanto è Largo l’Intervallo?
Come si stabiliscono concretamente i limiti superiori e inferiori? E come si confronta la “severità” della pena con la “gravità” del reato (che sono mele e arance)? Qui ci viene in aiuto la distinzione di von Hirsch tra proporzionalità cardinale (la pena massima e minima assolute nel sistema, es. ergastolo e multa) e ordinale (le pene relative tra i vari reati: se il furto semplice merita X, il furto aggravato deve meritare proporzionalmente di più).
Le commissioni che redigono le linee guida sulla pena (come quelle sostenute da Tonry) fanno proprio questo: classificano la gravità dei reati in base a un consenso su casi “tipici”, e poi assegnano pene (o intervalli di pena) a questi livelli, tenendo conto delle prassi passate e delle risorse disponibili. In pratica, molte linee guida USA finiscono per adottare un modello ALR: il limite superiore è definito, ma la pena effettiva per i casi tipici senza precedenti è spesso più bassa, riflettendo la flessibilità del limite inferiore e le mitigazioni comuni.
Misurare la Severità: Sofferenza Reale o Censura Simbolica?
La pena è solo la “sofferenza effettiva” inflitta (anni di carcere, ore di lavoro sociale)? O conta anche la censura formale, il messaggio che la società invia? Io credo che un modello basato sulla censura (e sugli effetti espressivi della pena) permetta di considerare “pena” anche una condanna a una pena detentiva poi sospesa condizionalmente. L’uso diffusissimo delle pene sospese dimostra che giudici e operatori lo ritengono accettabile. Conservano risorse, incentivano il reo a rispettare le condizioni, e comunicano comunque la gravità del reato (una sospensione di 10 anni per il reato X e di 5 per il reato Y dice che X è due volte più grave).
Caratteristiche del Reo e Conseguenze Collaterali
Dobbiamo considerare le differenze soggettive nel modo in cui una pena è vissuta? Tonry sembra propenso, io meno: sarebbe una fonte enorme di disparità. E lo svantaggio sociale? Tonry è più possibilista, e anch’io: è innegabile che chi proviene da contesti svantaggiati abbia più difficoltà a rispettare la legge. È un fattore mitigante legittimo dal punto di vista retributivo, ma bilanciarlo con le esigenze di sicurezza a breve termine è complesso.
E le conseguenze “collaterali” della condanna (perdita del lavoro, deportazione, perdita della custodia dei figli)? Tonry suggerisce di tenerne conto per mitigare la pena. Io sono scettico: rende tutto più complicato, è difficile “tradurre” queste conseguenze in anni di carcere in meno, e forse non sono nemmeno “pena” in senso stretto. Forse la soluzione è escluderle dalla pena base per il caso tipico, ma permettere ai giudici di considerarle come motivo di “scostamento” dalle linee guida in casi eccezionali.
Quali Scopi Non Retributivi sono Ammessi?
Dentro i limiti del merito, quali altri obiettivi possiamo perseguire? Tonry (come Morris) era contrario alla “riabilitazione coatta” in carcere ma a favore di quella su base comunitaria. Erano scettici sull’uso eccessivo della valutazione del rischio individuale per decidere incarcerazione e durata, ma favorevoli all’uso di strumenti validati di valutazione del rischio. Io sono d’accordo.
Non concordo invece con Morris (e Tonry non sembra averlo seguito su questo) sull’idea che i giudici possano usare la pena per la deterrenza generale caso per caso (la “pena esemplare”). I giudici non hanno le informazioni per farlo, e la ricerca suggerisce che aumentare la severità della pena ha scarso effetto deterrente aggiuntivo.
Equivalenza tra Sanzioni e Sanzioni Sostitutive
Tonry e Morris hanno spinto molto per l’uso di sanzioni intermedie al posto del carcere, suggerendo formule di “equivalenza” (es: 8 ore di lavoro sociale = 1 giorno di carcere). Ma ci sono problemi:
- Come si stabiliscono queste equivalenze? Le formule variano enormemente. Come si equiparano il carcere e un trattamento terapeutico?
- Anche con formule generose, le sanzioni intermedie possono sostituire solo pene detentive brevi.
Questi problemi sono meno gravi in un modello LR che non insiste sulla sofferenza immediata: si può dare la stessa pena detentiva (sospesa) a rei ugualmente colpevoli, comunicando la stessa censura, ma con sanzioni intermedie diverse e modeste.
Il Problema delle Sanzioni “di Riserva” (Backup Sanctions)
Se si usano pene comunitarie con condizioni (evitare certi luoghi, seguire un programma), cosa succede se il reo non le rispetta? Servono sanzioni “di riserva”. Ma se sono troppo severe, si rischia di mandare in carcere persone che non ci dovrebbero andare per violazioni minori (il “net widening”). E se la pena comunitaria era quella “meritata”, come si giustifica mandare poi in carcere senza una nuova condanna? Questo è un problema per la proporzionalità forte. Per i modelli LR è più gestibile: la pena detentiva sospesa era già considerata “meritata” in termini di limite massimo. La sfida è strutturare l’uso delle sanzioni di riserva in modo che il carcere sia l’ultima spiaggia.

In Conclusione: Un Dibattito Aperto
Michael Tonry è stato pioniere nel riconoscere e sviluppare il modello del Retributivismo Limitante, una visione che, di fatto, era già diffusa nella pratica ma snobbata dalla teoria pura. Il suo pensiero si è evoluto verso un modello asimmetrico, più robusto nel proteggere dagli eccessi punitivi e più flessibile nel permettere soluzioni pragmatiche.
Certo, come abbiamo visto, restano domande aperte e sfide complesse. Ma molte di queste sfide sono irrisolte (e forse irrisolvibili) anche per chi difende una visione “forte” della proporzionalità retributiva. Forse è arrivato il momento che anche loro prendano sul serio il Retributivismo Limitante, si confrontino con esso e ci mostrino come intendono affrontare questi dilemmi senza, di fatto, adottare anch’essi un modello ibrido. Il viaggio intellettuale continua!
Fonte: Springer