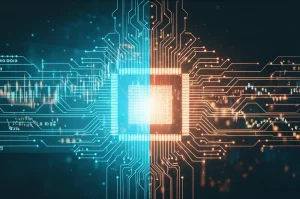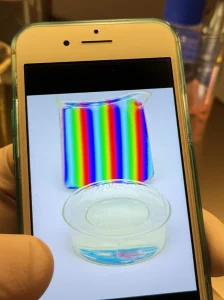Paracetamolo Sotto la Lente: A Caccia di Impurità Nascoste con HPLC e TLC!
Ciao a tutti! Oggi voglio parlarvi di qualcosa che riguarda molti di noi da vicino: i farmaci. In particolare, ci tufferemo nel mondo affascinante e super importante del controllo qualità, scoprendo come facciamo a scovare ospiti indesiderati, le cosiddette impurità, in medicinali di uso comune. Prendiamo ad esempio una combinazione farmaceutica che magari conoscete: quella che unisce ibuprofene (IBU), paracetamolo (PAR) e clorzoxazone (CHZ). L’ibuprofene è un antidolorifico e antinfiammatorio, il paracetamolo è un altro antidolorifico e antipiretico (contro la febbre), e il clorzoxazone è un miorilassante. Un bel trio per combattere dolori muscolari e infiammazioni, vero?
Ma ecco il punto cruciale: il paracetamolo, pur essendo un farmaco efficacissimo e largamente usato, può portarsi dietro delle “ombre”, delle impurità potenzialmente tossiche che si formano durante la sua produzione o conservazione. E il nostro compito, da “detective della chimica”, è assicurarci che queste impurità rimangano ben al di sotto dei limiti di sicurezza.
I “Cattivi” della Storia: Le Impurità Tossiche del Paracetamolo
Nel nostro studio, ci siamo concentrati su tre impurità specifiche del paracetamolo, note per la loro potenziale pericolosità:
- p-aminofenolo (PAP): Questa è l’impurità “principale”, definita K nella Farmacopea Britannica (BP). Può derivare sia dalla sintesi che dalla degradazione del paracetamolo. Pensate, ha effetti teratogeni (dannosi per il feto), epatotossici (dannosi per il fegato) e nefrotossici (dannosi per i reni). I limiti sono severissimi: non più di 50 parti per milione (ppm) nella materia prima e 1000 ppm (0.1%) nelle compresse!
- p-nitrofenolo (PNP): Classificata come impurità F non specificata nella BP, il suo limite è 500 ppm nella materia prima e 2500 ppm nelle formulazioni. Perché tenerla d’occhio? Può causare metaemoglobinemia, una condizione che riduce la capacità del sangue di trasportare ossigeno.
- p-cloroacetanilide (PCA): Questa è l’impurità J della BP, con limiti ancora più stringenti: massimo 10 ppm! È anch’essa nefrotossica ed epatotossica, può causare emolisi (rottura dei globuli rossi) ed è irritante per pelle e occhi.
Capite bene perché è fondamentale non solo dosare i principi attivi (IBU, PAR, CHZ) ma anche quantificare con precisione queste impurità.
La Sfida: Analizzare Tutto Insieme!
Il problema è che analizzare contemporaneamente tre principi attivi *e* tre impurità, presenti in concentrazioni molto diverse, non è una passeggiata. Servono metodi analitici potenti, selettivi e sensibili. Ed è qui che entriamo in gioco noi! Abbiamo sviluppato e validato due tecniche cromatografiche diverse ma ugualmente efficaci per fare proprio questo: la cromatografia su strato sottile con rilevamento densitometrico (TLC-Densitometria) e la cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC). L’obiettivo? Avere metodi affidabili per il “profilo di impurità” del paracetamolo in questa specifica combinazione farmaceutica.
Metodo 1: La Corsa sulla Lastrina – TLC Densitometrica
La TLC è una tecnica classica ma sempre valida. Immaginate una lastrina ricoperta di un materiale speciale (gel di silice 60 F254 nel nostro caso). Noi depositiamo una piccola quantità del nostro campione (estratto dalle compresse o soluzioni standard) su questa lastrina. Poi immergiamo il bordo inferiore della lastrina in una miscela di solventi (la nostra “fase mobile”: cloroformio, toluene, etanolo e ammoniaca in proporzioni specifiche 7.0:1.0:1.6:0.2). I solventi risalgono per capillarità sulla lastrina, trascinando con sé i componenti del campione.
Ogni sostanza “corre” a una velocità diversa in base a come interagisce con la lastrina e con i solventi. Alla fine della corsa, avremo delle macchie separate a diverse altezze (identificate dai valori di Rf). Per “vedere” e quantificare queste macchie, usiamo un densitometro che misura quanta luce assorbono a una specifica lunghezza d’onda (220.0 nm nel nostro caso). È un metodo relativamente economico e versatile. Abbiamo ottimizzato la miscela di solventi e la lunghezza d’onda per ottenere la migliore separazione possibile tra i nostri sei “corridori”: IBU, PAR, CHZ e le tre impurità PAP, PNP, PCA.

Metodo 2: L’Autostrada Liquida – HPLC
L’HPLC è considerata la tecnica “regina” per l’analisi farmaceutica. Qui, la separazione avviene all’interno di una colonna (nel nostro caso, una Xterra C8) riempita con un materiale specifico (la fase stazionaria). La nostra miscela di solventi (fase mobile: acetonitrile e tampone fosfato a pH 7.5, in rapporto 30:70 v/v) viene pompata ad alta pressione attraverso la colonna. Il campione viene iniettato e i suoi componenti viaggiano attraverso la colonna a velocità diverse, separandosi in modo molto efficiente.
All’uscita della colonna, un rivelatore UV (impostato anche qui a 220.0 nm) misura l’assorbanza dei composti man mano che escono, generando un grafico chiamato cromatogramma, con picchi distinti per ogni sostanza. Abbiamo sperimentato diverse colonne, fasi mobili, pH e velocità di flusso (0.7 mL/min è risultata ottimale) per trovare le condizioni perfette che ci permettessero di separare tutti e sei i composti in un tempo ragionevole (circa 11 minuti per l’ultimo picco, quello del PCA) e con picchi ben definiti e simmetrici. L’HPLC è generalmente più sensibile, precisa e veloce della TLC, anche se richiede strumentazione più costosa.
La Prova del Nove: La Validazione Secondo le Regole
Sviluppare un metodo è solo il primo passo. Poi bisogna dimostrare che funziona davvero bene, che è affidabile e robusto. Questo processo si chiama validazione e segue linee guida internazionali molto precise (le famose linee guida ICH – International Council for Harmonisation). Abbiamo sottoposto entrambi i nostri metodi, TLC e HPLC, a una serie rigorosa di test:
- Linearità: Abbiamo verificato che la risposta dello strumento (area del picco o della macchia) sia proporzionale alla concentrazione della sostanza in un certo intervallo.
- Accuratezza: Abbiamo controllato quanto i risultati ottenuti si avvicinano al valore “vero”, analizzando campioni a concentrazione nota. I recuperi percentuali erano ottimi per entrambi i metodi!
- Precisione: Abbiamo valutato quanto sono ripetibili i risultati, sia facendo analisi nello stesso giorno (ripetibilità) sia in giorni diversi (precisione intermedia). I valori di deviazione standard relativa (RSD%) erano molto bassi, indicando alta precisione.
- Specificità: Abbiamo dimostrato che i metodi misurano *solo* i composti di interesse, senza interferenze da parte degli altri componenti o delle impurità. Abbiamo analizzato miscele complesse e verificato che tutti i picchi/macchie fossero ben separati (risoluzione > 2).
- Robustezza: Abbiamo introdotto piccole variazioni volontarie nelle condizioni operative (es. composizione della fase mobile, pH, flusso, lunghezza d’onda) per vedere se il metodo reggeva il colpo. Ebbene sì, entrambi i metodi si sono dimostrati robusti!

Dal Laboratorio alla Farmacia: Il Test sulle Compresse
Dopo la validazione, era il momento della verità: applicare i metodi a un prodotto commerciale reale. Abbiamo preso delle compresse di Flexon® MR (che contengono proprio IBU 400mg, PAR 325mg e CHZ 250mg), le abbiamo polverizzate, estratto i principi attivi e le eventuali impurità, e le abbiamo analizzate con i nostri metodi TLC e HPLC.
I risultati? Eccellenti! Siamo riusciti a quantificare accuratamente i tre principi attivi nelle compresse, ottenendo valori in linea con quanto dichiarato in etichetta e senza interferenze da parte degli eccipienti (le sostanze “inattive” della compressa). Ancora più importante, i metodi si sono dimostrati capaci di rilevare e quantificare le impurità PAP, PNP e PCA se presenti. Abbiamo anche confrontato statisticamente i nostri risultati con quelli di un metodo HPLC precedentemente pubblicato (che però non analizzava le impurità) e non abbiamo trovato differenze significative, confermando l’accuratezza e la precisione del nostro lavoro.
Due Metodi, Un Obiettivo: Sicurezza e Qualità
In conclusione, abbiamo messo a punto due metodi cromatografici, uno TLC e uno HPLC, che sono precisi, accurati, selettivi e validati secondo le norme internazionali. La loro forza sta nel permettere non solo il dosaggio simultaneo di ibuprofene, paracetamolo e clorzoxazone, ma anche, per la prima volta a nostra conoscenza, la quantificazione delle tre principali impurità tossiche del paracetamolo (PAP, PNP, PCA) nella stessa analisi.
Questo è un passo avanti importante per il controllo qualità di routine di queste formulazioni farmaceutiche. Offriamo così all’industria farmaceutica due opzioni valide: la TLC, più economica, e l’HPLC, più veloce e performante. Entrambe contribuiscono a garantire che i farmaci che arrivano nelle nostre case siano non solo efficaci, ma soprattutto sicuri. E per noi “detective della chimica”, questa è la soddisfazione più grande!
Fonte: Springer