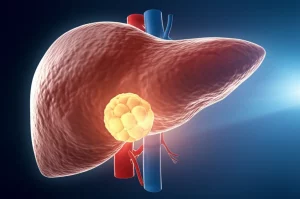Palloncini Medicati: Funzionano Davvero sulle Lesioni Lunghe? Scoperte a 2 Anni
Ciao a tutti! Oggi voglio parlarvi di un argomento che mi sta particolarmente a cuore e che riguarda la salute delle nostre arterie, in particolare quelle delle gambe: la malattia arteriosa periferica (PAD). Pensate che colpisce oltre 200 milioni di persone nel mondo! È una condizione seria, associata a problemi cardiaci, ictus e, nei casi peggiori, all’amputazione degli arti.
Negli ultimi anni, una delle terapie più promettenti per trattare le lesioni nelle arterie femoropopliteali (quelle che corrono lungo la coscia e dietro il ginocchio) è l’uso dei palloncini medicati (Drug-Coated Balloons, o DCB). Questi dispositivi sono fantastici perché, una volta gonfiati nell’arteria ristretta, rilasciano localmente un farmaco (spesso il paclitaxel) che aiuta a prevenire la formazione di nuove ostruzioni (la cosiddetta restenosi). È un approccio “leave nothing behind”, cioè non lascia impianti metallici permanenti come gli stent, il che sulla carta è un bel vantaggio.
Numerosi studi hanno confermato che i DCB sono sicuri ed efficaci, soprattutto per le lesioni corte. Ma cosa succede quando le lesioni sono lunghe, diciamo oltre i 15 cm? Qui le prove scientifiche sono ancora un po’ scarse. Ed è proprio qui che entra in gioco il nostro studio. Ci siamo chiesti: come si comportano i DCB a distanza di due anni quando li usiamo su lesioni lunghe rispetto a quelle corte? E quali fattori possono farci prevedere se il trattamento avrà successo o meno?
Il Nostro Studio: Mettere i Puntini sulle “i”
Abbiamo condotto uno studio “real-world”, cioè basato sull’esperienza clinica quotidiana, nel nostro centro, il Peking Union Medical College Hospital. Abbiamo analizzato i dati di 234 pazienti trattati con successo con DCB (specificamente il modello Orchid DCB) tra gennaio 2019 e dicembre 2021. Di questi, 115 avevano lesioni lunghe (> 15 cm) e 141 lesioni corte (≤ 15 cm).
Cosa volevamo capire? Principalmente due cose:
- Sicurezza: Volevamo vedere quanti pazienti, a due anni, non avessero avuto eventi avversi maggiori (morte per qualsiasi causa, amputazione dell’arto trattato o trombosi).
- Efficacia: L’obiettivo principale era misurare la “pervietà primaria” a due anni. In parole semplici, volevamo vedere quanti pazienti non avessero avuto bisogno di un nuovo intervento sulla stessa lesione (CD-TLR) e non presentassero una nuova restenosi significativa (confermata da ecodoppler o angio-TC).
Abbiamo raccolto un sacco di dati: caratteristiche dei pazienti (età, sesso, altre malattie come ipertensione o diabete), dettagli delle lesioni (lunghezza, se erano occlusioni totali, presenza di calcificazioni, restenosi su stent precedenti) e i risultati delle procedure. I pazienti sono stati seguiti regolarmente con visite e controlli strumentali a 6, 12 e 24 mesi.

Risultati Chiave: Luci e Ombre sui Palloncini Medicati
E qui arrivano i risultati, che ci danno un quadro interessante. Partiamo dall’efficacia: la pervietà primaria a 2 anni è stata del 56,1% in generale. Ma la differenza tra i due gruppi è stata netta:
- Lesioni corte (≤ 15 cm): Pervietà del 62,5%
- Lesioni lunghe (> 15 cm): Pervietà del 48,3%
Questa differenza è statisticamente significativa (p = 0,005), e ci dice chiaramente che i DCB funzionano meno bene sulle lesioni più estese a lungo termine.
Curiosamente, però, quando abbiamo guardato la necessità di un nuovo intervento (libertà da CD-TLR), non abbiamo trovato differenze significative tra i due gruppi (87,4% per le corte vs 83,6% per le lunghe, p = 0,25). Come si spiega? Una possibile ragione è che, a volte, anche se c’è una restenosi visibile agli esami, si decide di non intervenire se il paziente non ha sintomi importanti.
Analizzando le caratteristiche, abbiamo notato che i pazienti con lesioni lunghe avevano più spesso:
- Occlusioni totali complete (90,4% vs 53,9%)
- Restenosi all’interno di stent precedenti (in-stent restenosis)
- Ischemia più avanzata (cioè sintomi più gravi, classificati come Rutherford Clinical Category – RCC 4-6)
- Valori più bassi dell’indice caviglia-braccio (ABI), che indica una peggiore circolazione.
Abbiamo anche cercato di capire quali fattori fossero dei veri e propri “predittori” di perdita di pervietà. L’analisi multivariata (che tiene conto di più fattori contemporaneamente) ha confermato due elementi chiave:
- Lunghezza della lesione > 15 cm (p = 0,017)
- Ischemia avanzata (RCC 4-6) (p = 0,026)
Interessante notare che, analizzando solo il sottogruppo con lesioni lunghe, l’unico fattore predittivo rimasto significativo era l’ischemia avanzata (RCC 4-6). Nel gruppo con lesioni corte, invece, non sono emersi predittori statisticamente significativi.
La Sfida delle Lesioni Lunghe: Perché sono Diverse?
Ma perché queste lesioni lunghe sono così ostiche? Ci sono diverse ragioni. Prima di tutto, le arterie femoropopliteali sono sottoposte a stress meccanici notevoli: si piegano, si torcono, si comprimono con i movimenti della gamba. Questo stress è maggiore su segmenti lunghi e può favorire il fallimento del trattamento.
Poi c’è la questione delle calcificazioni. Anche se nel nostro studio non abbiamo trovato un legame diretto tra la presenza generica di calcio e la perdita di pervietà (p = 0,761), siamo consapevoli che il nostro metodo di valutazione (semplicemente “presente/assente”) era forse troppo semplicistico. La letteratura scientifica suggerisce fortemente che calcificazioni severe, specialmente quelle che circondano gran parte del vaso (>270°) o quelle di tipo intimale (legate alla placca aterosclerotica) piuttosto che mediale (più comuni nel diabete), possono ostacolare l’efficacia del DCB, rendendo più difficile la penetrazione del farmaco. Manca ancora uno standard univoco per classificare il calcio nelle arterie periferiche, come invece esiste per le coronarie (punteggio di Agatston), e questo è un limite.

Un altro punto cruciale è il confronto con gli stent, in particolare quelli medicati (Drug-Eluting Stents, DES). Mentre i DCB puntano a non lasciare nulla di permanente, gli stent forniscono un supporto meccanico (scaffolding) che può essere vitale proprio in queste arterie “difficili”. Diversi studi randomizzati e controllati hanno mostrato che, per le lesioni lunghe, DES e DCB hanno risultati simili a 1 anno, ma i DES sembrano garantire una pervietà migliore a lungo termine. I nostri dati, con una pervietà del 48,3% a 2 anni per le lesioni lunghe trattate con DCB, sembrano confermare questa tendenza.
Inoltre, non dimentichiamo il “bailout stenting”: quando si usa un DCB, a volte è necessario impiantare comunque uno stent se il risultato non è ottimale (es. dissezione dell’arteria, restringimento residuo >30%). Nel nostro studio è successo nel 15,7% dei casi con lesioni lunghe. Questo, di fatto, annulla il vantaggio del “leave nothing behind” e solleva la domanda se, in questi casi complessi, non sia meglio usare uno stent medicato fin dall’inizio. La pratica clinica sembra già andare in questa direzione: i DCB sono spesso preferiti per lesioni di media lunghezza e poco calcificate, mentre i DES vengono scelti più di frequente per segmenti lunghi e molto calcificati.
Ischemia Avanzata: Un Nemico Silenzioso
Un dato che mi ha colpito è l’impatto dell’ischemia avanzata (RCC 4-6, che include dolore a riposo o presenza di ulcere/gangrena). Questi pazienti erano più presenti nel gruppo con lesioni lunghe e, come abbiamo visto, questa condizione è un fattore di rischio indipendente per la perdita di pervietà. Perché? Probabilmente perché in questi stadi avanzati della malattia, non c’è solo un problema nelle grandi arterie, ma anche una disfunzione del microcircolo (i capillari). L’ipossia cronica danneggia questi piccoli vasi, e riaprire solo l’arteria principale potrebbe non essere sufficiente a ripristinare una buona circolazione a lungo termine.
Sicurezza e Complicazioni: Cosa Dicono i Dati?
Parliamo di sicurezza. Nel nostro studio, gli eventi avversi maggiori (MAE) si sono verificati nel 12,4% dei pazienti. La mortalità per tutte le cause (escluse le morti peri-operatorie) è stata del 9,4%, con cause diverse (infarto, cancro, complicanze del diabete, COVID-19, ictus, cause non specificate). Le amputazioni maggiori sono state 7. È un tasso relativamente alto. Dobbiamo considerare che lo studio si è svolto durante la pandemia di SARS-CoV-2. Sappiamo che il COVID-19 può aumentare il rischio di trombosi e peggiorare le malattie cardiovascolari, inclusa la PAD. Anche se non abbiamo dati specifici sull’infezione nei nostri pazienti, è un fattore che potrebbe aver inciso.

Limiti e Prospettive Future
Come ogni studio, anche il nostro ha dei limiti. È retrospettivo, condotto in un solo centro, e non confronta direttamente i DCB con altre terapie come i DES o l’aterectomia. La scelta di usare un DCB era lasciata al chirurgo durante l’intervento, il che introduce un potenziale bias di selezione. La valutazione delle calcificazioni era qualitativa e abbiamo perso ai controlli alcuni pazienti (anche se pochi, il 2,6%). Inoltre, abbiamo usato un solo tipo di DCB, quindi i risultati potrebbero non essere generalizzabili a tutti i palloncini medicati disponibili sul mercato.
In Conclusione: Cosa Portiamo a Casa?
Allora, qual è il succo della storia? I palloncini medicati (DCB) si confermano una terapia con risultati di sicurezza accettabili a 2 anni per le lesioni femoropopliteali. Tuttavia, quando ci troviamo di fronte a lesioni lunghe (> 15 cm), la loro efficacia in termini di pervietà primaria è significativamente inferiore rispetto alle lesioni corte (48,3% vs 62,5%). L’ischemia avanzata (RCC 4-6) emerge come un importante fattore di rischio per il fallimento del trattamento.
Questi risultati ci fanno riflettere: forse per le lesioni lunghe e complesse, i DCB da soli non sono la strategia ottimale. Potrebbe essere necessario considerare alternative fin dall’inizio, come l’impianto primario di stent medicati (DES), la chirurgia di bypass, o magari terapie “ibride” che combinano diverse tecniche. La scelta del trattamento deve essere sempre più personalizzata, basata sulle caratteristiche specifiche della lesione (lunghezza, calcificazione) e del paziente. La ricerca continua, e speriamo presto di avere strategie ancora migliori per affrontare queste sfide affascinanti della medicina vascolare!
Fonte: Springer