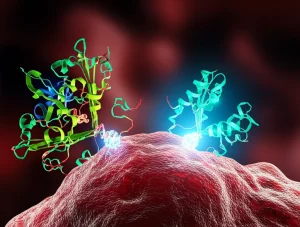Ossido di Cobalto: L’Eroe Inatteso che Sfida l’Iridio nell’Elettrolisi della CO2?
Ciao a tutti! Oggi voglio parlarvi di una sfida affascinante nel mondo della chimica e dell’energia sostenibile: come possiamo trasformare l’anidride carbonica (CO2), uno dei principali “cattivi” del cambiamento climatico, in qualcosa di utile? Una delle strade più promettenti è l’elettrolisi della CO2, un processo che usa l’elettricità (idealmente da fonti rinnovabili) per convertire la CO2 in sostanze chimiche preziose o combustibili. Figo, no?
Però, come in ogni bella storia, c’è un “ma”. Questo processo richiede dei catalizzatori, materiali speciali che aiutano le reazioni a avvenire in modo efficiente. All’anodo, il polo positivo della nostra cella elettrolitica dove avviene l’ossidazione dell’acqua (una reazione chiamata OER, Oxygen Evolution Reaction), il campione indiscusso è l’Iridio (Ir). È bravo, fa il suo lavoro egregiamente. Il problema? L’Iridio è raro, costoso e la sua stabilità in alcune condizioni operative non è sempre impeccabile. Insomma, cercare un sostituto più abbondante ed economico è un po’ il Sacro Graal per chi lavora in questo campo.
La Sfida: Un Ambiente Difficile per i Catalizzatori
Potrebbe sembrare semplice: troviamo un altro materiale che faccia l’OER e via. Eh no, non è così facile! L’elettrolisi della CO2 ha le sue particolarità. Nelle celle più comuni, si usa una membrana a scambio anionico (AEM) per separare anodo e catodo. Durante il funzionamento, soprattutto a correnti elevate, ioni carbonato (CO3²⁻) viaggiano dal catodo (dove la CO2 viene ridotta) all’anodo. Se l’anolita (la soluzione all’anodo) viene ricircolata – cosa necessaria in applicazioni pratiche – questi ioni carbonato si accumulano, abbassando il pH fino a valori quasi neutri (si forma una soluzione tampone carbonato/bicarbonato).
Questa è una differenza chiave rispetto all’elettrolisi dell’acqua con AEM, dove gli ioni OH⁻ che attraversano la membrana vengono subito neutralizzati dagli H⁺ prodotti all’anodo. Materiali come il Nichel (Ni), ottimi in ambiente alcalino, nell’elettrolisi della CO2 funzionerebbero solo se continuassimo ad aggiungere base per mantenere il pH alto. Poco pratico.
Quindi, il candidato ideale deve:
- Essere bravo a fare l’OER in un ambiente a pH quasi neutro e pieno di ioni carbonato/bicarbonato.
- Essere fatto di materiali economici e abbondanti (non “materie prime critiche”, come le definisce l’UE).
- Essere sintetizzabile con metodi scalabili per celle industriali.
Ecco che Entra in Gioco il Co3O4
La ricerca si è concentrata su vari metalli (Cu, Fe, Ni, Co), spesso scoprendo che la forma attiva del catalizzatore si sviluppa proprio durante la reazione OER. Tra questi, l’ossido di cobalto (Co3O4) ha attirato molta attenzione fin dagli anni ’80, soprattutto per la sua buona attività OER e durabilità in ambiente alcalino. Studi successivi hanno mostrato che è stabile anche in soluzioni tampone fosfato a pH neutro e che può funzionare persino in ambienti acidi o neutri per l’elettrolisi dell’acqua pura o marina, con prestazioni a volte paragonabili all’IrO2.
Il Co3O4 ha una struttura a spinello, ma è intrinsecamente un semiconduttore, il che può portare a tensioni di cella più alte (serve più energia). Però, questa struttura permette di “drogare” il materiale, inserendo altri cationi (Pd, Cr, Fe, Ni…) o elementi (F, N) per migliorarne la conduttività e la resistenza.
Ma come si comporta il Co3O4 nell’ambiente specifico dell’elettrolisi della CO2 a lungo termine, con pH quasi neutro e tanto carbonato? Sorprendentemente, non c’erano molte informazioni disponibili. La termodinamica suggerirebbe che gli ossidi di cobalto “nudi” siano stabili solo a potenziali abbastanza alti in questo ambiente, ma la cinetica (la velocità delle reazioni) potrebbe cambiare le carte in tavola. Era ora di scoprirlo!

Il Nostro Approccio: Far Crescere il Catalizzatore Direttamente Dove Serve
Nel nostro studio, abbiamo deciso di sostituire l’Iridio con nanofogli porosi di Co3O4 come catalizzatore anodico in una cella per elettrolisi di CO2 a “zero-gap” (con componenti molto vicini per minimizzare le resistenze). Per evitare problemi di conducibilità dovuti a contatti imperfetti tra le particelle di catalizzatore e il supporto (lo strato di trasporto poroso, PTL, in Titanio nel nostro caso), abbiamo usato un metodo intelligente: abbiamo fatto crescere il Co3O4 direttamente sulla superficie del Ti PTL tramite sintesi idrotermale.
Immaginate di “cucinare” il catalizzatore proprio lì dove deve lavorare! Questo approccio garantisce un contatto intimo e, cosa non da poco, è scalabile: basta avere un’autoclave (una specie di pentola a pressione da laboratorio) abbastanza grande. Abbiamo preparato diversi campioni variando la quantità di precursore di cobalto per ottenere diversi “carichi” (loading) di catalizzatore sul PTL, da circa 2.5 a 13.3 mg per cm².
Analizzando i campioni con tecniche come SEM (microscopia elettronica a scansione) e XRD (diffrazione a raggi X), abbiamo visto che il Co3O4 si depositava uniformemente sul Ti PTL formando delle “scaglie” bidimensionali porose (nanosheets) di dimensioni micrometriche, con la tipica struttura cristallina cubica a facce centrate dello spinello. L’analisi XPS (spettroscopia fotoelettronica a raggi X) ha confermato la composizione superficiale attesa.
Alla Prova dei Fatti: Co3O4 vs Iridio
Abbiamo quindi assemblato le nostre celle elettrolitiche, usando il Ti PTL rivestito di Co3O4 come anodo e un catodo standard a base di nanoparticelle d’Argento (Ag NPs) per la riduzione della CO2 a CO (monossido di carbonio). Abbiamo fatto circolare una soluzione di CsHCO3 (ottenuta saturando CsOH 0.05 M con CO2) come anolita a 60°C e alimentato CO2 umidificata al catodo.
I risultati? Confrontando un anodo Co3O4 (con carico ottimale di circa 7 mg cm⁻²) con un anodo di Ir nero (1 mg cm⁻²), abbiamo visto che, come previsto, l’Iridio richiedeva una tensione di cella inferiore per raggiungere la stessa densità di corrente (es. 100 mA cm⁻² a 2.40 V per Ir vs 2.88 V per Co3O4). Tuttavia, il nostro Co3O4 riusciva comunque a raggiungere una rispettabile densità di corrente di circa 300 mA cm⁻² a 3.4 V. È interessante notare che la selettività della riduzione della CO2 a CO era molto simile per entrambi i catalizzatori, intorno all’85-92%.
Abbiamo anche studiato l’effetto del carico di Co3O4. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare (“più catalizzatore = meglio è”), abbiamo scoperto che c’era un carico ottimale intorno ai 7 mg cm⁻². Carichi inferiori davano prestazioni leggermente minori, ma carichi superiori peggioravano significativamente le cose! Analizzando l’impedenza della cella, abbiamo visto che la resistenza (Rs) aumentava rapidamente con carichi superiori a 7 mg cm⁻², suggerendo che la conducibilità dello strato di Co3O4 diventasse un fattore limitante, forse insieme a problemi di trasporto di massa nello strato più spesso.

Ma Reggerà nel Tempo? La Prova di Durata
La vera domanda era: quanto è stabile questo Co3O4 nelle condizioni operative reali e prolungate? Abbiamo misurato la quantità di Cobalto disciolto nell’elettrolita dopo i test: era bassissima, nell’ordine dei microgrammi per cm², indicando una buona stabilità chimica intrinseca.
Poi è arrivato il momento del test di durata: 50 ore di funzionamento continuo! In un primo tentativo con il carico ottimale di 7 mg cm⁻² a 300 mA cm⁻², abbiamo notato un calo di selettività dopo circa 20 ore. Smontando la cella, abbiamo trovato dei piccoli fori nella membrana, forse causati dai bordi un po’ “taglienti” dei nanofogli di Co3O4 più spessi.
Abbiamo quindi ritentato con un carico leggermente inferiore (4.85 mg cm⁻², superficie meno “ruvida”) e una densità di corrente di 250 mA cm⁻². Successo! La cella ha funzionato stabilmente per tutte le 50 ore, mantenendo una tensione costante intorno a 3.4-3.5 V e una selettività per il CO intorno al 90%. Il pH dell’anolita è rimasto stabile nell’intervallo 7.05-7.30, confermando che il Co3O4 lavorava proprio nell’ambiente quasi neutro previsto.
Cosa Abbiamo Imparato e Prospettive Future
Analizzando l’anodo dopo il test di lunga durata, abbiamo osservato dei cambiamenti interessanti. La morfologia superficiale era passata da “scaglie” a strutture più simili ad “aghi”, e l’analisi XPS suggeriva la formazione di una fase di ossiidrossido di cobalto (CoOOH) sulla superficie, in linea con quanto noto per l’attivazione del Co3O4 per l’OER. Tuttavia, l’analisi XRD ha mostrato che la struttura cristallina interna (il “bulk”) era rimasta quella del Co3O4. Questo significa che le alterazioni erano principalmente superficiali, mentre il cuore del catalizzatore era rimasto intatto. Non abbiamo trovato tracce di Cobalto migrate attraverso la membrana.
Quindi, missione compiuta? Direi un ottimo passo avanti! Abbiamo dimostrato che i nanofogli porosi di Co3O4, sintetizzati direttamente sul PTL di Titanio, possono effettivamente sostituire l’Iridio come catalizzatore anodico nell’elettrolisi della CO2. Funzionano, sono stabili per almeno 50 ore nelle condizioni operative reali (pH quasi neutro, ambiente carbonato) e sono basati su un materiale molto più abbondante ed economico.
Certo, c’è ancora spazio per migliorare. La tensione richiesta è ancora più alta rispetto all’Iridio, un problema legato alla conducibilità intrinseca del Co3O4. Ottimizzare ulteriormente la morfologia iniziale o drogare la struttura cristallina con altri metalli potrebbero essere le prossime mosse per abbassare questa tensione, magari depositando anche meno materiale.
Ma il messaggio chiave è forte e chiaro: è possibile trovare alternative valide, non nobili e più sostenibili economicamente all’Iridio. Il metodo di sintesi che abbiamo usato è scalabile, aprendo potenzialmente la strada all’applicazione industriale di questa tecnologia. Un piccolo passo per il nostro laboratorio, ma speriamo un grande passo per rendere l’elettrolisi della CO2 una realtà su larga scala!
Fonte: Springer