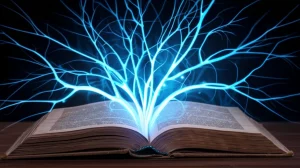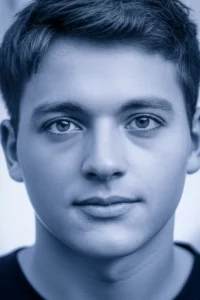Sentirsi Parte del Gruppo: Come Misuriamo Davvero l’Integrazione Sociale a Scuola con il Nuovo SSI 3-4?
Ciao a tutti! Avete presente quella sensazione, quando si è bambini, di sentirsi davvero parte di un gruppo, capiti, apprezzati? Ecco, quella è l’integrazione sociale autopercepita (SSI, per gli amici), ed è una cosa serissima. Non è solo un “sentirsi bene”, è un bisogno psicologico fondamentale, come bere o dormire, che ci portiamo dietro per tutta la vita, in ogni cultura. Se questo bisogno non viene soddisfatto, possono nascere un sacco di problemi, anche a livello psicologico. Per questo, capire come funziona e come migliorarla, soprattutto a scuola, è una missione cruciale per chi si occupa di educazione.
Il Vecchio Modo di Vedere le Cose: Un Po’ Limitato
Fino a poco tempo fa, quando noi ricercatori volevamo capire come si sentisse uno studente integrato nella sua classe, usavamo spesso questionari un po’… sempliciotti. Immaginateveli come occhiali con una sola lente: vedevano qualcosa, certo, ma non tutte le sfumature. Questi strumenti, detti unidimensionali, erano rapidi da compilare – poche domande e via – ma ci davano un quadro limitato. Non riuscivano a scomporre l’integrazione sociale in tutti i suoi pezzettini, nelle sue diverse “sfaccettature”. E questo è un bel problema se, per esempio, vogliamo aiutare studenti con bisogni educativi speciali o con difficoltà comportamentali, che magari si sentono meno integrati dei loro compagni.
Arriva l’Innovazione: Vi presento l’SSI 3-4!
Ed è qui che entro in gioco io, o meglio, il nostro team di ricerca! Ci siamo detti: “E se provassimo a creare uno strumento più completo, più ‘multidimensionale’, per misurare come i bambini delle elementari (terza e quarta, per la precisione) vivono la loro integrazione sociale?”. Così è nato il Fragebogen zur multifaktoriellen Messung der SSI (SSI 3-4), un nome un po’ complicato in tedesco, ma che significa semplicemente “Questionario per la misurazione multifattoriale dell’integrazione sociale autopercepita per le classi 3-4”. Con i suoi 24 item (le “domande”, per intenderci), è un po’ più lungo dei vecchi test, ma la sua forza sta proprio nel riuscire a dipingere un quadro molto più dettagliato.
Ma cos’è esattamente questa integrazione sociale autopercepita? In parole povere, è come uno studente sente di essere parte del gruppo classe. Non stiamo parlando delle amicizie strette con uno o due compagni, quelle sono un’altra cosa, ma proprio della sensazione di essere “dentro” l’intera classe.
Come Abbiamo Costruito il Nostro “Super-Questionario”
Creare un questionario del genere non è come scrivere la lista della spesa. È un lavoro che richiede metodo e pazienza. Abbiamo iniziato spulciando tutta la letteratura scientifica esistente, cercando definizioni, vecchi questionari, qualsiasi cosa potesse darci un’idea delle possibili “sotto-dimensioni” dell’integrazione sociale. Pensate che, inizialmente, non c’erano teorie chiarissime su quali fossero queste sotto-dimensioni. Era un po’ come navigare a vista.
Abbiamo raccolto un bel po’ di item da strumenti già esistenti, sia in tedesco che in inglese (traducendoli, ovviamente). Alcuni erano illustrati, e li abbiamo trasformati in domande scritte, più adatte. L’obiettivo era avere un “calderone” di possibili domande da cui partire. All’inizio ne avevamo ben 133! Poi, eliminando i doppioni e quelle meno chiare, siamo scesi a 63. Tutte queste domande sono state formulate pensando ai bambini delle elementari, quindi con un linguaggio semplice e riferendosi sempre al “gruppo dei compagni”. La scala di risposta era semplice: da “non è vero per niente” a “è proprio vero”.

Il nostro lavoro si è svolto in due fasi principali, due “studi”.
Studio 1: Alla Scoperta dei Fattori Nascosti
Nel primo studio, abbiamo coinvolto 617 studenti di terza e quarta elementare. Abbiamo dato loro il nostro “calderone” di 63 item e poi abbiamo usato una tecnica statistica chiamata analisi fattoriale esplorativa (EFA). Immaginatela come un setaccio che ci aiuta a raggruppare le domande che “parlano” della stessa cosa, che misurano aspetti simili dell’integrazione. È un po’ come mettere ordine in una stanza piena di giocattoli, dividendoli per tipo.
Dopo un bel po’ di calcoli e riflessioni (perché i numeri da soli non bastano, serve anche il buon senso per interpretare i risultati!), siamo riusciti a identificare sei “famiglie” di item, sei dimensioni distinte e significative dell’integrazione sociale autopercepita. Ognuna di queste dimensioni è rappresentata da quattro item specifici. Eccole qui:
- Riconoscimento e Apprezzamento: quanto mi sento lodato e valorizzato dai miei compagni (es. “I miei compagni mi fanno i complimenti”).
- Interazione Negativa ed Esclusione Sociale: quanto subisco comportamenti negativi o mi sento escluso (es. “I miei compagni parlano male di me”).
- Contatto Extrascolastico: quanto frequento i miei compagni anche fuori da scuola (es. “I miei compagni vengono a casa mia o io vado a casa loro”).
- Apertura di Sé e Supporto Emotivo: quanto mi confido e ricevo sostegno emotivo (es. “Parlo con i miei compagni di cose personali”).
- Simpatia e Benessere: quanto mi sento a mio agio e provo simpatia con i miei compagni (es. “Mi sento bene con i miei compagni”).
- Supporto Scolastico: quanto ricevo aiuto dai compagni nelle attività didattiche (es. “Se non capisco qualcosa, i miei compagni mi aiutano”).
Studio 2: La Prova del Nove
Avere identificato queste sei dimensioni era già un gran passo avanti, ma dovevamo essere sicuri che questa struttura a sei fattori fosse solida. Così, abbiamo condotto un secondo studio, coinvolgendo altri 666 studenti, sempre di terza e quarta. Questa volta, abbiamo usato l’analisi fattoriale confermativa (CFA). Se l’EFA è come esplorare un territorio sconosciuto per fare una mappa, la CFA è come usare quella mappa per vedere se il territorio è davvero come lo avevamo disegnato. Ebbene, i risultati hanno confermato la bontà del nostro modello a sei fattori! I dati “calzavano” bene con la nostra ipotesi.
Non ci siamo fermati qui. Volevamo capire ancora meglio la struttura dell’SSI. Abbiamo confrontato diversi modelli: uno con un solo fattore generale, il nostro a sei fattori, uno più complesso detto “di secondo ordine” e, infine, un modello bi-fattoriale. Quest’ultimo modello prevede un “super-fattore” globale di integrazione sociale (quanto mi sento integrato in generale) e, contemporaneamente, i nostri sei fattori specifici. Indovinate un po’? Il modello bi-fattoriale è risultato il migliore! Questo significa che l’SSI 3-4 può darci sia un punteggio generale di integrazione, sia punteggi specifici per ognuna delle sei dimensioni. Una flessibilità niente male!
Ma Funziona Davvero? La Validità del Questionario
Ok, abbiamo una bella struttura, ma il nostro SSI 3-4 misura davvero quello che dice di misurare? E come si relaziona con altri concetti importanti, tipo l’accettazione da parte dei compagni? Per rispondere, abbiamo confrontato i punteggi del nostro questionario con quelli di altri due test già noti e validati per misurare l’integrazione sociale (il PIQ e il FEESS 3-4) e con una misura dell’accettazione sociale ottenuta chiedendo ai bambini quanto volentieri si sederebbero vicino a ciascun compagno (un rating sociometrico).
I risultati sono stati confortanti: tutte le nostre sei scale (e il fattore globale) hanno mostrato correlazioni da medie a forti con gli altri due questionari sull’integrazione. Questo ci dice che stiamo misurando qualcosa di molto simile, il che è un buon segno! Le correlazioni con l’accettazione sociale da parte dei compagni erano più deboli, ma comunque significative, come ci aspettavamo. È interessante notare che, anche se abbiamo “girato” le domande negative (tipo “i compagni parlano male di me”) per l’analisi, le correlazioni sono risultate positive, indicando che una minore interazione negativa corrisponde a una maggiore integrazione. Tutto torna!

Le nostre analisi hanno anche mostrato che gli item sono “robusti”: hanno una buona capacità discriminante (cioè, distinguono bene chi si sente più integrato da chi meno) e le scale hanno una buona consistenza interna (cioè, gli item di una stessa scala misurano davvero lo stesso costrutto). Il fattore globale sembra spiegare la maggior parte della varianza, ma anche i sottofattori, specialmente “Interazione Negativa ed Esclusione Sociale” e “Contatto Extrascolastico”, aggiungono informazioni preziose.
Cosa Ci Dice Tutto Questo? Implicazioni e Curiosità
Una cosa che mi ha particolarmente colpito è la somiglianza tra le nostre sei dimensioni e quelle di un questionario americano molto famoso, il Friendship Quality Questionnaire (FQR) di Parker e Asher, che però misura la qualità delle amicizie diadiche (cioè tra due persone). Anche se il nostro SSI 3-4 guarda all’integrazione nel gruppo classe intero, le tematiche sono sorprendentemente simili: riconoscimento, conflitto, aiuto, compagnia… Questo suggerisce che questi aspetti dell’esperienza sociale potrebbero essere importanti e distinguibili un po’ ovunque, non solo da noi!
Confrontando l’SSI 3-4 con gli strumenti tedeschi già esistenti, abbiamo notato che la nostra scala “Simpatia e Benessere” è quella che si avvicina di più a ciò che misurano il PIQ e il FEESS 3-4. Sembra che questi strumenti si concentrino molto su questo aspetto. Invece, la nostra scala “Contatto Extrascolastico” è quella che mostra le correlazioni più basse (seppur medie) con loro, indicando che il nostro questionario riesce a cogliere una sfumatura dell’integrazione che gli altri forse trascurano un po’ di più.
La scala “Riconoscimento e Apprezzamento” ha una forte eco con il concetto di “riconoscimento” del filosofo Honneth. Ha senso: sentirsi riconosciuti e apprezzati dai compagni è una fetta importante del sentirsi integrati. Dopotutto, come dicono Deci e Ryan (due pezzi grossi della psicologia), l’appartenenza sociale non riguarda solo quanto gli altri sono importanti per noi, ma anche quanto noi siamo importanti per gli altri.
Limiti? Certo, Ogni Ricerca Ne Ha!
Ora, non voglio vendervi fumo. Ogni ricerca ha i suoi “se” e i suoi “ma”, e anche il nostro studio sull’SSI 3-4 non fa eccezione.
- Primo, abbiamo testato il questionario solo su bambini di terza e quarta elementare. Sarebbe bello vedere se funziona altrettanto bene con bambini più piccoli o più grandi. Magari i più piccoli percepiscono l’integrazione in modo meno sfaccettato, o i più grandi in modo ancora più complesso! Pensate che abbiamo usato solo il 38% degli item che avevamo all’inizio; chissà cosa c’è nel restante 62%…
- Secondo, non abbiamo verificato la stabilità nel tempo dei punteggi (la cosiddetta affidabilità test-retest). Non sappiamo, quindi, quanto “ferme” siano queste misurazioni se ripetute dopo un po’.
- Terzo, per quanto ci siamo sforzati di raccogliere tutti gli item possibili, non possiamo escludere di averne tralasciato qualcuno di importante.
- Quarto, la scala “Interazione Negativa ed Esclusione Sociale” è composta solo da item negativi. Questo potrebbe aver introdotto qualche “effetto metodologico” nelle analisi, anche se abbiamo cercato di tenerne conto.
In Conclusione: Un Passo Avanti per Capire (e Migliorare) l’Integrazione
Nonostante questi piccoli nei, crediamo che l’SSI 3-4 sia uno strumento prezioso. Offre una misurazione dell’integrazione sociale autopercepita più dettagliata e sfaccettata, basata su sei dimensioni chiare, plausibili e misurabili in modo economico. I nostri risultati sottolineano che l’integrazione sociale è un costrutto multidimensionale e forniscono una base solida per future ricerche in ambito scolastico.
E, cosa non da poco, l’SSI 3-4 potrebbe essere usato per identificare più precisamente i fattori che favoriscono una buona integrazione sociale. Questo, a sua volta, potrebbe aiutarci a sviluppare interventi pedagogici sempre più mirati ed efficaci per far sì che ogni bambino si senta davvero “parte del gruppo”. E questo, lasciatemelo dire, è un obiettivo per cui vale davvero la pena lavorare! Ah, dimenticavo, l’SSI 3-4 è disponibile gratuitamente con licenza CC-BY, quindi chiunque voglia usarlo per la ricerca o nella pratica, può farlo!
Fonte: Springer