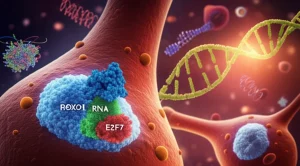Michael Tonry: Basta Muri! Apriamo le Finestre sulla Giustizia Penale Globale
Sapete, a volte mi sembra che viviamo tutti un po’ chiusi nel nostro orticello, convinti che il nostro modo di fare le cose sia l’unico, o quantomeno il migliore. Questo vale per tante cose, ma quando si parla di giustizia penale, e in particolare di come uno Stato decide di punire chi sbaglia, beh, la faccenda si fa seria. E qui entra in gioco una figura che, per me, è stata una vera e propria boccata d’aria fresca: Michael Tonry. Un nome che forse non dirà molto ai più, ma che nel mondo della criminologia e della riforma penale pesa come un macigno, soprattutto per chi, come lui, ha cercato di scardinare una certa mentalità un po’ troppo… americana.
L’Eccezionalismo Americano Sotto la Lente
Parliamoci chiaro: gli Stati Uniti, in fatto di politica penale, hanno spesso seguito una strada tutta loro, un percorso che Tonry non ha esitato a definire “parrocchiale”. Immaginate un sistema che tende a essere eccezionalmente punitivo, a volte con venature razziste e una certa disinvoltura storica rispetto alle regole. Ecco, Tonry ha passato una vita a guardare oltre questi confini, cercando di capire perché il sistema di condanne americano fosse così, diciamo, disfunzionale e, soprattutto, come si potesse riformarlo. Non è un caso che fin dagli anni ’70, dopo la laurea a Yale, e poi con la sua rivista “Overcrowded Times” (un nome che è tutto un programma, “Tempi di Sovraffollamento”), abbia iniziato a tessere una rete di collaborazioni internazionali. Voleva sentire voci diverse, dall’Europa al Giappone, passando per Australia e Canada. Perché, mi chiedo, un accademico americano dovrebbe guardare fuori quando il suo paese è spesso visto come un modello (o un anti-modello, a seconda dei punti di vista) nel campo penologico? Forse, come ipotizzo, c’entra l’influenza di figure come Norval Morris, uno studioso australiano che ha lasciato il segno anche a Chicago, dove Tonry ha lavorato con lui. O forse, più semplicemente, era un profondo fastidio per quella che lui vedeva come la punitività, il razzismo e l’illegalità intrinseca nel sistema americano.
Tonry criticava apertamente l’asimmetria negli scambi di politiche penali: mentre gli USA sembravano impermeabili a sanzioni più umane ed economicamente vantaggiose come i lavori socialmente utili o le multe giornaliere (comuni in Europa), esportavano con disinvoltura leggi del tipo “tre colpi e sei fuori”, i famigerati “boot camp” e la “verità nella condanna”. Un vero peccato, secondo lui, vedere queste pratiche attecchire, seppur in forme attenuate, in altri paesi anglofoni.
Oltre i Confini: La Ricerca Comparata Come Faro
Se credi davvero nel tuo lavoro e hai una visione per un mondo migliore, non puoi restare chiuso nel tuo studio. Devi diventare quello che potremmo chiamare un “imprenditore accademico della politica”. E Michael Tonry, lasciatemelo dire, è uno dei migliori esempi degli ultimi cinquant’anni. Una persona capace di muoversi con agilità tra il mondo accademico e quello delle politiche pubbliche, costruendo reti, capendo le dinamiche di potere e usando tutto questo per sviluppare e comunicare proposte di riforma. Come si fa a diffondere idee innovative sulle riforme delle condanne? Beh, un modo sono le conferenze internazionali. Tonry ne è stato un grandissimo sostenitore. Ricordo la prima, a Bristol nel 1993, dove si sottolineò come ci fossero lezioni da imparare oltre i confini nazionali per migliorare i propri sistemi ed evitare errori già commessi da altri. Fu lì che Anthony Bottoms coniò il termine, tristemente famoso, di “punitività populista”.

E poi ci sono state altre conferenze importanti, come quella all’Università del Minnesota nel 1998, che riunì studiosi da mezzo mondo per confrontare sistemi sanzionatori e capire se pratiche efficaci in un paese potessero essere adottate altrove. E ancora Glasgow nel 1999, Victoria in Australia nel 2005, Minneapolis, Bologna nel 2014, Haifa nel 2018… un vero e proprio pellegrinaggio della conoscenza comparata! Ma non basta. L’editoria è un altro strumento potentissimo. Dal 1979, Tonry ha curato i 53 volumi di “Crime and Justice: A Review of Research”. E fin dall’inizio, l’obiettivo era chiaro: “sfuggire al parrocchialismo che caratterizzava gran parte delle scienze sociali americane”. Voleva che la rivista fosse comparativa e internazionale. All’inizio, un quarto degli autori proveniva da fuori gli USA; negli ultimi anni, quasi la metà. E non si è limitato a questo: ha pubblicato su riviste europee, britanniche, tedesche, polacche, sudafricane, estendendo il suo pubblico ben oltre i confini americani. Ha messo il suo corpo dove metteva la sua bocca, ricoprendo incarichi nel Regno Unito, in Germania, Svizzera, Paesi Bassi. Un impegno costante e profondo.
Principi Fondamentali per una Giustizia Migliore
La battaglia di Tonry contro il parrocchialismo penale americano si basa su alcuni pilastri. Primo: le condanne contano. Le politiche penali, diceva, “comprendono i valori fondamentali della libertà dalla paura e dal danno e il diritto di essere lasciati soli… L’autorità dello Stato di esercitare potere sui cittadini in nome dell’applicazione della legge o della prevenzione del crimine incide e spesso diminuisce l’autonomia e la libertà dei cittadini”. Non è una cosa da poco. Secondo: ha un’idea chiara di come dovrebbe essere un sistema di condanne ideale, o almeno migliore di quello attuale. Dovrebbe essere coerente, razionale, logico ed equo, basato su principi, imparziale, efficace ma misericordioso e “coerente con i diritti umani e le libertà, competente nella deterrenza del crimine, nella definizione di standard minimi di comportamento e [tendere a] una migliore protezione della società dai suoi predatori umani”. Dovrebbe basarsi sulle migliori prove disponibili e preoccuparsi dell’uguaglianza e della dignità umana. Era molto critico sulla mancanza di dignità nelle carceri statunitensi e sul fallimento degli Stati Uniti nel ratificare le convenzioni ONU. Particolarmente sferzante era il suo giudizio sull’interpretazione restrittiva dell’Ottavo Emendamento (quello che vieta punizioni crudeli e inusuali), che ha permesso la pena di morte per minori e persone con disabilità intellettive. E la mancata affermazione del principio di proporzionalità nella condanna da parte della Corte Suprema era per lui particolarmente irritante. Fondamentalmente, sosteneva, la riforma penale è una questione di moralità tanto quanto di criminologia: “È chiaro che cambiamenti fondamentali avverranno solo quando una massa critica di opinione convergerà nel ritenere che le leggi americane sulle condanne, la severità delle condanne e l’incarcerazione di massa siano moralmente ingiustificabili”.

Le Radici del Problema Americano
Terzo pilastro: crede fermamente nell’importanza della ricerca comparata, affinché i paesi possano imparare dalle reciproche esperienze. E quando Tonry parla di ricerca comparata, intende progetti empirici seri, con misure e strumenti comuni tra due o più paesi, applicando confronti sistematici. Non semplici “visite personali, aneddoti, storie di guerra e sentito dire”. Certo, la ricerca comparata ha un valore di curiosità, ma ha anche un valore utilitaristico. Confrontare i tassi di incarcerazione, ad esempio, solleva la questione di quale sia un tasso “normale” e quale eccezionale. La relazione tra pratiche di condanna e tassi di criminalità può darci un’idea dell’efficacia relativa di diverse sanzioni. I confronti potrebbero permettere di capire se si possono ottenere livelli equivalenti di controllo sociale con mezzi meno costosi o più “umani”. La sua speranza era che le pressioni della comunicazione di massa, dell’economia globale e dell’emergere dell’inglese come lingua mondiale potessero ridurre le differenze tra i paesi occidentali. Finora, un’aspirazione non realizzata. Gli USA restano un caso a sé, e gli altri paesi anglofoni variano a seconda del partito al potere. Le differenze abissali tra USA e Canada, ad esempio, sono state per lui un continuo oggetto di studio.
Ma perché gli Stati Uniti sono così “eccezionali” e refrattari a imparare dagli altri? Tonry ha identificato diverse ragioni:
- La politica penale statunitense è profondamente ideologica e partigiana, dove simbolismo e ideologia contano più della sostanza.
- La cultura penale e l’atteggiamento verso la punizione sono molto più severi rispetto ai paesi di confronto.
- Lo “stile paranoico” della politica americana, che vede il dissenso come male da sradicare con ogni mezzo.
- Il fondamentalismo protestante, che giustifica crociate moralistiche contro droghe, crimine, aborto, ecc.
- Una struttura costituzionale datata che ha politicizzato la giustizia penale (elezione di giudici e procuratori).
- La storia delle relazioni razziali: schiavitù, leggi Jim Crow, linciaggi, discriminazione hanno alimentato disparità.
- La forte dipendenza dalle negoziazioni di patteggiamento.
- Una mancanza di fiducia nei funzionari pubblici, che porta a voler limitare la discrezionalità giudiziaria.
In sintesi, per Tonry, la differenza tra i sistemi anglosassoni/americani e quelli europei è tra un modello di responsabilità democratica (che si traduce in prevenzione del crimine, denuncia e politicizzazione) e un modello di giustizia sostanziale (proporzionalità, coerenza, reintegrazione e riabilitazione).

Sguardi al Sud e all’Est del Mondo: Un Orizzonte da Esplorare
Tuttavia, i problemi di condanna non sono solo una questione del “Primo Mondo”. Il lavoro di Tonry si è concentrato principalmente su quello che oggi chiamiamo il Nord Globale (paesi anglofoni ed europei). Ma, come giustamente sottolineano diversi studiosi, c’è un bisogno urgente di andare oltre questi confronti e di esaminare le politiche penali del cosiddetto Sud Globale (Africa, America Latina, Sud-Est Asiatico) o dell’Est Globale (Europa Orientale, Asia Centrale), dove vive la maggioranza della popolazione mondiale. Finora, molta ricerca in queste aree si è concentrata su come applicare idee “occidentali” (come le commissioni per le condanne) a contesti diversi. La sfida, però, è più grande: non solo applicare, ma sviluppare nuove teorie basate su idee e pratiche non occidentali. Certo, ci sono ostacoli, come la barriera linguistica (molta ricerca è pubblicata solo in inglese) e la necessità di mettere in discussione le tradizionali costruzioni di giustizia, esaminando le eredità del colonialismo, della schiavitù e della disuguaglianza globale. Serve, insomma, una vera e propria “decolonizzazione” della criminologia, che dia voce alla “periferia” e non solo ai centri di potere ideologico tradizionali.
L’Eredità di Tonry: Un Faro per il Futuro
Lo stile di Tonry è inconfondibile. Ha una capacità sorprendente di identificare e analizzare chiaramente il problema, sintetizzare una vasta quantità di materiale, presentare prove empiriche, identificare opzioni politiche preferibili e, alla fine, offrire prescrizioni pratiche. Il tutto con umiltà, introspezione e un’immensa empatia per sistemi diversi dal suo. È anche realista: sa che le innovazioni ambiziose spesso falliscono più che avere successo. Come osserva, “le giurisdizioni che rifiutano di imparare dalle esperienze altrui sono condannate a ripetere i loro errori”. Cosa possiamo imparare dal suo lavoro?
- L’importanza di un impegno verso i valori fondamentali che dovrebbero sostenere qualsiasi sistema di giustizia penale.
- Il valore della collaborazione, della collegialità e di una mente aperta a visioni diverse.
- La consapevolezza che la strada per la riforma può essere lunga e difficile.
- L’importanza di aderire ai più alti standard di erudizione.
Oggi Michael Tonry vive a Bagnaia, sull’Isola d’Elba. Un luogo che evoca Napoleone, ritiratosi lì dopo la sua prima abdicazione. È lontano da Castine, Maine, ma Tonry non è affatto “in pensione”. Con una reputazione napoleonica (anche se non per la statura fisica!), continua a dominare il panorama della riforma penale. E come il Codice Napoleonico, la sua prodigiosa produzione continuerà a influenzare studiosi e politici per i decenni a venire. E spero che, grazie a figure come lui, riusciremo sempre più ad abbattere i muri del provincialismo e ad aprire le finestre su un mondo di giustizia più informato, più equo e, oserei dire, più umano.

Fonte: Springer