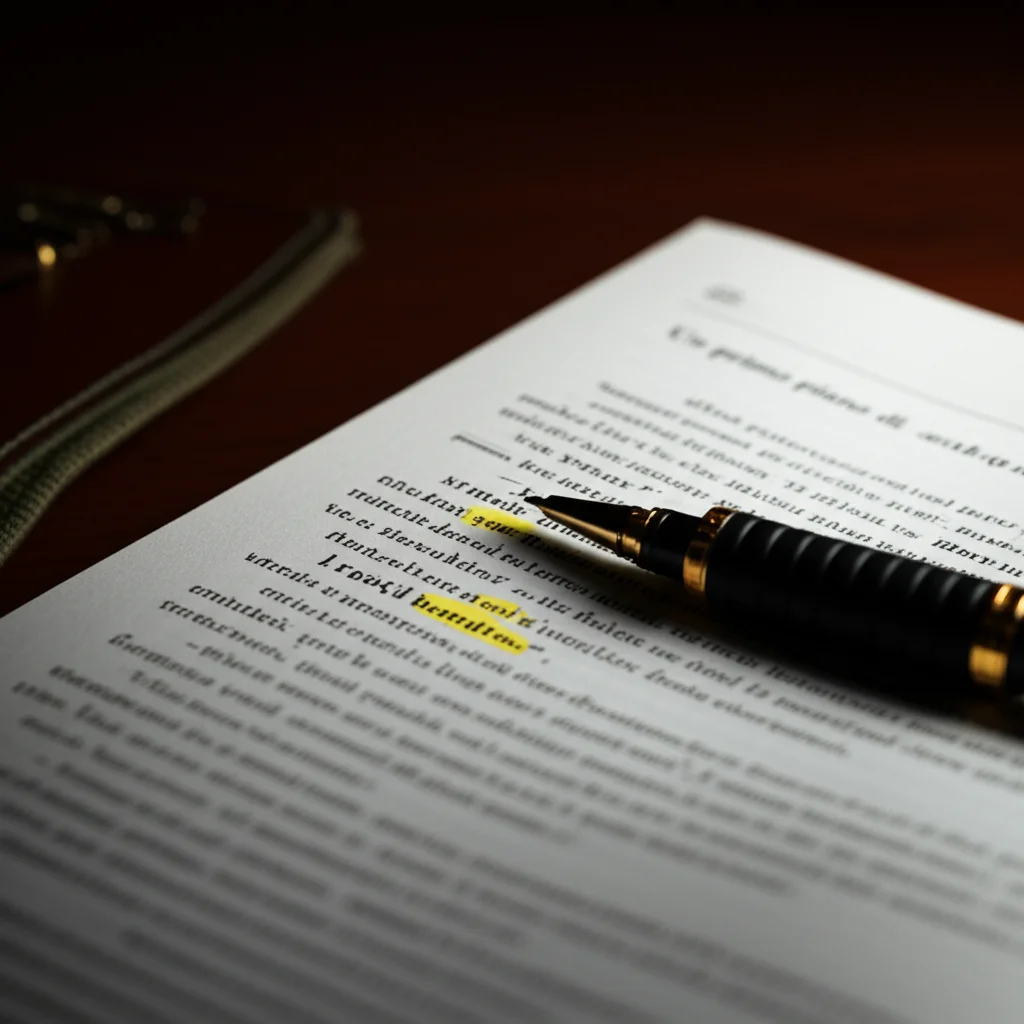I Mattoncini Nascosti del Linguaggio Giuridico: Come Parlare (e Scrivere) da Vero Avvocato!
Ammettiamolo, il linguaggio giuridico a volte sembra arabo, vero? Quei tomi universitari, pieni di frasi complesse e termini che sembrano usciti da un’altra epoca… un vero incubo, soprattutto per chi si affaccia per la prima volta a questo mondo, che sia uno studente alle prime armi o un giovane professionista formatosi all’estero. Ma se vi dicessi che c’è un “trucchetto”, o meglio, una serie di “mattoncini” linguistici che, una volta capiti, possono semplificarci la vita? Sto parlando dei cosiddetti “lexical bundles”, o aggregati lessicali, e in particolare di quelli che ci aiutano a organizzare il discorso nei testi giuridici accademici.
Recentemente mi sono imbattuto in uno studio affascinante che ha messo sotto la lente d’ingrandimento proprio questi “aiutanti” linguistici. L’obiettivo? Fornire a studenti di giurisprudenza, professionisti del settore e sviluppatori di materiale didattico un vero e proprio inventario di queste espressioni, basato su dati concreti. Immaginate di avere una mappa per navigare la complessità dei testi di legge: ecco, questi “lexical bundles” sono un po’ come le indicazioni stradali più importanti!
Ma cosa sono esattamente questi “Lexical Bundles”?
In parole povere, i “lexical bundles” sono sequenze di tre o più parole che tendono a comparire insieme molto frequentemente in determinati contesti, tipi di testo o discipline. Pensate a espressioni come “sulla base di“, “d’altra parte“, “nel caso di“. Non sono proverbi o modi di dire fissi, ma piuttosto combinazioni preferenziali che gli autori usano, spesso inconsciamente, per strutturare il loro pensiero e guidare il lettore. Sono, come diceva qualcuno, i “mattoni fondamentali del discorso”.
La ricerca in questo campo è vasta e ha toccato diverse discipline, ma il discorso giuridico scritto, soprattutto quello dei manuali universitari, era rimasto un po’ in ombra. Eppure, è proprio lì che si forma la mente del futuro giurista!
L’Indagine sui Testi Giuridici: Metodologia da Detective
Per scovare questi “organizzatori del discorso”, i ricercatori hanno analizzato un corpus enorme: ben 8 milioni di parole tratte da cinquantaquattro manuali universitari di diritto! Un lavoraccio, ve lo assicuro. Hanno poi filtrato queste sequenze di parole usando parametri come la lunghezza (concentrandosi su quelle di quattro parole, le più comuni e significative), la frequenza con cui apparivano, la loro distribuzione attraverso i vari testi e, soprattutto, la loro utilità pedagogica.
L’idea era quella di identificare quelle espressioni che servono specificamente a “organizzare il testo e il significato dei suoi elementi come messaggio o argomentazione”, come ha sottolineato un esperto del settore, Hyland. Insomma, quelle frasi che ci dicono: “attenzione, ora introduco un argomento”, “ora ti presento i risultati”, “ora ti spiego meglio questo concetto”.
Il risultato? Una lista di 144 “lexical bundles” che fungono da organizzatori del discorso. E la cosa interessante è la loro struttura.

La Struttura dei “Mattoncini”: Preposizioni e Nomi la Fanno da Padrone
Sapete cosa è emerso? Che il 90% di questi organizzatori del discorso identificati nello studio sono strutturalmente basati su preposizioni e nomi (ad esempio, “nel contesto di“, “sulla base di“). Solo il restante 10% è costituito da espressioni basate su verbi o altri frammenti. Questo non sorprende più di tanto, perché la prosa accademica tende a preferire strutture frasali (nominali e preposizionali) rispetto a quelle clausali, più dirette.
Pensateci: espressioni come “il fatto che“, “la relazione tra“, “all’inizio di” sono comunissime. E ci sono dei veri e propri “schemi” produttivi, come “nel * di” (che genera “nel caso di“, “nel corso di“) o “il * del” (che genera “la base del“, “l’assenza del“).
Questa predominanza di strutture nominali e preposizionali è probabilmente legata allo scopo comunicativo dei manuali: disseminare conoscenza fattuale in modo elaborato e dettagliato. A differenza, per esempio, degli articoli scientifici, gli autori di testi giuridici devono inquadrare argomentazioni, analizzare casi, spiegare concetti, attingere a leggi e statuti, e presentare spiegazioni in modo accessibile.
Le Funzioni Chiave: A Cosa Servono Davvero?
Lo studio ha anche rivelato che la lista di questi “organizzatori del discorso” è dominata da espressioni che svolgono tre sottofunzioni principali:
- Creare una cornice per le argomentazioni (Framing bundles): Queste sono le più numerose! Servono a situare le argomentazioni specificando condizioni limitanti. Esempi? “il valore del“, “sulla base di“, “nella misura in cui“. Sono fondamentali perché gli autori accademici hanno costantemente bisogno di stabilire connessioni tra proposizioni e fornire spiegazioni dettagliate e specifiche che possano contestualizzare meglio la loro ricerca e renderla più comprensibile al lettore.
- Presentare risultati (Resultative bundles): Queste espressioni marcano relazioni inferenziali o causali tra gli elementi. Pensate a “come risultato di“, “si è riscontrato che“. È interessante notare come queste siano tipiche della scrittura scientifica e tecnologica, ma la loro presenza massiccia nei testi giuridici potrebbe spiegarsi con la necessità degli autori di evidenziare esiti definitivi, una strategia retorica che si allinea con la scrittura scientifica.
- Introdurre un argomento (Topic focus/introduction bundles): Queste aiutano a focalizzare l’attenzione del lettore su agenti, legislazione o informazioni specifiche, oppure a segnalare l’inizio di una nuova sezione del discorso. “per quanto riguarda“, “nel campo di“, “il fatto che il“.
Ovviamente, ci sono anche altre sottofunzioni meno frequenti, come segnalare transizioni (“in aggiunta a“, “d’altra parte“), chiarire condizioni di terminazione, spiegare argomenti rilevanti, articolare eventi concomitanti (“allo stesso tempo“), e molto altro. È un universo linguistico piuttosto ricco!

Perché Tutto Questo è Importante per Noi?
Vi starete chiedendo: “Ok, interessante, ma a me che studio o pratico il diritto, cosa cambia?”. Cambia, e parecchio! Questa lista di “mattoncini” linguistici è una miniera d’oro per diversi motivi:
- Migliora la comprensione: Conoscere queste espressioni ricorrenti aiuta a navigare testi complessi con più sicurezza, perché si impara a riconoscere come l’autore sta strutturando il discorso.
- Potenzia la scrittura: Per gli studenti, soprattutto quelli non madrelingua inglese che studiano in contesti internazionali, o per i giovani professionisti, utilizzare consapevolmente questi “organizzatori” può rendere i propri scritti più chiari, logici, coerenti e, diciamocelo, più “professionali”. Spesso chi è alle prime armi si concentra sul contenuto, trascurando l’organizzazione e la coerenza della presentazione.
- Supporta l’insegnamento: Gli insegnanti di “English for Legal Purposes” (ELP) e gli sviluppatori di materiale didattico possono usare questa lista per creare esercizi mirati, per sensibilizzare gli studenti sull’importanza di queste strutture e per aiutarli a passare da schemi basati prevalentemente su verbi a costruzioni frasali più tipiche del linguaggio accademico.
La ricerca suggerisce che un approccio esplicito all’insegnamento di questi “lexical bundles” è fortemente raccomandato, perché potrebbero facilmente sfuggire all’attenzione degli studenti se lasciati all’apprendimento incidentale. Un modo potrebbe essere l’esposizione ripetuta a schemi target in maniera sistematica. Oppure, si potrebbero usare attività come il “dictogloss modificato”, dove gli studenti leggono un testo e poi cercano di ricostruirlo a memoria, aiutati da una lista di “lexical bundles” target presenti nel testo originale.
Le Sfide del “Legalese”
Non dimentichiamoci che il linguaggio giuridico ha le sue belle gatte da pelare. Termini arcaici come ‘hereinafter’ (d’ora in avanti), parole comuni usate con significati legali specifici (pensate a ‘contempt’ che può significare disprezzo ma in diritto è ‘oltraggio alla corte’), termini di origine latina o francese, frasi lunghissime (una frase legale media può contenere cinquantacinque parole, il doppio rispetto ad altri testi scientifici!) e una sintassi complessa con abbondanza di subordinate e costruzioni nominali. Tutto questo per garantire chiarezza e precisione, ma che fatica per chi legge!
Questo studio sui “lexical bundles” non risolve magicamente tutti questi problemi, ma offre uno strumento concreto per affrontare almeno l’aspetto della struttura e dell’organizzazione del discorso. È un passo avanti per rendere il linguaggio giuridico un po’ meno ostico e più navigabile.
Qualche Piccola Limitazione (Sempre Onesti!)
Come ogni ricerca, anche questa ha i suoi limiti. Assegnare i “bundles” a categorie funzionali distinte non è sempre facile, perché alcune espressioni possono avere più funzioni. Inoltre, i parametri usati per estrarre queste sequenze dai corpora sono, in una certa misura, arbitrari. Tuttavia, il contributo resta significativo.
Insomma, la prossima volta che vi troverete davanti a un testo giuridico che vi sembra un muro invalicabile, ricordatevi di questi “mattoncini”. Cercateli, analizzateli e, perché no, iniziate a usarli anche voi. Potreste scoprire che parlare (e scrivere) da vero avvocato è un po’ più semplice di quanto pensavate!
Fonte: Springer