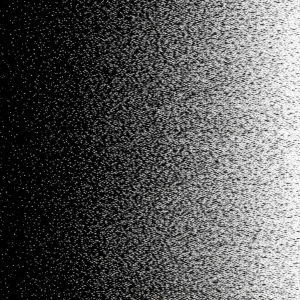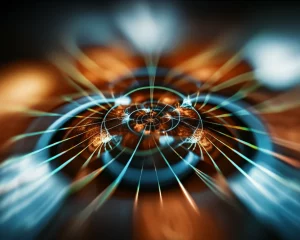Stirare lo Spazio: Alla Scoperta delle Mappe Estremali nel Gruppo Affine-Additivo
Ciao a tutti, appassionati di matematica e geometria! Oggi voglio portarvi con me in un viaggio affascinante all’interno di una struttura matematica particolare: il gruppo affine-additivo. Potrebbe suonare un po’ ostico, ma fidatevi, esplorare come “stirare” e “deformare” questo spazio seguendo regole precise è un’avventura intellettuale davvero stimolante.
Nel mondo della matematica, spesso ci chiediamo come trasformare uno spazio in un altro. A volte cerchiamo trasformazioni “perfette”, come le mappe conformi che preservano gli angoli (pensate alle mappe geografiche, anche se lì è impossibile farlo perfettamente su una superficie piana!). Altre volte, le mappe conformi non esistono o non fanno quello che vogliamo. È qui che entrano in gioco le mappe quasiconformi: sono trasformazioni che possono deformare le forme, ma lo fanno in modo controllato, con una distorsione limitata.
Il nostro obiettivo? Trovare le mappe quasiconformi “migliori” possibili, quelle che minimizzano una certa misura di distorsione, all’interno del gruppo affine-additivo. Queste mappe speciali le chiamiamo mappe estremali. Nello specifico, ci concentreremo su due tipi: le mappe di stiramento lineare e radiale.
Ma cos’è questo Gruppo Affine-Additivo?
Prima di tuffarci nelle mappe, spendiamo due parole su questo “palcoscenico” geometrico. Il gruppo affine-additivo, che indicheremo con ({{mathcal {A}}}{{mathcal {A}}}), è uno spazio tridimensionale che fa parte delle cosiddette geometrie di Thurston. Non è famoso come lo spazio euclideo o anche come il gruppo di Heisenberg (un altro ambiente molto studiato in questo campo), anzi, ha proprietà diverse. Ad esempio, mentre il gruppo di Heisenberg è “conformemente parabolico”, il nostro ({{mathcal {A}}}{{mathcal {A}}}) è conformemente iperbolico. Questa differenza non è banale: significa che le mappe quasiconformi si comportano diversamente nei due spazi.
Dal punto di vista tecnico, ({{mathcal {A}}}{{mathcal {A}}}) è costruito combinando il gruppo additivo dei numeri reali ((mathbb{R}, +)) con un gruppo basato sul semipiano superiore complesso (textbf{H}_{mathbb{C}}^1), dotato di un’operazione (star_0) derivata dalla composizione di trasformazioni affini. La struttura risultante ha una geometria detta sub-Riemanniana: non tutte le direzioni sono “uguali”, ma ci si può muovere solo lungo direzioni “orizzontali” specificate da una forma di contatto (vartheta). La distanza tra due punti (d_{{{mathcal {A}}}{{mathcal {A}}}}) si misura considerando la lunghezza dei cammini orizzontali più corti che li collegano. Esiste anche una misura di volume naturale, (dmu_{{{mathcal {A}}}{{mathcal {A}}}}), che tiene conto di questa struttura particolare.
Mappe Quasiconformi: Stirare con Regole Precise
Una mappa (f) tra due domini (Omega, Omega’) nel nostro gruppo ({{mathcal {A}}}{{mathcal {A}}}) è detta quasiconforme se è un omeomorfismo (cioè continua, invertibile e con inversa continua) e se esiste una costante (H ge 1) tale che la distorsione delle piccole sfere è limitata. Formalmente, si usa la distanza (d_{{{mathcal {A}}}{{mathcal {A}}}}) per definirla:
[ limsup_{rto 0} frac{max_{d_{{{mathcal {A}}}{{mathcal {A}}}}(p,q)=r} d_{{{mathcal {A}}}{{mathcal {A}}}}(f(p),f(q))}{min_{d_{{{mathcal {A}}}{{mathcal {A}}}}(p,q)=r} d_{{{mathcal {A}}}{{mathcal {A}}}}(f(p),f(q))} le H ]
per ogni punto (p in Omega).
Esistono definizioni equivalenti (analitica e geometrica) e queste mappe hanno proprietà interessanti: sono sufficientemente regolari (hanno derivate in un certo senso) e, cosa cruciale, spesso preservano la struttura di contatto, cioè (f^*vartheta = sigma vartheta) quasi ovunque per una qualche funzione (sigma).
Per misurare quanto una mappa quasiconforme si discosta dall’essere conforme (cioè (H=1)), si usa il quoziente di distorsione (K(p,f)). Una mappa è conforme se (K(p,f)=1) quasi ovunque. La distorsione massimale è (K_f = text{ess sup}_p K(p,f)). Noi siamo interessati a minimizzare non solo (K_f), ma anche una distorsione media, definita come (int_Omega K(p,f)^2 rho_0 , dmu_{{{mathcal {A}}}{{mathcal {A}}}}), dove (rho_0) è una “densità” speciale legata alla geometria del problema.

Il Metodo del Modulo e la Proprietà di Stiramento Minimo (MSP): Le Nostre Armi Segrete
Come facciamo a trovare queste mappe estremali? Uno strumento potentissimo è il modulo di una famiglia di curve, (textrm{Mod}_p(Gamma)). Immaginatelo come una misura della “densità” o “spessore” di una famiglia (Gamma) di curve all’interno del nostro spazio. Si definisce tramite un problema variazionale che coinvolge delle “densità ammissibili” (rho). La densità (rho_0) che realizza il minimo in questo problema (l’infimo) è detta densità estremale, ed è proprio quella che useremo nella nostra funzionale di distorsione media.
Un concetto chiave per noi è la Proprietà di Stiramento Minimo (MSP – Minimal Stretching Property). Diciamo che una mappa quasiconforme (f_0) ha la MSP rispetto a una famiglia di curve orizzontali (Gamma_0) se, lungo queste curve, la mappa “stira” lo spazio nella direzione in cui la sua deformazione è la più piccola possibile. Formalmente, questo si traduce in una condizione precisa che lega il differenziale della mappa e il coefficiente di Beltrami (mu_{f_0}) lungo le curve di (Gamma_0).
L’idea geniale, mutuata da lavori precedenti in altri contesti (come il gruppo di Heisenberg), è che se una mappa (f_0) ha la MSP rispetto a una famiglia di curve (Gamma_0) che “foliano” (riempiono) il dominio (Omega), e se la sua distorsione (K(cdot, f_0)) è costante lungo queste curve, allora (f_0) è una candidata ideale per essere estremale per la distorsione media associata alla densità estremale (rho_0) di (Gamma_0). Il Teorema 1.1 del lavoro originale formalizza proprio questo: sotto queste condizioni (e qualche altra ipotesi tecnica), (f_0) minimizza (int_Omega K(p,f)^2 rho_0 , dmu_{{{mathcal {A}}}{{mathcal {A}}}}) all’interno di una classe appropriata di mappe quasiconformi ({mathcal {F}}).
Le Mappe di Stiramento Lineare: Come una Fisarmonica
Vediamo la prima applicazione concreta. Definiamo la mappa di stiramento lineare (f_k) (per (k>0)) nel gruppo affine-additivo ({{mathcal {A}}}{{mathcal {A}}}) semplicemente come:
[ f_k(a, lambda + it) = (a, klambda + it) ]
Notate come agisce solo sulla componente (lambda), stirandola (se (k>1)) o comprimendola (se (k<1)), mentre lascia invariate le altre coordinate cartesiane (a) e (t).
Il bello è che questa mappa, così semplice, risulta essere estremale per la distorsione media! Lo dimostriamo in due scenari diversi, a seconda che (k) sia minore o maggiore di 1.
Caso 1: (k in (0,1)) (Compressione)
Consideriamo un dominio (Omega) a forma di “scatola” definito da (a in (0,1)), (lambda in (1/2, 1)) e (t in (0,1)). La mappa (f_k) lo trasforma nel dominio (Omega^k) dove (lambda in (k/2, k)). Consideriamo la famiglia (Gamma_0) di curve orizzontali che vanno “da sopra a sotto” in (Omega) (variando (t) da 0 a 1, mantenendo (a) e (lambda) fissi). Usando il nostro metodo:
- Calcoliamo la densità estremale (rho_0) per (Gamma_0).
- Verifichiamo che la distorsione (K(p, f_k)) è costante ((=1/k)) ovunque, quindi anche lungo le curve di (Gamma_0).
- Controlliamo che (f_k) soddisfi la MSP per (Gamma_0) (questo funziona proprio perché (k<1)).
- Estendiamo (Gamma_0) a una famiglia (Gamma) più grande (tutte le curve orizzontali che collegano le “facce” (t=0) e (t=1) di (Omega)) per cui (rho_0) è ancora ammissibile.
Il Teorema 1.1 ci garantisce allora che (f_k) minimizza la distorsione media (int_Omega K(p,f)^2 rho_0 , dmu_{{{mathcal {A}}}{{mathcal {A}}}}) tra tutte le mappe quasiconformi (f: Omega to Omega^k) con le stesse condizioni al bordo. In questo caso, si scopre che minimizza anche la distorsione massimale (K_f).

Caso 2: (k > 1) (Stiramento)
Qui la situazione è analoga, ma dobbiamo scegliere un dominio (Omega) e una famiglia di curve (Gamma_0) diversi. Prendiamo (Omega) definito da (a in (0,1)), (lambda in (1/2, 1)) e (t in (0,1)). La mappa (f_k) lo manda in (Omega^k) con (lambda in (k/2, k)). Questa volta, consideriamo la famiglia (Gamma_0) di curve orizzontali che vanno “da sinistra a destra” in (Omega) (variando (a) da 0 a 1, mantenendo (lambda) e (t) fissi). Di nuovo, i passaggi sono simili:
- Calcoliamo la nuova (rho_0).
- La distorsione (K(p, f_k)) è ancora costante ((=k)).
- La MSP vale per (Gamma_0) proprio perché (k>1).
- Estendiamo (Gamma_0) a (Gamma) (tutte le curve orizzontali tra le facce (a=0) e (a=1)).
E di nuovo, il Teorema 1.1 ci dice che (f_k) minimizza la distorsione media, e anche in questo caso, la distorsione massimale. Questo secondo caso è particolarmente interessante perché può essere visto come una soluzione al “problema di Grötzsch” nel contesto del gruppo affine-additivo: trovare la mappa “quasi conforme” che trasforma un “rettangolo” in un altro stirato.
Coordinate Cilindrico-Logaritmiche e Stiramento Radiale
Per definire l’analogo dello stiramento radiale (come (z mapsto |z|^{k-1}z) nel piano complesso), è utile cambiare sistema di coordinate. Introduciamo le coordinate cilindrico-logaritmiche ((a, xi, psi)). L’idea è di usare coordinate polari ((lambda, t) = (e^xi cos psi, e^xi sin psi)) nel semipiano (textbf{H}_{mathbb{C}}^1), mantenendo la coordinata (a). Quindi, la trasformazione (Phi) è:
[ Phi(a, xi, psi) = (a, e^xi cos psi + i e^xi sin psi) ]
In queste coordinate, molte formule (condizione di orizzontalità, misura di volume, campi vettoriali Z e (overline{Z}), coefficiente di Beltrami, condizione MSP) assumono forme diverse, a volte più maneggevoli per certi problemi.
Definiamo ora la mappa di stiramento radiale (f_k) (per (0
Anche questa mappa radiale si rivela estremale per la distorsione media. Lo dimostriamo considerando domini a forma di “guscio cilindrico troncato”, (D_{r_0, psi_0}), definiti in coordinate cilindrico-logaritmiche da (a in (0,1)), (xi in (0, log r_0)) e (psi in (0, psi_0)) (con (r_0>1, 0 Il Teorema 1.1 si applica di nuovo, e concludiamo che (f_k) minimizza la distorsione media (int_{D_{r_0,psi_0}} K(p,f)^2 rho_0 , dmu_{{{mathcal {A}}}{{mathcal {A}}}}) nella classe ({mathcal {F}}_k) di mappe quasiconformi (f: D_{r_0,psi_0} to D^k_{r_0,psi_0}) con le giuste condizioni al bordo. Un’ultima osservazione interessante. Abbiamo dimostrato che le mappe di stiramento lineare e radiale minimizzano la distorsione media. Per le mappe lineari, questo implicava anche la minimizzazione della distorsione massimale (K_f). Ma per la mappa radiale, le cose sono più sottili. A causa della dipendenza della distorsione da (psi), non è detto che minimizzare la media implichi minimizzare il massimo. Infatti, i calcoli mostrano che per certi valori di (psi_0), la mappa radiale (f_k) probabilmente non minimizza la distorsione massimale (K_f) all’interno della classe ({mathcal {F}}_k). Stabilire se lo faccia o meno rimane una questione aperta. Ecco, spero che questo tuffo nel gruppo affine-additivo e nelle sue mappe di stiramento vi abbia incuriosito. È un esempio di come la matematica esplori strutture geometriche diverse da quelle a cui siamo abituati, usando strumenti potenti come il metodo del modulo per capire le trasformazioni ottimali. C’è sempre qualcosa di nuovo da scoprire quando si inizia a “stirare” lo spazio! Fonte: Springer Una Domanda Aperta: C’è Ancora da Scoprire!