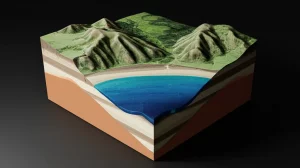Marocco Segreto: A Caccia di Tesori Nascosti con Occhi Satellitari nell’Atlante
Ciao a tutti! Oggi voglio portarvi con me in un’avventura affascinante, un viaggio tra tecnologia spaziale e geologia antica, nel cuore del Marocco. Immaginate di poter scrutare sotto la superficie terrestre, non con un piccone, ma con potentissimi occhi elettronici che orbitano sopra le nostre teste. È un po’ quello che ho fatto, usando il telerilevamento per esplorare una zona remota e ricca di promesse: l’inlier di Mougueur, nell’Alto Atlante Orientale.
Questa regione è un pezzo della catena Ercinica, formatasi nell’era Paleozoica, un libro di storia geologica a cielo aperto. Ma non è solo storia antica: è anche un potenziale scrigno di risorse minerarie, in particolare vene ricche di carbonati come siderite e ankerite, e associazioni di zinco-piombo (Zn-Pb), a volte accompagnate da ferro, rame e magnesio. Il problema? Esplorare queste aree montuose e vaste con metodi tradizionali è lento, costoso e faticoso. Ed è qui che entra in gioco la magia del telerilevamento!
L’Atlante Orientale: Un Tesoro Geologico Nascosto
L’Alto Atlante Orientale (EHA) è una regione montuosa di una complessità geologica pazzesca, nota da tempo per le sue risorse minerarie. Si estende per decine di chilometri ed è stata plasmata da ere di processi tettonici e sedimentari (Paleozoico, Mesozoico, Cenozoico). Questa storia turbolenta ha favorito la formazione di diversi giacimenti minerari, rendendo l’EHA un’area super interessante per l’industria estrattiva.
I metalli più preziosi qui sono piombo, zinco, rame e argento, spesso presenti in vene o masse stratiformi associate a rocce sedimentarie e vulcaniche. Sono i processi idrotermali – la circolazione di fluidi caldi e carichi di minerali nella crosta terrestre – i veri “artisti” che hanno concentrato questi metalli. Alcuni studi precedenti hanno già suggerito che questi depositi assomigliano a quelli di tipo Mississippi Valley (MVT) e che le grandi fratture nella roccia (i lineamenti strutturali) giocano un ruolo chiave nel controllare dove si trovano le mineralizzazioni. Si parla di strutture con direzioni principali N-S, NE-SW e NW-SE. Inoltre, la presenza di rocce intrusive (gabbri, sieniti) legate a processi magmatici e idrotermali è un altro indizio importante. Ma nonostante decenni di esplorazione, c’è ancora tanto da scoprire, soprattutto usando tecnologie moderne.
Occhi dal Cielo: La Magia del Telerilevamento
Come fare, quindi, a mappare in dettaglio strutture geologiche e zone alterate da fluidi idrotermali su aree così vaste e impervie? La risposta sta nei satelliti! Per questa ricerca, ho utilizzato principalmente i dati di due “occhi” speciali:
- ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer): Un sensore sofisticato con 14 bande spettrali (dal visibile all’infrarosso termico) che permette di “vedere” la composizione chimica delle rocce e dei minerali sulla superficie. Ha risoluzioni spaziali diverse (15m, 30m, 90m).
- Landsat 8 OLI (Operational Land Imager): Un altro cavallo di battaglia del telerilevamento, ottimo per mappare le strutture geologiche grazie alla sua risoluzione e alle sue bande nel visibile e infrarosso.
Il bello di questa zona del Marocco è il clima semi-arido, la scarsa vegetazione e le rocce ben esposte: condizioni ideali per il telerilevamento! L’idea era semplice ma potente: usare le “firme” spettrali uniche che i minerali lasciano quando interagiscono con la luce solare (riflessa e riemessa) per mappare le zone di alterazione idrotermale (indizio di possibile mineralizzazione) e le strutture tettoniche (le “autostrade” per i fluidi mineralizzanti).
Caccia alle Tracce: Lineamenti e Alterazioni
Il primo passo è stato cercare le “cicatrici” della Terra: i lineamenti. Utilizzando un algoritmo specifico (nel software Geomatica) applicato alle immagini Landsat 8, ho estratto automaticamente tutte le caratteristiche lineari visibili. Poi, con un po’ di “pulizia” manuale (eliminando fiumi, strade, confini geologici non strutturali) e confrontando con mappe topografiche e geologiche esistenti, ho ottenuto una mappa delle fratture e faglie potenzialmente significative dal punto di vista strutturale. L’analisi statistica di questi lineamenti (usando i diagrammi a rosa) ci dice quali sono le direzioni preferenziali di fratturazione della crosta in quell’area.

Il secondo passo, cruciale, è stato mappare l’alterazione idrotermale usando i dati ASTER, in particolare le bande nell’infrarosso a onde corte (SWIR), molto sensibili alla composizione minerale. Ho usato due approcci principali:
- Band Ratio (Rapporti tra Bande): Combinando matematicamente diverse bande spettrali, si possono esaltare specifici minerali o gruppi di minerali. Ho calcolato indici per evidenziare la presenza di ossidi di ferro (come nel “cappellaccio” superficiale dei depositi, il gossan), minerali argillosi, carbonati-clorite-epidoto (tipici di alterazioni propilitiche) e quarzo (spesso associato a vene mineralizzate).
- Analisi Spettrale: Ho confrontato gli spettri misurati dal satellite con quelli di minerali noti presenti in librerie spettrali di laboratorio (come la libreria ASTER), per identificare con più precisione i minerali di alterazione presenti.
L’obiettivo era trovare le zone dove questi segnali di alterazione si concentravano, specialmente in corrispondenza delle strutture tettoniche identificate.
Mappe Parlanti: Cosa Abbiamo Scoperto a Mougueur
E i risultati? Davvero affascinanti! L’analisi dei lineamenti ha rivelato che l’area è intensamente fratturata, come ci aspettavamo. Le direzioni dominanti vanno da NE-SW a SE-NW, ma la direzione ENE-WSW (N80) è risultata la più frequente (ben il 42% dei lineamenti!). Queste direzioni sono state confermate anche dalle osservazioni sul campo, dove abbiamo visto faglie associate a mineralizzazioni di rame. Le aree con la maggiore densità di lineamenti sono risultate essere Tit N’ali, Tamelahl, la zona ovest di Talharite e Tijane.
La mappatura dell’alterazione idrotermale con ASTER ha dato risultati altrettanto interessanti.
- L’indice del Gossan (b4/b2) ha mostrato allineamenti e macchie concentrate, spesso lungo corridoi strutturali.
- L’indice Dolomite-clorite-epidoto ((b5+b7)/b6) ha evidenziato zone ben sviluppate a Tijane, a nord di Tit N’ali, e a ovest/est di Talharite, anche queste allineate con faglie NE-SW, E-W e NW-SE.
- L’indice del Quarzo (b11/(b10+b12)) ha mostrato allineamenti E-W nel cuore dell’inlier, proprio dove sul campo si trovano vene di quarzo con tracce di rame (malachite, calcopirite) e ferro.
La cosa più eccitante è stata sovrapporre queste mappe! Creando un’immagine composita a colori (RGB) usando i diversi indici di alterazione (es. Dolomite-clorite-epidoto in Rosso, Ferro in Verde, Quarzo in Blu), siamo riusciti a visualizzare le associazioni mineralogiche e la loro distribuzione spaziale. Ad esempio, le aree azzurre corrispondevano a zone note per rame-ferro, legate all’ossidazione ferrica e alle vene di quarzo nel basamento paleozoico. Le zone gialle corrispondevano a mineralizzazioni Pb-Zn note, associate a ossidi di ferro e carbonati (ma senza quarzo). Le aree viola indicavano silice e clorite, soprattutto nei basalti/gabbri triassici alterati. È stato come mettere insieme i pezzi di un puzzle geochimico visto dallo spazio!
La Prova sul Campo: Dalle Immagini alla Roccia
Ovviamente, il telerilevamento è uno strumento potentissimo, ma non basta guardare dall’alto. Bisogna mettere gli scarponi e andare a vedere di persona! Ho organizzato due missioni sul campo. La prima, di ricognizione, per familiarizzare con la geologia locale e raccogliere campioni delle rocce e delle mineralizzazioni visibili. Analisi macroscopiche in laboratorio ci hanno aiutato a caratterizzare i minerali presenti.

La seconda missione è avvenuta dopo aver elaborato le immagini satellitari e aver identificato le zone “calde”. L’obiettivo era validare le mappe tematiche: andare nei punti indicati come anomali dalle analisi satellitari e verificare se corrispondevano effettivamente a strutture geologiche significative o ad alterazioni idrotermali. E la corrispondenza è stata notevole! Abbiamo trovato vari tipi di vene (quarzo, calcite), gossan estesi, e zone di alterazione lungo le pareti delle vene con minerali argillosi e ossidi di ferro (limonite, goethite) – proprio i segnali che avevamo cercato con ASTER! Abbiamo anche osservato direttamente le mineralizzazioni principali: galena, pirite, calcopirite, e i loro prodotti di alterazione superficiale come cerussite, malachite, azurite, smithsonite (carbonato di zinco) associata a ossidi di ferro. Bingo! Le mappe ci avevano guidato bene.
Zone Calde: Identificare Nuove Aree Promettenti
Il bello viene ora: integrare tutto. Sovrapponendo la mappa di densità dei lineamenti, le mappe degli indici di alterazione (gossan, ferro, quarzo, dolomite-clorite-epidoto) e le posizioni delle mineralizzazioni note e osservate sul campo, abbiamo creato una “mappa del potenziale minerario”. Questa mappa evidenzia le aree dove la combinazione di intensa fratturazione (alta densità di lineamenti) e forte alterazione idrotermale è massima.
I risultati sono stati illuminanti:
- Le zone mineralizzate note si allineano perfettamente con le aree ad alta densità di lineamenti e con le anomalie di alterazione.
- Le vene mineralizzate seguono i principali corridoi di taglio (faglie) o sono oblique rispetto ad essi.
- Le aree più promettenti sono quelle caratterizzate da intensa fratturazione e presenza di minerali di alterazione come argille e ossidi di ferro. Le faglie hanno agito da condotti principali per i fluidi mineralizzanti.
Ma la cosa più importante è che questo approccio integrato ci ha permesso di identificare cinque nuove aree ad alto potenziale che non erano state sfruttate in precedenza o erano poco conosciute:
- A SW di Tamlahl
- Nella regione di Tijane (in particolare l’estensione orientale)
- A NE di Tit N’Ali
- A SW di Tit N’Ali (in particolare l’estensione SE delle vene già note)
- Nella parte SW dell’area di studio
Tre di queste aree sono già parzialmente confermate da attività minerarie passate o presenti, ma l’analisi suggerisce un potenziale ben maggiore e più esteso.
Guardando Avanti (e Ancora più Lontano)
Certo, il telerilevamento ha i suoi limiti: la risoluzione spaziale potrebbe non cogliere dettagli finissimi, e la copertura vegetale o le condizioni atmosferiche possono a volte “sporcare” il segnale. Ma i vantaggi, specialmente in aree come l’Atlante Orientale, sono enormi: rapidità, copertura vasta, costi ridotti rispetto all’esplorazione tradizionale a tappeto, e capacità di “vedere” l’invisibile (la chimica delle rocce).
Questo studio dimostra come l’integrazione di dati satellitari (Landsat 8 per le strutture, ASTER per le alterazioni), analisi GIS e validazione sul campo sia una strategia potentissima per l’esplorazione mineraria. Abbiamo non solo confermato il controllo strutturale sulla mineralizzazione a Mougueur, ma anche identificato nuove zone target concrete per future esplorazioni più approfondite (geofisica, geochimica, perforazioni).
Il prossimo passo? Magari usare dati iperspettrali (ancora più bande, ancora più dettaglio chimico!) e algoritmi di machine learning per analizzare queste enormi moli di dati in modo ancora più efficace. L’avventura della scoperta dei tesori nascosti della Terra, grazie agli occhi dallo spazio, è appena iniziata!
Fonte: Springer