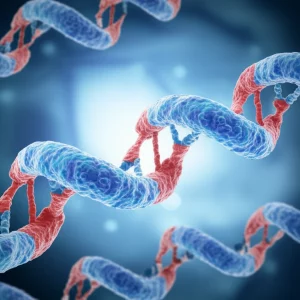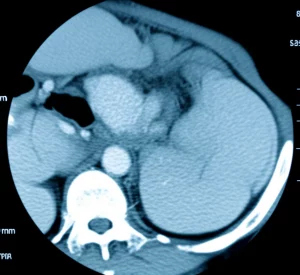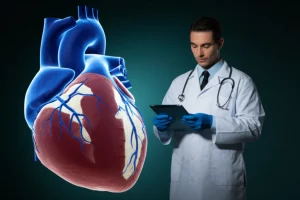Malattia di Fabry: Viaggio tra Progressi e Sfide nelle Cure
Ciao a tutti! Oggi voglio parlarvi di una condizione un po’ particolare, forse non molto conosciuta ma che ha un impatto profondo sulla vita di chi ne soffre: la Malattia di Fabry. È una malattia rara, ereditaria, legata al cromosoma X, che rientra nel gruppo delle malattie da accumulo lisosomiale. Cosa significa? In pratica, a causa di un’attività ridotta di un enzima chiamato alfa-galattosidasi A (AGAL), una sostanza chiamata globotriaosilceramide (Gb3) non viene smaltita correttamente e si accumula nelle cellule.
Questo accumulo non è affatto innocuo. Pensate che provoca una malattia che colpisce tanti sistemi del nostro corpo e, se non trattata, può ridurre l’aspettativa di vita di circa 10 anni nelle donne e ben 20 negli uomini. Le conseguenze più gravi? Insufficienza renale progressiva, cardiomiopatia ipertrofica, aritmie cardiache e infarti cerebrali precoci. Insomma, una bella gatta da pelare.
I campanelli d’allarme: riconoscere i sintomi
Come ci si accorge di avere la Malattia di Fabry? Spesso i primi segnali, i cosiddetti “red flags”, compaiono già durante l’infanzia. Parliamo di:
- Dolore neuropatico alle estremità (mani e piedi che bruciano, crisi di dolore intenso)
- Sintomi gastrointestinali (gonfiore, diarrea, dolori addominali)
- Problemi con la sudorazione (sudare troppo poco o troppo)
- Angiocheratomi (piccole macchie rosso-violacee sulla pelle, spesso raggruppate)
- Cornea verticillata (un aspetto particolare della cornea visibile all’esame oculistico)
Con il passare del tempo, se la malattia progredisce, possono comparire danni più seri a carico di reni (nefropatia di Fabry), cuore (cardiomiopatia) e cervello (ictus). È interessante notare che la gravità e il tipo di sintomi possono variare molto, specialmente nelle donne, a causa di un processo chiamato inattivazione casuale del cromosoma X. In generale, però, più si va avanti con l’età, più organi possono essere coinvolti e maggiore diventa il peso della malattia.

La gravità dipende molto dal tipo di mutazione genetica. Esistono forme “classiche”, con attività enzimatica quasi assente, sintomi precoci e gravi, e forme “a esordio tardivo” (late-onset), con un’attività enzimatica residua, sintomi che compaiono più tardi (verso i 30-40 anni) e spesso un coinvolgimento prevalentemente cardiaco.
Come si arriva alla diagnosi?
Il sospetto nasce dalla storia familiare o dalla presenza dei sintomi tipici. Per confermare la diagnosi:
- Negli uomini: si misura l’attività dell’enzima alfa-galattosidasi A nei globuli bianchi. Se è bassa, la diagnosi è confermata.
- Nelle donne: l’attività enzimatica può essere normale! Quindi è fondamentale l’analisi genetica per cercare una mutazione nel gene GLA.
L’analisi genetica è importante anche per gli uomini, perché aiuta a capire se una particolare terapia orale potrebbe funzionare. Un altro aiuto viene dal dosaggio di un biomarcatore, la globotriaosilsfingosina (lyso-Gb3), che è elevata nei pazienti e può dare un’idea del carico di malattia. A volte, una biopsia renale o cardiaca può mostrare al microscopio elettronico delle inclusioni caratteristiche chiamate “corpi zebra”, confermando ulteriormente la diagnosi.
Obiettivi della terapia e approccio personalizzato
Una volta diagnosticata la Malattia di Fabry, l’obiettivo è prendersi cura del paziente a 360 gradi, cercando di:
- Ridurre i sintomi (soprattutto il dolore)
- Rallentare o prevenire il peggioramento dei danni agli organi (reni, cuore, cervello)
- Migliorare la qualità della vita
- Normalizzare l’aspettativa di vita
L’inizio della terapia specifica per la Fabry si basa sul rischio individuale del paziente. È quella che chiamiamo medicina di precisione: adattare il trattamento alle caratteristiche di ciascuno. Ad esempio, gli uomini hanno generalmente un rischio maggiore di un decorso grave rispetto alle donne. Le attuali raccomandazioni suggeriscono di trattare gli uomini in modo profilattico (preventivo), mentre le donne solo se mostrano segni di danno d’organo. Questo approccio è un po’ dibattuto, specialmente per le donne con forme classiche, per le quali iniziare presto la terapia potrebbe essere vantaggioso prima che i danni diventino irreversibili. È chiaro che iniziare presto è cruciale, soprattutto negli uomini con forme classiche.
Le terapie attuali: TES e Chaperone
Dal 2001 abbiamo a disposizione la Terapia Enzimatica Sostitutiva (TES). L’idea è semplice: rimpiazzare l’enzima mancante o difettoso infondendo endovena ogni due settimane una versione ricombinante dell’alfa-galattosidasi A. Attualmente ci sono tre farmaci approvati:
- Agalsidase alfa (0.2 mg/kg di peso corporeo)
- Agalsidase beta (1.0 mg/kg di peso corporeo)
- Pegunigalsidase alfa (1.0 mg/kg di peso corporeo)
L’agalsidase alfa e beta sono disponibili da più tempo e la loro efficacia è ben documentata, soprattutto se iniziate precocemente: possono stabilizzare la funzione renale, ritardare l’insufficienza renale terminale, stabilizzare lo spessore delle pareti cardiache, ridurre l’ipertrofia ventricolare sinistra, alleviare il dolore neuropatico e i sintomi gastrointestinali, migliorare la sudorazione e la qualità della vita. È emerso che, specialmente nei bambini con danno renale, dosi più alte (come quelle dell’agalsidase beta) sembrano avere un effetto “pulizia” maggiore sulle cellule renali. Sono in sviluppo anche versioni biosimilari dell’agalsidase beta.

La Pegunigalsidase alfa è l’ultima arrivata. È una forma modificata dell’enzima (PEGilata) che dovrebbe rimanere in circolo più a lungo e causare meno reazioni immunitarie. Studi come il BALANCE (confronto con agalsidase beta), il BRIDGE (passaggio da agalsidase alfa) e il BRIGHT (studio su somministrazione mensile a dose doppia, non ancora approvata) ne hanno valutato l’efficacia e la sicurezza. Lo studio BALANCE ha mostrato una non-inferiorità rispetto ad agalsidase beta sulla funzione renale generale, anche se analizzando separatamente uomini e donne sono emerse alcune differenze, soprattutto nei maschi, con un calo della funzione renale leggermente più marcato e una riduzione minore del lyso-Gb3 plasmatico con pegunigalsidase alfa rispetto ad agalsidase beta. Serviranno altri studi per capire meglio queste differenze. Lo studio BRIGHT ha anche sollevato questioni sull’impatto degli anticorpi anti-farmaco (ADA) preesistenti sull’efficacia della pegunigalsidase alfa, specialmente a dosaggi più alti e intervalli più lunghi.
Dal 2016 esiste anche un’alternativa orale: la terapia chaperone con Migalastat. Questa non è per tutti, ma solo per i pazienti con mutazioni “suscettibili” (amenable). Come funziona? Il migalastat è una piccola molecola che si lega all’enzima alfa-galattosidasi A difettoso (ma ancora parzialmente funzionante) prodotto dal paziente, lo stabilizza, lo aiuta a raggiungere la sua destinazione (i lisosomi) e poi si stacca, permettendo all’enzima di fare il suo lavoro di smaltimento del Gb3. È una capsula da prendere a giorni alterni. Dati a lungo termine (fino a 8.6 anni) mostrano che può mantenere la funzione renale e ridurre gli eventi clinici associati alla Fabry. Ovviamente, il confronto diretto con la TES è complicato, perché i pazienti trattabili con migalastat hanno generalmente forme meno gravi della malattia (mutazioni missenso con attività residua) rispetto a quelli che necessitano di TES (spesso mutazioni nonsenso senza attività enzimatica).
Uno sguardo al futuro: le terapie in arrivo
La ricerca non si ferma! Ci sono diverse strade promettenti in fase di studio:
1. Terapia di Riduzione del Substrato (TRS): L’idea qui è diversa: invece di sostituire l’enzima, si cerca di ridurre la produzione del Gb3 agendo a monte. Farmaci come Lucerastat, Venglustat e AL01211 sono inibitori della glucosilceramide sintasi (GCS), un enzima chiave nella produzione di Gb3. Sono farmaci orali. Lucerastat, in uno studio di fase III (MODIFY), non ha raggiunto l’obiettivo primario sul dolore neuropatico ma ha ridotto significativamente il lyso-Gb3. Venglustat è in fase III (studi CARAT e PERIDOT) e AL01211 è in fase II.
2. Terapia Genica: Questa è forse la frontiera più affascinante. L’obiettivo è fornire alle cellule del paziente il codice genetico corretto per produrre l’enzima alfa-galattosidasi A funzionante. Si usano principalmente due tipi di “navette” (vettori) per consegnare il gene:
- Vettori lentivirali: Usati in approcci ex vivo (le cellule staminali del paziente vengono prelevate, modificate in laboratorio e reinfuse). L’esperienza con AVR-RD-01 (AvroBio) ha dato risultati iniziali promettenti ma variabili, e il programma è stato interrotto.
- Vettori adeno-associati (AAV): Usati per terapie in vivo, spesso mirando al fegato per trasformarlo in una “fabbrica” di enzima. Ci sono diversi programmi in corso:
- Isaralgagene civaparvovec (ST-920, Sangamo): È il più avanzato. Usa un vettore AAV2/6 che mira al fegato. I dati iniziali mostrano livelli di enzima molto alti e riduzione del lyso-Gb3, permettendo a molti pazienti di sospendere la TES.
- FLT190 (Freeline): Programma interrotto.
- 4D-310 (4D Molecular Therapeutics): Mira specificamente al cuore, ma lo studio è stato messo in pausa per eventi avversi (sindrome emolitico-uremica atipica), anche se recentemente l’FDA ha rimosso lo stop.
- AMT191 (UniQure): Usa un vettore AAV5, studio di fase I/II in corso.
La terapia genica con AAV pone sfide legate all’immunogenicità (reazioni immunitarie contro il vettore o la proteina prodotta) che richiedono attenzione e strategie di gestione.

3. Terapia con mRNA: Simile ai vaccini COVID, si potrebbero usare nanoparticelle lipidiche per consegnare l’mRNA che codifica per l’alfa-galattosidasi A. Studi preclinici su topi e primati non umani sono promettenti, mostrando alti livelli di enzima e riduzione del (lyso-)Gb3.
4. TES “potenziata” con vescicole: Si sta esplorando l’uso di “navette” come nanoliposomi o vescicole extracellulari naturali per trasportare l’enzima, migliorandone potenzialmente la stabilità, la distribuzione e l’assorbimento cellulare, forse anche nel cervello.
Le sfide: l’Immunogenicità della TES
Un aspetto cruciale, soprattutto con la TES, è la possibilità che il corpo riconosca l’enzima infuso come “estraneo” e sviluppi una risposta immunitaria. Questo può manifestarsi in due modi principali:
Reazioni Associate all’Infusione (IARs): Sono reazioni che avvengono durante o subito dopo l’infusione. Possono essere lievi (febbre, brividi, mal di testa, orticaria) o, più raramente, gravi (difficoltà respiratorie, ipotensione, anafilassi). Sono più comuni all’inizio della terapia, specialmente nei pazienti maschi che non producono affatto l’enzima (CRIM-negativi). Spesso non sono mediate da IgE (anafilattoidi) ma da altri meccanismi immunitari (attivazione del complemento, degranulazione dei mastociti). La gestione prevede premedicazione (antistaminici, corticosteroidi) e riduzione della velocità di infusione, ma a volte servono protocolli più complessi o farmaci specifici come l’omalizumab (anti-IgE).
Anticorpi Anti-Farmaco (ADAs) IgG: Circa il 40-70% dei pazienti maschi in TES sviluppa anticorpi IgG contro l’enzima infuso. Questi anticorpi possono essere “neutralizzanti”, cioè possono bloccare l’attività dell’enzima e ridurne l’efficacia terapeutica. Possono inibire l’enzima già nel sangue, impedirne l’ingresso nelle cellule o bloccarne l’attività all’interno dei lisosomi. Dosi più alte di TES sembrano in parte compensare questo effetto, ma la risposta è variabile.
Un’altra preoccupazione, anche se non ancora ben documentata nella Fabry con agalsidase alfa/beta, è che questi anticorpi formino complessi immuni con l’enzima che potrebbero depositarsi nei reni causando nefrite membranosa (come visto in altre malattie trattate con TES). Questo rischio potrebbe essere teoricamente maggiore con enzimi a lunga emivita come la pegunigalsidase alfa (un caso è stato riportato nello studio BALANCE).

La PEGiliazione stessa (usata per pegunigalsidase alfa) può indurre anticorpi specifici contro il PEG (polietilenglicole), una sostanza presente in molti farmaci, cosmetici e alimenti. Anche i vaccini mRNA anti-COVID possono indurre o aumentare questi anticorpi anti-PEG. L’impatto clinico di questi anticorpi sull’efficacia di pegunigalsidase alfa è ancora da chiarire.
Come si affronta l’immunogenicità? Si stanno studiando strategie come l’immunosoppressione (usata con successo in altre malattie lisosomiali, ma non specificamente studiata per la Fabry in questo contesto) o l’induzione della tolleranza orale (somministrare piccole dosi di enzima per via orale per “abituare” il sistema immunitario), ma siamo ancora nel campo della ricerca.
Altre sfide e terapie di supporto
Anche la terapia con Migalastat ha le sue complessità. Non tutte le mutazioni definite “amenable” in laboratorio rispondono bene clinicamente, e capire quale sia il livello minimo di attività enzimatica da raggiungere per avere un beneficio clinico è ancora oggetto di studio. Inoltre, misurare l’attività enzimatica nei pazienti in terapia con migalastat richiede attenzione: bisogna prelevare il sangue almeno 24 ore dopo l’assunzione del farmaco per evitare che il migalastat ancora in circolo interferisca con la misurazione.
Infine, non dimentichiamo le terapie sintomatiche e di supporto, fondamentali per gestire le complicanze:
- Per i reni: farmaci nefroprotettivi come gli ACE-inibitori o i sartani, associati a una dieta povera di sodio. Si sta valutando anche l’uso degli inibitori SGLT2.
- Per il dolore neuropatico: farmaci specifici come pregabalin, duloxetina, amitriptilina (con cautela per gli effetti cardiaci), o trattamenti topici (capsaicina, lidocaina).
In conclusione
La Malattia di Fabry è un quadro complesso, una sfida continua per pazienti e medici. Ma, come abbiamo visto, la ricerca ha fatto passi da gigante! Dalle prime terapie enzimatiche sostitutive alla terapia chaperone orale, fino alle frontiere entusiasmanti della terapia di riduzione del substrato, della terapia genica e dell’mRNA, il panorama terapeutico è in continua evoluzione. Certo, rimangono sfide importanti, come la gestione dell’immunogenicità o l’ottimizzazione delle terapie esistenti, ma la speranza è che questi progressi portino a una migliore qualità e aspettativa di vita per tutte le persone che convivono con la Malattia di Fabry. È un viaggio affascinante e pieno di speranza quello della ricerca in questo campo!
Fonte: Springer