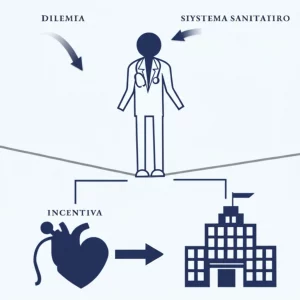Perdono in Sanità: 10 Motivi Per Cui Potrebbe Non Essere la Risposta Giusta
Parliamoci chiaro, il perdono è una cosa potente. Spesso lo vediamo come una virtù, un dovere morale, quasi una tappa obbligata per guarire e andare avanti, specialmente quando qualcuno ci fa un torto. E nel mondo della sanità? Beh, lì la faccenda si complica parecchio. Immaginate un errore medico, magari grave. Le linee guida, le commissioni, persino la cultura professionale spingono medici e infermieri a rivelare l’errore, a chiedere scusa. E noi pazienti? A volte sentiamo quasi una pressione implicita a perdonare, come se fosse la cosa “giusta” da fare.
Ma è sempre così? Davvero il perdono è la panacea per tutti i mali, anche in corsia? Recentemente mi sono imbattuto in una riflessione affascinante che mette in discussione questa idea, esplorando i limiti del perdono in ambito sanitario. E devo dire che mi ha aperto gli occhi. Perché sì, perdonare può liberare, può aiutare a chiudere un capitolo doloroso. Ma ci sono situazioni in cui forzare o concedere il perdono potrebbe addirittura peggiorare le cose, aggiungere trauma al trauma.
L’idea di fondo è che il perdono non è un interruttore da accendere o spegnere a comando. È un processo intimo, personale, che qui definiamo come la scelta consapevole di sostituire i sentimenti negativi verso chi ci ha fatto del male con emozioni neutre o positive. Ma questa scelta non è sempre libera, né sempre appropriata. Esistono dei confini, dei limiti ben precisi che dovremmo imparare a riconoscere. Ne sono stati identificati 10, raggruppati in quattro categorie principali, e credo valga la pena esplorarli insieme.
Limiti Concettuali: Quando il Perdono Non Ha Proprio Senso
Partiamo dalle basi, dalle fondamenta filosofiche. A volte, semplicemente, il perdono non è richiesto o non è possibile.
- Non tutto il male richiede perdono: Pensiamo a un danno avvenuto senza intenzione o negligenza. Certo, un medico può commettere un errore tecnico, come nel tragico caso ipotetico di Sarah, morta per un’appendicectomia di routine andata male a causa di problemi sistemici (personale insufficiente, software difettoso). Il chirurgo ha sbagliato, sì, ma era sfinito, forse troppo dipendente dalla tecnologia imposta. C’è colpa morale che *richiede* perdono? Forse no. Il chirurgo dovrebbe esprimere rammarico per il dolore della famiglia, certo, ma parlare di perdono per l’errore tecnico potrebbe essere fuori luogo. A volte, poi, un disagio apparente è giustificato da uno scopo più alto (un whistleblower che denuncia pratiche scorrette) o è frutto di sensibilità personali, non di un vero torto. E che dire delle scuse “di cortesia” per inezie, che svuotano di significato l’atto stesso del chiedere scusa?
- Il male radicale, oltre il perdono umano: Ci sono atti talmente atroci, “radicalmente malvagi”, che superano la capacità umana di perdonare. Pensiamo agli esperimenti disumani di Mengele ad Auschwitz o agli omicidi seriali di pazienti commessi da Shipman. Sono tradimenti così profondi della fiducia e della sacralità della vita che il perdono sembra non solo impossibile, ma quasi irrispettoso verso le vittime e verso noi stessi. Anche gravi negligenze sistemiche, come quelle che hanno alimentato la crisi degli oppioidi, mettendo il profitto davanti alla salute pubblica, sollevano la questione: è possibile perdonare quando manca una vera assunzione di responsabilità per sofferenze immani?
- Incompatibilità tra biasimo e perdono: Se biasimare qualcuno per un’azione sbagliata è ragionevole e giustificato, ha senso perdonarlo? Alcuni filosofi, come Kekes, sostengono di no. Il biasimo sottolinea la responsabilità e la gravità del torto; il perdono, in un certo senso, lo “rilascia”. Sembrano due risposte incompatibili. Certo, si può obiettare che si perdona la persona, non l’atto, separando i due piani. Ma il rischio è che il perdono annacqui la gravità morale del gesto, soprattutto se il biasimo è meritato. È un bel dilemma, no? Forse, come suggerisce Weil, cercare un equilibrio perfetto tramite il perdono è un desiderio irrealizzabile, quasi un voler negare la nostra fallibilità umana.

Limiti Morali ed Etici: Tra Responsabilità e Redenzione
Andiamo avanti. Anche quando il perdono sembra concettualmente possibile, possono sorgere ostacoli morali ed etici.
- La tensione tra responsabilità (accountability) e perdono: Qui la faccenda si complica. In sanità, la responsabilità è fondamentale per mantenere standard elevati, fare giustizia e migliorare il sistema. Ma come si concilia con il perdono? L’esempio della Commissione per la Verità e la Riconciliazione in Sudafrica post-apartheid è illuminante: focalizzandosi molto sulla riconciliazione, ha rischiato di indebolire la ricerca di responsabilità concrete. Allo stesso modo, in ospedale, una pressione prematura a perdonare (magari prima che siano state accertate le responsabilità individuali e istituzionali e prese misure correttive, come nel caso di Sarah) rischia di minare la giustizia e la sicurezza. Il perdono non può diventare una scorciatoia per evitare le conseguenze.
- L’ostacolo dell’assolutismo morale: Viviamo in tempi di “nuovo puritanesimo”, a volte. Si tracciano linee nette tra giusto e sbagliato, spesso senza sfumature. La “cancel culture” ne è un esempio: si chiede conto ai “colpevoli” con standard morali rigidi, rendendo il perdono difficile, quasi un tradimento della vittima. Questo può portare a una giusta richiesta di responsabilità, ma rischia anche di soffocare il dialogo, la crescita personale e la possibilità di redenzione. Nel caso di Sarah, un approccio assolutista potrebbe focalizzarsi solo sull’errore del chirurgo, ignorando i problemi sistemici che lo hanno favorito, e demonizzandolo senza possibilità di appello. Questo clima può spingere altri medici a nascondere gli errori per paura.
- I limiti del perdono “per procura”: Posso perdonare io al posto di un altro? Secondo molte tradizioni etiche e religiose, no. Il perdono è un atto profondamente personale, legato al danno subito direttamente. Solo la vittima (o, in alcune visioni, Dio) ha l’autorità morale per concederlo. Quando un’istituzione o una terza parte chiede scusa o perdona “per conto di”, come nel caso delle scuse federali per lo studio sulla sifilide di Tuskegee, si compie un atto simbolico importante, ma che può suonare falso o irrispettoso per le vittime dirette, specialmente se non ci sono più (come Sarah). Potrebbe banalizzare la loro sofferenza o imporre una riconciliazione non sentita. E se la vittima preferisse la giustizia, o persino un sano sentimento di rabbia (che a breve termine può essere utile per fissare confini), anziché il perdono?

Limiti Relazionali e Sociali: Pressioni e Sistemi
Il contesto sociale e le dinamiche relazionali giocano un ruolo enorme.
- Riconciliazione forzata o sotto pressione: Chiedere perdono è una cosa, pretenderlo è un’altra. Quando un’istituzione o un medico fa pressione, più o meno velata, affinché il paziente perdoni, si trasforma un atto volontario in una forma di coercizione. Spesso lo si fa per “gestire” la situazione, proteggere l’immagine, evitare conseguenze legali, più che per il bene della vittima. Questo mette un fardello enorme su chi ha già sofferto, mancando di rispetto alla sua autonomia e rischiando di farlo sentire in colpa se non perdona. Pensiamo ai pazienti che dipendono da cure continue: potrebbero sentirsi costretti a perdonare per non compromettere il rapporto con chi li cura, data l’asimmetria di potere intrinseca nella relazione medico-paziente.
- Negligenza sistemica e responsabilità diffusa: E se la colpa non è *solo* del chirurgo, ma di un intero sistema che non funziona? Errori medici gravi spesso hanno radici profonde: carenza di personale, turni massacranti, protocolli inadeguati, comunicazione fallace, tecnologia difettosa (come nel caso di Sarah). In questi casi, individuare un singolo “colpevole” da perdonare diventa difficile, quasi fuorviante. La responsabilità è diffusa, quasi diluita. Come si può perdonare un’istituzione, che non ha una coscienza morale individuale? I meccanismi legali esistono (responsabilità vicaria, illecito civile), ma non colgono la complessità morale. Perdonare l’individuo in prima linea potrebbe sembrare ingiusto o inutile se il sistema che ha permesso l’errore rimane invariato. Anzi, potrebbe quasi scusare le falle istituzionali.

Limiti Temporali e di Processo: Il Tempo della Guarigione
Infine, non possiamo ignorare il fattore tempo e il processo individuale di elaborazione.
- Danno persistente o non affrontato: Come fai a perdonare se il problema persiste, se chi ha sbagliato non mostra rimorso genuino, non si scusa sinceramente o non si impegna a cambiare? La mancanza di ammissione di colpa, a volte legata alla paura di conseguenze legali (nonostante leggi che proteggono le scuse) o a una cultura di auto-protezione, è un ostacolo enorme. Se il danno continua (pensiamo a pregiudizi radicati come lo stigma sul peso o il bias razziale nella gestione del dolore) o non viene affrontato seriamente, non perdonare diventa un atto di auto-protezione. Chiedere perdono in queste circostanze può sembrare un modo per normalizzare comportamenti inaccettabili o deviare dalla responsabilità sistemica.
- Traiettorie di guarigione individuali: Ognuno ha i suoi tempi. La guarigione da un trauma, fisico o emotivo, non è una gara né un percorso lineare. È un processo unico, che dipende dalla persona, dalla sua resilienza, dalla sua vulnerabilità. Pretendere o sollecitare il perdono prima che una persona sia pronta è ingiusto e potenzialmente dannoso. Può riaprire ferite, invalidare emozioni autentiche (come rabbia, dolore, sfiducia), e far sentire la vittima ancora più sola e incompresa. A volte c’è bisogno di tempo per elaborare, per ricostruire un senso di sicurezza, per capire cosa è successo. C’è anche la “fatica del perdono”: perdonare ripetutamente, magari in un contesto di danno continuo, può esaurire le risorse psicologiche. Il perdono non si può forzare; deve emergere, se emerge, in modo organico.

Allora, cosa ci portiamo a casa da questa riflessione? Che il perdono in sanità è una questione delicata, molto più complessa di quanto sembri. Riconoscere questi 10 limiti non significa sminuire il valore del perdono quando è autentico e appropriato. Significa piuttosto capire che non è sempre la risposta, e a volte insistere su di esso può fare più male che bene.
Per noi pazienti, significa sentirci legittimati a non perdonare se non ce la sentiamo, se le condizioni non lo permettono, se abbiamo bisogno di altro (giustizia, responsabilità, cambiamento). Per i professionisti sanitari e le istituzioni, significa adottare un approccio più empatico e centrato sulla persona: chiedere scusa sinceramente quando serve, assumersi le responsabilità (individuali e sistemiche), impegnarsi a prevenire errori futuri, ma senza aspettarsi o pretendere il perdono in cambio. L’obiettivo primario dovrebbe essere sempre la guarigione – della vittima, ma anche del professionista coinvolto – e creare un ambiente di fiducia e sicurezza. E la guarigione può avvenire, eccome, anche senza che la parola “perdono” venga mai pronunciata.
Alla fine, quello che conta davvero è creare uno spazio in cui la sofferenza sia riconosciuta, supportata, e in cui si possa lavorare insieme per ricostruire fiducia e migliorare le cure, rispettando i tempi e i percorsi di ognuno. Un sistema sanitario più giusto e compassionevole passa anche da qui: dalla capacità di gestire gli errori e i torti con onestà, responsabilità e un profondo rispetto per i confini del perdono.
Fonte: Springer